

L’opera nasce dall’occasione di una ristrutturazione di una residenza estiva costruita a metà degli anni Sessanta, adagiata su una duna di sabbia e circondata da pini marittimi. L’intervento delinea una duplice prospettiva: da un lato la necessità di individuare una sintesi tra la natura dell’edificio – seppur ancora da scoprire – e i valori morfologici e cromatici del luogo in cui esso è insediato; dall’altro la volontà di collocare il carattere degli ambienti interni nel solco di una tradizione che fa del comfort, della domesticità, dell’appropriatezza la propria cifra identificativa. Tutto ciò si applica soprattutto nella modulazione della luce e delle vedute, nel- la misura e conformazione degli spazi, nella discrezione dei materiali. Una ideale direttrice longitudinale, che attraversa l’intera costruzione, permette di trovare una convergenza tra due aspetti operativi significativi: in primo luogo la ridefinizione della spazialità interna, che si concretizza in una sequenza di stanze passanti in stretto rapporto tra loro e con il paesaggio circostante; in secondo luogo l’identificazione del carattere dell’edificio in una nuova morfologia, allo stesso tempo naturale e archetipica, che trova nel sedimento orizzontale la cifra costitutiva.
… fra cielo e mare … ‘… sospesa tra cielo e mare …‘ è la definizione utilizzata dai Committenti per ritrarre la loro nuova casa al Monte Argentario, all’avvio di una bella avventura di progetto condotta con l’obiettivo di riverberare i sapori del paesaggio circostante all’interno dell’abitazione. Un progetto rispettoso dell’organismo edilizio esistente, ispirato ai lavori del grande maestro Giò Ponti, integra le belle pavimentazioni in cotto esistenti con un ampio utilizzo della ceramica dipinta a mano nel vietrese (memoria delle origini napoletane dei Committenti), a rivestire in maniera diffusa i bagni, la cucina e a disegnare un particolare tappeto ceramico a parete nel soggiorno. Un asola orizzontale mette in comunicazione diretta questo con la cucina, permettendo così a questo locale di godere del panorama che si apprezza dall’ampia finestra anche grazie all’installazione a parete di una sorta di grande specchio retrovisore. Le varianti formali e cromatiche che caratterizzano i rivestimenti ceramici ispirano i motivi geometrici che disegnano un po’ tutta la casa frazionando pareti e soffitti secondo triangoli, rombi, rettangoli, semicerchi, sorta di installazione artistica che trova proprio nel corridoio, il locale solitamente di semplice transito, il momento più alto. Arredi e complementi in legno di noce canaletto completano l’ambientazione, interprete di quei valori artigianali tutti italiani di cui la casa oggi va molto fiera.
Casa TLI è un’unità abitativa di piccole dimensioni che fa parte di un blocco di appartamenti risalente ai primi anni settanta del secolo scorso e di conseguenza, l’involucro non avrebbe potuto essere modificato. Lo sforzo maggiore dunque è stato dedicato alla creazione di spazi dinamici all’interno di un contenitore rigido che potessero soddisfare le esigenze di un gruppo familiare di quattro persone stimolando nel contempo, uno stile di vita improntato alla libertà e alla naturalezza d’uso degli ambienti. In altre parole, la volontà di creare uno spazio domestico creativo, a dispetto anche delle dimensioni molto limitate, ha indotto ad evitare quanto più possibile le partizioni cieche che ne avrebbero ridotto il “respiro”; la necessaria definizione funzionale, è stata ottenuta articolando le superfici orizzontali le cui forme scultoree sono enfatizzate da tagli ed asole illuminate da strisce di luce che creano scenari diversi. Gli spazi di connessione e l’ampio soggiorno sono stati trattati in modo da renderli il più possibile multifunzionali con aree specializzate contenute e ampie porte scorrevoli che, a seconda delle necessità, funzionano come pareti divisorie a scomparsa modificando sensibilmente l’ambiente.
Se è vero che nella società contemporanea la città rappresenta il centro di attrazione per eccellenza – l’invenzione più importante nella storia dell’uomo – e se è vero che il concetto stesso di civitas esprime al meglio l’utilizzo condiviso dello spazio urbano, è altrettanto vero che questa condivisione si esprime al meglio in tutti quei luoghi che, pubblici o privati, auspicano tale socialità e la sostengono creando le ideali scenografie all’interno delle quali gli uomini vivono le proprie esperienze. Il “Decumanus caffè” nasce dal presupposto culturale di trarre ispirazione dall’origine più antica della nostra città, quella Firenze romana ancora oggi evidente nei segni generatori della sua più intima struttura urbana.Partendo da questa premessa il progetto ne interiorizza i contenuti grafici e li sovrappone simbolicamente ad una “città universale” ricca di trame infinite, dure, moderne, drammaticamente tese alla ricerca dell’origine stessa della metropoli contemporanea e concettualmente collegate alle griglie ortogonali delle città ellenistiche, autentiche generatrici della città occidentale. Tali fondamenti hanno portato il progetto ad incoraggiare la ricerca di una spazialità interna volta a privilegiare, con i lunghi tavoli comuni e nell’intimità del giardino chiuso, le funzioni aggregative tipiche delle tabernae. Di forte impatto è l’utilizzo delle grandi lastre in pietra serena che, da banchi di fresa nelle cave di Firenzuola, assurgono ad elemento scenografico.
Il fabbricato che ospita la filiale e sede legale della Banca di Pisa e Fornacette si trova nel centro di Pisa, in via Lungarno Pacinotti, vicino al Ponte di Mezzo. Il progetto interessa alcuni locali del piano terra e del piano primo di un edificio storico e si articola su una superficie complessiva di circa 650 mq. Il piano terra ospita la hall di ingresso, il salone con le casse ed il caveau. Attraverso l’ingresso si entra in uno spazio a doppia altezza, attraversato da due ponti colorati, al cui interno si sviluppa una comoda scala in legno di teak, che sale al piano superiore. Il piano primo, con una superficie di circa 500 mq, ospita gli uffici della direzione, la segreteria, la sala riunioni, la sala per conferenze, archivi e locali tecnici, uniti tra loro da una “catena”di corridoi, slarghi e spazi di attesa. L’intervento di restauro ha lasciato invariata la distribuzione dei locali e la loro dimensione, prevedendo un’opera di consolidamento delle strutture e il ridisegno dei percorsi di distribuzione. All’esterno l’edificio mantiene un aspetto omogeneo e si integra con il resto dei prospetti affacciati sul fiume. All’interno il progetto ammicca ai decori tradizionali delle mattonelle in graniglia degli anni ’50, ingigantiti attraverso la lente della rivisitazione pop. Così dove il pavimento prende colore gli arredi si fanno più tenui, al contrario nelle stanze in cui il rivestimento è bianco e nero gli armadi, i tavoli e le sedie si accendono con i colori intensi.
E’ emersa fin da subito la volontà di lasciare la torre “nuda”, spoglia di tutto ciò che non è sé stessa. La filosofia dell’intervento si è quindi basata sulle parole chiave “rispetto” ed “essenzialità”, puntando sull’ascolto, azione necessaria ad entrare in empatia con l’oggetto e percepirne i bisogni. «Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di “levare” più che di “mettere”, nel rigoroso rispetto dei materiali originari, un gioco di rimandi di forme e colori tra odierno e antico». Ogni piano è dotato di un solo elemento poggiato free standing, oggetto dichiaratamente funzionale che non cerca di confondersi con la torre ma che permette la sola dotazione minima per la sopravvivenza, disegnato come evoluzione e deformazione del “cassone” medioevale. Viene così liberata la torre di tutto ciò che è superfluo, architettonicamente e spiritualmente. La scelta dei materiali degli elementi d’arredo si riduce all’essenza ed alla funzionalità: al metallo brunito, scuro, severo, di cui si vestono tutti gli oggetti esteriormente, si contrappone l’acciaio, a rifinire tutte le superfici interne di lavoro. Tale binomio si intravede solo in alcuni dettagli che dichiarano la presenza dell’acciaio interno, sottolineando la fisionomia appena accennata del cassone “archetipo”. Gambe e maniglie vengono ripulite sino all’essenza ultima. Il cassone, oggetto utilizzato da sempre come letto, tavolo, seduta, contenitore, riprende vita, tornando nel luogo a lui più congeniale.
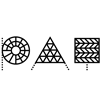
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix