

L’intervento ha previsto la realizzazione di 8 villini trifamiliari isolati, situati lungo il crinale affacciato su una vallata di una zona a sud-est di Siena di particolare rilievo sia paesaggistico che storico, in prossimità delle mura, vicino ad una porta d’accesso alla città, Porta Pispini. La conformazione della città storica e delle appendici di più recente edificazione, è legata sicuramente alle caratteristiche territoriali; i tre crinali su cui si adagia Siena hanno determinato uno sviluppo urbanistico, in cui ampie zone verdi si insinuano con estrema armonia nel tessuto edificato. Questa particolarità si riscontra sia all’interno delle mura che all’esterno, dove l’edificazione si è concentrata lungo le strade principali d’ ingresso alle porte, quindi lungo i crinali, nel tentativo di tutelare sempre le vallate verdi che si sviluppano tra un crinale e l’altro e che creano un legame indissolubile tra città e campagna. Nell’intento di contenere il terreno, di “ridisegnare” questa parte di territorio senese, all’interno dei lotti, le diverse zone pavimentate ed a verde, hanno modificato l’area con una serie di scatti di quota trattati anch’essi a verde; l’effetto d’insieme è uno spazio dove zone verdi e costruite si fondono piacevolmente . Gli 8 edifici pur presentando differenze planivolumetriche generate dall’andamento altimetrico del terreno, mantengono un’uniformità di linguaggio architettonico evidenziato dalle finestre a nastro e dai bowindows di valle.
Il progetto per restauro e adeguamento in oggetto conserva le caratteristiche storiche ed architettoniche dell’edificio vincolato di origine quattrocentesca e lo adegua alle funzioni preesistenti attraverso interventi contemporanei, puntuali, coordinati e leggeri che, pur mantenendo la propria individualità e riconoscibilità, ben si integrano con le preesistenze storiche. Questi interventi di natura più progettuale sono accompagnati da un intervento generale di restauro conservativo dei vari ambienti interni interessati e dei paramenti esterni, in parte in laterizio, e della terrazza, al primo piano, caratterizzata da un pavimento in pietra con botole, anch’esse in pietra, utilizzate in passato per riempire il granaio che era posto al piano terra. L’intervento mantiene le volumetrie attuali, elimina le superfetazioni e riorganizza i percorsi funzionali e distributivi. Al piano primo e secondo rimane ubicata la biblioteca che è collegata al piano terra dalla scala esterna esistente e da un nuovo ascensore per consentire l’accesso anche ai disabili senza intervenire in modo invasivo sul fabbricato. Un ulteriore ascensore esterno è previsto vicino alla terrazza e rifinito con un rivestimento esterno di lamiera in corten incisa da parole dedicate ai Cavalieri del Tau, la via Francigena e la Biblioteca. Al piano terra è previsto un adeguamento di tipo strutturale per realizzare la soprastante biblioteca e conservare i reperti archeologici ritrovati durante i lavori di restauro.
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area dove sono collocati una coppia di blocchi di loculi a fila verticale tra due manufatti esistenti nell’ultimo ordine del Cimitero Monumentale di Arezzo, in prossimità del bastione della Fortezza Medicea. Il progetto ha riguardato la trasformazione dell’attuale spazio in una cappella funeraria chiusa ad uso privato, nel riaspetto dei caratteri del sito e di tutela paesaggistica delle presenze storiche esistenti. La scelta progettuale è stata quella di realizzare una cappella con caratteri di leggerezza e trasparenza in modo tale da non alterare i rapporti morfologici e le finiture dei manufatti esistenti mediante uno spazio chiuso e utilizzo di componenti opachi; inoltre, mantenere libere le visuali lungo i percorsi interni che guardano la fortezza. Le dimensioni dell’area sono: larghezza 3.40 ml, lunghezza 2.65 ml, altezza 4.60 ml. Il sistema costruttivo utilizzato è costituito da un telaio metallico in acciaio inox satinato e vetro strutturale. Anche le griglie laterali svolgono funzioni strutturali per consentire di avere lastre sottili.
L’area oggetto di intervento fa parte del bacino del Lago di Massacciuccoli; fino agli anni ’40 del ‘900 trovavamo le coltivazioni di riso, poi dagli anni ’60 la coltura di Fior di Loto oggi una delle più vaste d’Europa. Il sito era in stato di degrado e di abbandono. Il percorso ciclopedonale “Fior di Loto” riporta alla luce un vero e proprio “gioiello ambientale”; si estende per 1 km ed è parte del sistema dei percorsi territoriali dedicati a luoghi della vita di G. Puccini. Il progetto si inserisce nel contesto ambientale interpretandone materiali e forme, rispondendo alle complesse esigenze tecnico-idrauliche dell’area e all’esigenza di un armonico inserimento paesaggistico. Un palcoscenico ambientale dove natura, coltivazione e infrastruttura instaurano un nuovo ed equilibrato dialogo. I vincoli idraulici sono risolti con tratti in rilevato e un pontile ligneo di 150 m, ciò determina variazioni della velocità di percorrenza, delle percezioni prospettiche e differenti sonorità. Il pontile è in lamellare e massello di abete rosso su pali in acciaio. Il progetto è ad impatto ambientale “zero”, i materiali sono naturali, permeabili e senza agenti chimici. I filari di pioppi cipressini creano zone ombreggiate e le sequenze lineari di essenze arbustive danno vita a un confine osmotico fra natura selvatica e costruzione. Un’architettura naturalizzata dove la “natura costruita” si ibrida con la “natura naturale”: sottili linee cromatiche, cangianti al variare delle stagioni.
Il fabbricato posto a Pisa in via Gioberti 39 è un edificio con pianta irregolare, di due piani fuori terra ed un piano interrato, destinato a biblioteca, uffici ed altri spazi polivalenti con un ampio giardino esterno ed una Piazza pubblica antistante. L’edificio è caratterizzato da un involucro trasparente articolato intorno ai due blocchi scala e servizi. La trasparenza delle pareti vetrate è stata concepita nel rispetto del grande valore delle mura urbane poste dietro l’edificio e che così possono essere viste dalla via pubblica. La struttura è di tipo reticolare a ponte con funzione di sostegno dell’involucro trasparente che rende possibile una flessibilità totale dello spazio. La zona centrale dell’atrio al piano terra risulta libera da pilastri in quanto gli orizzontamenti sono sostenuti da tre travate reticolari tipo Warren di altezza pari all’interpiano tra piano primo e copertura. Gli elementi rigidi sono costituiti dai due corpi scala in c.a. La parete vetrata esterna è ancorata attraverso montanti ai solai. Il volume dell’auditorium al piano primo è l’elemento che concilia massa e leggerezza di forma a parallelepipedo appeso e rivestito in legno. Questa “scatola volante” può essere osservata dalla sala polifunzionale posta al piano terra. Il piano seminterrato assume la valenza di piastra distributiva di servizi, canalizzazioni e reti tecniche che attraverso i cavedi dipartono da questo livello rendendo facilmente manutenibile e gestibile l’intero complesso.
Si trattava di intervenire con attenzione sovrapponendo segni nuovi a quelli esistenti, frutto di una pratica agricola e architettonica basata sul rispetto del paesaggio. L’impianto generale si affida ad una serie di muri di sostegno rivestiti in pietra, che rendono il profilo del terreno più razionale e adatto ad accogliere i volumi compatti delle abitazioni. Tre blocchi stereometrici si appoggiano, o meglio si intersecano con i muri di sostegno, e affondano le ‘radici’ nel terreno, assumendo la tettonica quale valore fondante del progetto. Il rapporto tra geometria e materia, che accompagna tutta la storia dell’architettura di questa regione, finisce qui, per assumere il ruolo di paradigma. I prospetti hanno poche aperture, di forma e dimensione variabile, disposte secondo un’apparente casualità che rimanda al disegno spontaneo dell’architettura rurale esistente. Il rivestimento in lastre di travertino a ricorsi variabili esalta il principio di sedimentazione e stratificazione litica. Un piccolo scavo, sottrazione materica, realizza in ogni abitazione una piccola corte centrale attorno alla quale si struttura in orizzontale e in verticale lo spazio della casa. La narrazione del progetto propone quale atto conclusivo la negazione consapevole della consueta copertura a falde, qui sostituita da una terrazza belvedere, segnando un tratto di discontinuità con la pratica costruttiva e compositiva tradizionale: essa è luogo privilegiato da cui tornare ad osservare il paesaggio.
Il progetto di recupero e trasformazione di un dismesso fabbricato artigianale disvela la primitiva morfologia di abbandonati edifici produttivi, reinterpretandone l’arcaicità della forma e l’unicità dello spazio interno. La conversione, di ciò che ieri era luogo di produzione familiare in nuovo territorio per l’abitare, garantisce il permanere di quei rapporti di convivialità spaziale tra l’ex annesso lavorativo e l’adiacente abitazione principale. Il volume monolitico esistente si evolve in una piccola casa per una giovane coppia generando nuove connessioni, spaziali visive e materiche, tra interno ed esterno, tra il territorio della casa e gli altri territori: il giardino, la strada, il luogo. Il collegamento tra l’edificio ed il giardino è articolato nella continuità d’uso del pavimento in cemento gettato in opera, un nuovo suolo in forma di aia o seduta. Lo sviluppo cromatico dei prospetti è trattato con un profondo bruno, intonaco in pasta per le facciate, elementi in laterizio per la copertura. Finestre-cornice come nicchie lignee creano una soglia abitata, mentre il portico d’ingresso in forma di vuoto protetto diviene loggia-soggiorno. All’interno un nuovo paesaggio si dipana nella successione di piani sequenza, un’enfilade prospettica di scorci per l’abitare articolata in piccoli universi dalle singole specificità. La luce, filtrata da elementi frangisole lignei, penetra nella profondità di tale scenario fino a cadere dall’alto a narrare paesaggi altri.
Situato nel centro storico di Pistoia, vicino al vecchio Ospedale del Ceppo, il Giardino Volante nasce dall’evocazione della memoria genetica urbana dei vuoti naturali interni al costruito, a cui si immagina di sovrapporre il disegno di una trama vegetale, nel tentativo di indagare i simboli caratterizzanti della città. Una sinuosa architettura verde contenuta da un nastro continuo in cemento trasforma le zone di soglia da recinto a percorso, a seduta, fino a divenire piccole architetture per i bambini. All’interno la trama dei percorsi, simulando le nervature linfatiche di una foglia, genera zolle di prato che accolgono le sculture-gioco realizzate dagli artisti, Luigi Mainolfi, Atelier Mendini, Gianni Ruffi, le quali legandosi alla maestosa vegetazione arborea esistente, ricercano una suggestiva relazione tra il lavoro dell’uomo e la seduzione incantata del paesaggio. Il giardino diviene allora un frammento in grado di proiettarsi verso altre aree, nel tentativo di creare una ricucitura urbana dentro un più ampio disegno di riqualificazione attraverso la spinta dell’arte e della natura, nella convinzione che l’architettura all’interno dei tessuti esistenti divenga un innesto in grado di generare nuovi fermenti nel paesaggio e successivi livelli di interazione con il luogo. Una grande platea lineare avvolge molteplici palcoscenici, dove un’architettura nel paesaggio diviene sfondo alle passioni dell’arte, del gioco, della natura.
Il nuovo complesso si colloca sul fondovalle del fiume Pesa che solca il paesaggio collinare. È articolato in due parti: il capannone e il fabbricato uffici e servizi. Il capannone dei reparti produttivi (un rettangolo di 300×100 metri) è parzialmente incassato nel pendio e ha la copertura metallica color ocra, ritmata dagli shed. Le facciate del capannone, percorse da una striscia finestrata, sono marrone scuro. Tre torri, realizzate con elementi prefabbricati, sporgono dalla lunga facciata verso valle e contengono gli impianti tecnici dell’area produttiva. I colori ocra (del tetto) e marrone (delle facciate) riprendono quelli della terra dei campi circostanti. Il fabbricato uffici e servizi è collocato sulla testata nord del capannone, è di tre piani fuori oltre a un piano interrato per i locali tecnici e gli spogliatoi. Il fabbricato è caratterizzato dalla facciata vetrata curvilinea con un andamento sinuoso che varia ai diversi piani. La facciata è segnata dai nastri in alluminio naturale del marcapiano. Il nastro, in corrispondenza del primo piano, aggetta dalla facciata a formare una gronda curvilinea che segnala l’ingresso e l’innesto del volume murario sporgente della mensa (dove si riprende il colore marrone scuro delle pareti del capannone).
I 22 alloggi, facenti parte del 3° programma comunale P.E.E.P., si trovano in località Tavola nella parte sud-ovest del Comune di Prato, territorio ancora caratterizzato da ampie aree coltivate. Gli alloggi, distribuiti su due edifici, completano un lotto già parzialmente edificato, dove, ad un “muro argine” pubblico, sono affiancate a pettine varie stecche di abitazione per un totale di 72 unità. In questa logica di completamento i due edifici ricavano al centro un’area di verde pubblico a servizio di tutto l’insediamento. Il piano terra a pilotis è dovuto al rischio idraulico rappresentato dal vicino fiume Ombrone, ed ha ricreato un fronte strada al piano primo dove, diramando dal “muro argine”, sulla stecca più lunga (A) vengono disposti 16 alloggi duplex da 70 mq e sulla più piccola (B) 6 simplex da 45 mq. I fronti degli edifici sono in muratura a facciavista eseguita con mattone comune tinteggiato di bianco, compresi i frangisole delle logge di ciascun appartamento. Fanno eccezione i fronti arretrati lungo i ballatoi e i fronti interni alle logge, più protetti e interpretati quali elementi dotati di una maggiore domesticità e per questo intonacati e colorati. Marcapiani, elementi strutturali, vano ascensore e scale esterne sono in c.a. a facciavista, gradini e piani di calpestio delle scale in lamiera zincata antisdrucciolo. Il manto di copertura, a compluvio interno, è anch’esso in lamiera metallica.
Il Casale “Casiscala” è un gioiello incastonato fra le verdi colline di Castelfalfi, nel cuore della Toscana tra Firenze e Siena, immerso in un incontaminato paesaggio di riserva di caccia. Il Casale, con una superficie di 310 mq e circondato da circa 3.500 mq di verde privato, trovato in stato di abbandono e pressoché diruto, è stato oggetto di un’attenta opera di restauro dal 2013 al 2016 attraverso il quale è tornato al suo antico splendore come Villa indipendente, dimora esclusiva dotata di tutti i comfort moderni. Il recupero architettonico ha cercato di preservare le originali ed autentiche forme del casale rurale, nel rispetto dell’ambiente e della tradizione storica della Toscana, in armonia con le proporzioni, i materiali (cotto, pietra e legno quanto più possibile recuperati) ed i cromatismi dell’originario Casale. La residenza si sviluppa su un piano terra costituito da una zona di ingresso con ampio camino, cucina con parete in pietra faccia vista, una camera da letto ed un bagno; scendendo sei gradini si raggiunge il soggiorno, in contatto visivo con la zona del camino e l’area esterna della piscina. Salendo una rampa di scale si raggiunge il primo piano formato da tre camere da letto ciascuna con proprio bagno, un’ampia loggia regala un affaccio ad ovest sulla suggestiva vallata. Completano il complesso un annesso di 78 mq destinato a garage ed una piscina con solarium; il tutto circondato da olivi ed essenze tipiche locali: alloro, ginestra, timo e rosmarino.
L’intero progetto, si sviluppa seguendo la linea retta, elemento essenziale da cui si è generato tutto l’intervento, fino alle soluzioni adottate per la scelta di particolari e dettagli, con specifica attenzione rivolta alla nuova scala. Il nuovo progetto di collegamento con il sottotetto, nasce idealmente da un blocco di forma parallelepipeidale nello spazio rilevato, da cui ne viene catturata la sua forma trapezoidale esistente in pianta, che rappresenta, in proiezione, la scala, con tutti i suoi punti e le sue altimetrie dei gradini soprastanti l’opera. Questo disegno, nella sua forma caratteristica, ricorda lo spazio scultoreo ed essenziale, mentre le geometrie e gli elementi dei gradini stessi, si ispirano agli oggetti elementari di design in fusione al progetto d’insieme della scala. La porzione ricavata del sottotetto, invece, ha origine dal disegno in pianta, in particolare, dalla rappresentazione della sua sezione, che genera idealmente un guscio composto da sottrazioni e addizioni compositive di volumi lineari.
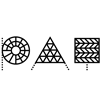
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix