

Il progetto per le nuove residenze prende in considerazione il suo territorio di appartenenza e ne studia i caratteri principali al fine di restituire alla città un’architettura urbana radicata nel contesto. L’analisi tipologica della città ha evidenziato l’orditura rigorosa nelle facciate storiche esistenti: l’alternanza di spessori e matericità in prospetto disegna un filtro tra la vita pubblica e quella privata interna all’edificio. L’analisi dell’architettura storica aretina si presta alla suggestione formale del tessuto, il cui metodo di produzione, composto da trama, ordito e filato, genera sovrapposizioni alternate di elementi in grado di originare un unico tessuto. Il disegno dell’involucro di progetto compone un‘orditura regolare di segni verticali e orizzontali. Il progetto per le nuove residenze nasce da un volume costruito sui limiti dell’area, articolato in modo scalare. I terrazzi mettono in relazione lo spazio pubblico esterno e la casa, creando un filtro tra essi. La composizione degli aggetti avviene tramite la traslazione orizzontale dei terrazzi, in modo da creare spazi esterni per ciascun appartamento e variare le soluzioni abitative. Alla composizione si aggiunge la definizione cromatico-materica generale: l’intonaco rigato color pietra e il rivestimento ligneo ad elementi verticali, cercano un dialogo dell’edificio con l’intorno, conferendo allo stesso tempo un’immagine identitaria e riconoscibile.
Allestire la mostra “Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’informale” (curata da Marco Pierini con il coordinamento scientifico e progetto allestitivo di Alessandro Sarteanesi) negli spazi della Galleria Comunale attigua alla Basilica di San Francesco, è stata anche l’occasione per riordinarne gli spazi espositivi al fine di riscoprirne il forte rapporto con la città, oltre a adeguarne la funzionalità. Dopo l’originaria trasformazione di Andrea Branzi, che intervenne a più ampia scala con un progetto di recupero dell’intero isolato, alcuni dei caratteri salienti della strategia espositiva iniziale sono stati persi e fortemente modificati. Il progetto ha cercato di valorizzare quanto rimaneva, concentrandosi nel ridefinire le pareti espositive e riscoprire il senso dello spazio interno, anche in rapporto con quello esterno di piazza San Francesco, attraverso la riapertura di gran parte delle finestre che su di essa si affacciano. Al piano terra il progetto prevede un nuovo bookshop con biglietteria, che sarà mediato con l’esterno attraverso il vestibolo d’ingresso che potrà ospitare opere d’arte. Ai piani superiori, alcune mosse tese a far riemergere la serialità degli spazi del manufatto e l’installazione di grandi prismi stereometrici nelle sale centrali ai piani, non orientati rispetto alle pareti, che permetteranno di filtrare gli spazi di servizio esistenti oltre che a supportare apparati testuali e visivi delle esposizioni.
Il progetto, su un area in collina, è stato affrontato considerando il tema dell’inserimento paesaggistico del fabbricato. Il progetto propone un edificio con un solo piano fuori terra, che si sviluppa su un corpo di fabbrica principale, posto lungo l’asse est/ovest, di forma rettangolare e compatta con una copertura a più falde delle quali le principali sono convergenti con impluvio interno. Un lungo parallelepipedo al quale si contrappongono nel lato nord altri due volumi, volendo con questa scelta emulare un processo diacronico di crescita del fabbricato tipico del processo evolutivo dell’edilizia di base nelle nostre terre. Il progetto del fabbricato si è inoltre basato sui principi della progettazione bioclimatica. L’Architettura si muove sempre di più verso la sostenibilità, verso un’integrazione degli edifici nella natura e nella ricerca di materiali che siano il più possibile eco-compatibili. In particolare ciò che renderà l’architettura sostenibile sarà il superamento della radicata tradizione costruttiva per porre, all’inizio del processo, altri elementi e sistemi considerati fino da oggi solo marginalmente: orientamento, soleggiamento, fattori di ventilazione naturale, ombreggiamento, ma anche l’adozione di sistemi di sfruttamento ed utilizzo dell’energia ricavabile da fonti rinnovabili e sistemi domotici di gestione. Per questo motivo è stato realizzato un edificio nZEB, con struttura prefabbricata in legno ad altissima prestazione energetica.
Il progetto dell’abitazione privata parte da una attenta analisi delle tipologie edilizie di case contadine della Valdichiana. La ricerca delle valide ragioni e della consapevolezza bioclimatica propria della cultura locale hanno guidato la progettazione, plasmando i suggerimenti derivanti dall’analisi dell’area d’intervento. E così l’assenza di finestre esposte a tramontana, l’orientamento delle facciate secondo i quattro punti cardinali con la facciata principale esposta a sud, la creazione di un camino centrale per scaldare la casa e di loggiati tutti attorno dimensionati per far entrare i raggi solari d’inverno e di schermarli nei mesi estivi sono diventati la strategia bioclimatica passiva dell’abitazione. Gli spazi serventi sono stati disposti nel lato nord e lungo la strada di accesso che lambisce la casa, permettendo alla zona giorno di aprirsi verticalmente con un doppio volume e orizzontalmente sui lati sud e ovest verso il parco, determinando con le grandi vetrate una continuità tra interno ed esterno. A mediare la loggia, progettata per accogliere la vegetazione. Ciò ha permesso al progetto di diventare a tutti gli effetti una autentica casa contemporanea toscana, in cui le virtù della tradizione si fondono con le innovazioni tecnologiche.
La progettazione di uno studio odontoiatrico, degli spazi di cura e sanitari in generale, è un tema che richiede attenzione e sensibilità. Nell’immaginario condiviso le esperienze di una persona nello studio di un dentista sono quelle del timore, dell’apprensione e della sofferenza. Il luogo dove queste esperienze sono vissute ha un ruolo determinante nell’accentuare le paure o calmare, rilassare. Lo spazio è uno strumento di lavoro che introduce e accoglie il paziente a questa condizione di fragilità. Ad un luogo di cura viene richiesta un’immagine di pulizia e ordine ma allo stesso tempo di ospitalità e confort, caratteristiche necessarie sia a rassicurare sulle cure sia a sentirsi ospitati in un contesto sereno. Il progetto vuole offrire questa doppia visione di luogo rigoroso, pulito, asettico nella parte medica ma anche accogliente, conviviale e comodo nella parte di attesa e recezione. Una scelta attenta ai materiali rafforza questo concetto. Un ambiente spazioso, materiali caldi come le pannellature in legno e gli arredi ricevono i visitatori in maniera rassicurante. Le forme rigorose e le generose superfici vetrate definiscono la zona tecnica e medica, permettono trasparenza e luminosità, mostrano con chiarezza il contesto al paziente e facilitano l’attività del personale.
Il cimitero suburbano di Campoluci di piccole dimensioni, con muro di cinta in pietra lungo la strada provinciale e il lato dell’ingresso, con due cipressi ai lati dell’ingresso. L’intervento è finalizzato all’ampliamento interno del cimitero per la realizzazione di una nuova cappella funeraria e blocchi di loculi ed ossari inserita in una sequenza perimetrale di manufatti esistenti. La tipologia architettonica della cappella, con schema planivolumetrico semplice di base quadrangolare, è costituita da un lato da una fila di loculi, sul fronte opposto è posizionato il sarcofago, una disposizione di tipo asimettrico, in cui si possono schematizzare due zone ambientali, i loculi prettamente funzionali, e l’ambiente destinato ad ospitare il sarcofago con una valenza simbolica. Tale valenza è accentuata dalla luce, uno spazio immerso dalla luce. La copertura prevede un lucernario in vetro a “L” dal quale penetra la luce e taglia la cappella, penetrando fino al lato opposto, l’ingresso alla cappella. Un invito luminoso ad entrare nel sepolcro, dove percepiamo immediatamente la visione dell’approdo alla felicità eterna. Una esigenza da parte della committenza, di ricordo della figlia deceduta giovane, e di dare una immagine positiva della morte al nipote. La cappella in calcestruzzo armato, sul lato esterno con calcestruzzo a vista. Il fronte esterno e l’interno è impreziosito da pietra e marmi pregiati.
La sistemazione di un appartamento su due livelli –secondo e terzo piano– cerca di adattare l’esistente, frutto di continui rimaneggiamenti, alle nuove esigenze abitative. Caratteristica peculiare dello stato di fatto sono gli scarti, le imperfezioni i piccoli e continui cambi di quota che rappresentano sia un ostacolo da arginare che un’occasione per connotare le dinamiche della casa. Questo raumplan naturale generato delle sovrascritture del tempo si manifesta già dall’ingresso, che malgrado si trovi al secondo piano introduce a quattro gradini verso il basso ed alla zona di distribuzione principale, al centro della quale si posiziona la scala. Questa viene pensata come corpo che poggia su di un podio costruito ex novo. L’intervento si incastra all’interno dei dislivelli esistenti come grande meccanismo che attraverso un solo gradino uniforma i flussi del piano. La pavimentazione in corda dell’ingresso interrotta con il parquet, che a sua volta viene posato con diversa orditura in modo da denunciare il dislivello presente. La scala, costruita attraverso un telaio in legno di frassino e tamponata con fogli di paglia di Vienna tirati poggia su un grande podio impiallacciato in legno di rovere. Un elemento in graniglia evidenzia l’imbocco della rampa e si pone come soluzione di continuità tra un piano e l’altro. La camera padronale è il risultato di un’interpretazione radicale nel modo di vivere il tempo del riposo: non avere nient’altro che il letto sul quale dormire.
Il progetto si concentra in un importante revisione degli interni con l’intento di qualificare e restituire all’abitazione spazi aperti per l’utilizzo conviviale e luoghi privati per esigenze familiari. Dove necessario si rimuove elementi murari incongrui enfatizzando ambienti unici distinti dalle fasce di servizio integrate nella progettazione con rivestimenti e dettagli su misura. Si privilegiano atmosfere differenti nella luminosità e nei colori ma legate da ricordi di finiture e disegno. L’accoglienza della casa avviene in un nucleo centrale costituito dalla sala giorno, luogo unico longitudinale composto da una successione eterogenea di fondali: libreria, studio, diaframma di disimpegno, armadiatura integrata, seduta in pietra e focolare, cassettiera, guardaroba. L’ingresso trasposto in asse si pone come inizio e fine di un concetto di arredo che si prospetta continuum vario nei diversi utilizzi ma uniforme-omogeneizzante nella sua composizione. Il legno di rovere della pavimentazione, che assorbe le ombre sfumandone i bordi, si ritrova nelle superfici degli arredi laccati di bianco o laminati di azzurro nebbia. L’innesto della scala è definito da tre gradini rivestiti in pietra serena spazzolata che continua come grande mensola di appoggio del camino. Il luogo del fuoco descrive un’atmosfera calda e colloquiale grazie ai rapporti tra seduta, illuminazione e poltrone.
La Fortezza di Arezzo è uno straordinario complesso fortificato cinquecentesco progettato da G. ed A. da Sangallo il Vecchio nei primi anni del cinquecento, ultimato da A. da Sangallo il Giovane tre decenni più tardi. Una prima fase delle lavorazioni ha riguardato i restauri specialistici dei paramenti lapidei della fortezza. Particolarissime le condizioni di degrado ed i dissesti presenti in tre dei cinque bastioni, che le truppe napoleoniche minarono nell’ottobre del 1800 facendone corpi di fabbrica sventrati e privi di volte ed orizzontamenti. Una seconda fase ha riguardato la risistemazione degli spazi interni alla Fortezza per renderli accessibili, utilizzabili con interventi di consolidamento, di restauro, di riqualificazione tecnologica e di ridisegno del sistema degli accessi e delle percorrenze, per riportare all’interno della Fortezza attività culturali, cittadini, turisti, giovani che possano scoprire o riscoprire un monumento straordinario, luogo di prima grandezza per la comprensione della Storia di Arezzo. Ai restauri specialistici si sono aggiunte integrazioni funzionali ed architettoniche con una costante ricerca del dialogo fra antico e nuovo necessarie per l’uso e la comprensione critica del complesso monumentale. Fra queste i ponti metallici, ascensori esterni, il grande palco in acciaio cor-ten, la ricostruzione del Bastione del Soccorso, sventrato dalle mine, quale nuovo accesso in acciaio e vetro con l’inserimento di un nuovo ascensore e scale.
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area dove sono collocati una coppia di blocchi di loculi a fila verticale tra due manufatti esistenti nell’ultimo ordine del Cimitero Monumentale di Arezzo, in prossimità del bastione della Fortezza Medicea. Il progetto ha riguardato la trasformazione dell’attuale spazio in una cappella funeraria chiusa ad uso privato, nel riaspetto dei caratteri del sito e di tutela paesaggistica delle presenze storiche esistenti. La scelta progettuale è stata quella di realizzare una cappella con caratteri di leggerezza e trasparenza in modo tale da non alterare i rapporti morfologici e le finiture dei manufatti esistenti mediante uno spazio chiuso e utilizzo di componenti opachi; inoltre, mantenere libere le visuali lungo i percorsi interni che guardano la fortezza. Le dimensioni dell’area sono: larghezza 3.40 ml, lunghezza 2.65 ml, altezza 4.60 ml. Il sistema costruttivo utilizzato è costituito da un telaio metallico in acciaio inox satinato e vetro strutturale. Anche le griglie laterali svolgono funzioni strutturali per consentire di avere lastre sottili.
Il CENTRO*Arezzo trae spunto dal logo Coop e dalla relazione con la città storica. Il primo elemento caratterizzante del logo è il cerchio. La ripetizione di questa forma geometrica è l’elemento chiave dell’intervento. L’aggregazione di cerchi di diverso diametro, inseriti in una griglia geometrica, genera un pattern che viene declinato nell’edificio creando effetti percettivi variabili. Il secondo spunto del logo è quello della continuità tra le lettere, che conferisce ad esso una lettura unitaria. Allo stesso modo un nastro continuo diventa l’elemento generatore degli spazi, accompagnando il visitatore in un sentiero fluido e curvilineo. Il pattern genera una superficie bianca, forata, dai raccordi curvilinei che si articola nella facciata esterna, nel soffitto del percorso interno, sviluppandosi nelle facciate della piazza. La scansione degli ambienti del CENTRO*Arezzo e l’articolazione dei percorsi è tesa a ricreare la spazialità della città storica nei suoi elementi caratterizzanti: la strada e la piazza. Il nuovo profilo dell’edificio è teso a ricreare un dialogo con l’articolazione caratteristica della città, riproponendo un elemento verticale per accentuare l’ingresso principale e richiamare con un nuovo linguaggio le forme delle torri di Arezzo. La presenza del verde sia negli spazi esterni che in quelli interni accompagna il visitatore lungo i percorsi con una serie di aiuole circolari, ed insieme alla luce solare filtrata crea un ambiente dal carattere naturale.
Oggetto: Progetto di restauro e risanamento conservativo del fabbricato n.ro 4 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva per il fabbricato n.ro 7 della Scheda Normativa n. 692 del Regolamento Urbanistico del Comune di Arezzo, Loc. Tregozzano. descrizione Si tratta del restauro del vecchio fienile adibito a deposito e della sostituzione della tettoia adiacente con una porzione di fabbricato da destinare il tutto a civile abitazione. Il progetto si è composto quindi di due momenti come meglio di seguito descritto: RESTAURO DEL FIENILE. A piano terra è stato restaurato per ricavarci la cucina e un servizio igienico con antibagno. Tramite una scala rettilinea ubicata nella parte terminale si accede al piano primo dove è stata ricavata una camera doppia con annesso servizio igienico. All’esterno al posto della vecchia concimaia è stata realizzata una pergola con canniccio nella parte superiore. PORZIONE IN SOSTITUZIONE. La vecchia tettoia regolarmente costruita in adiacenza al fienile è stata interamente demolita, strutture metalliche e pareti in bozze di tufo comprese per fare posto alla nuova porzione di edificio. Il nuovo involucro si sviluppa interamente a piano terra andando a ricalcare il vecchio perimetro, ha una forma pressochè rettangolare con ampie aperture nei due lati maggiori. Nel suo interno sono ricavati il soggiorno pranzo, due camere matrimoniali e due servizi igienici.
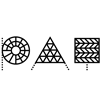
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix