

L’opera è situata nel sottosuolo di una villetta a Luciana (Fauglia). Era possibile accedere dal Soggiorno alle Cantine mediante una scala in pietra chiusa da una grata in ferro; le cantine avevano un solaio in legno (quota -2.97 mt) poggiato su travi in acciaio, da una botola con scala a pioli era possibile accedere al livello sottostante (quota – 5.27 mt). Il livello di umidità era tale da aver corroso i solai e compromesso l’impianto elettrico delle cantine. L’Opera Hidden Eggs ha previsto una nuova chiusura delle scale composta da tre vetrate con infisso in acciaio e maniglia a scomparsa poste a livello del pavimento del soggiorno. E’ stato quindi realizzato un impianto di aerazione forzata utilizzando tubazioni in Pvc per le cantine ed in acciaio inox a vista in Cucina regolate da un ventilatore con motore posto all’esterno del fabbricato. Sono stati realizzati nuovi solai e scale a chiocciola mediante profili in acciaio e lamiere grecate (per garantire maggiore passaggio d’aria). La Cantina di destra, utilizzata per i vini, è visibile dal lucernario in Soggiorno e presenta un solaio composto da lamiere tagliate a spicchi che proseguono l’andamento della scala a chiocciola, ha sia illuminazione scenica realizzata mediante led colorati che illuminazione tecnica per l’utilizzo della cantina stessa. La Cantina di sinistra, utilizzata come ripostiglio, ha scale decentrate e solaio composto da lamiere tagliate irregolarmente, presenta illuminazione tecnica a tenuta stagna.
L’edificio, di fattura singolare per l’alta Maremma, basso e con copertura a terrazza, è stato costruito negli anni Settanta. La struttura originaria è in muratura, realizzata in blocchi di tufo, e priva, prima della ristrutturazione, di impianto di riscaldamento. Per migliorarne l’isolamento termico è stato realizzato in copertura un cappotto, le murature porose sono state protette da un intonaco per allontanare l’acqua. Il nuovo progetto collega gli interni con gli esterni: la zona giorno è sull’asse sud-est/nord-ovest, l’orientamento viene fatto coincidere con i coni visivi. Il tavolo da pranzo è stato posto di affaccio al giardino e alla pianta di salice, in modo che la mattina si possa fare colazione guardando il sorgere del sole mentre il divano ha una vista sul giardino di accesso e sul tramonto estivo. Il letto è stato posto in asse con la finestra esposta a sud-ovest. Il tiglio, grazie alle sue foglie caduche, offre alla camera un’ombra fresca nelle stagioni calde mentre permette il passaggio dei raggi del sole in inverno. Il centro della casa è il fuoco. È stato realizzato un termocamino a legna, perché il fuoco in campagna è elemento utile anche per togliere l’umidità. In estate l’acqua calda è prodotta da due pannelli solari. Dopo aver posizionato gli arredi fondamentali in corrispondenza delle aperture principali si è continuato un processo di autocritica, cercando la sintesi tra forma e funzione, togliendo sempre il superfluo e aggiungendo solo il significante.
Il restauro del convento di San Francesco si inserisce nel quadro di interventi realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l’insediamento dell’istituzione Alti Studi Universitari IMT nel centro storico della città, completando, con la biblioteca e gli uffici amministrativi già realizzati, il campus . Il complesso di San Francesco riunisce in un edificio didattica, ricerca e residenza, secondo lo spirito dello studium: luogo di cultura, di vita quotidiana della comunità scientifica. A fianco delle aule per la didattica e i dottorandi e degli uffici di professori e ricercatori si trova la foresteria, composta da camere doppie, singole e mini appartamenti. La Cappella della famiglia Guinigi ospita l’aula magna di IMT mentre i locali della sagrestia sono stati attrezzati per seminari e riunioni. Gli interventi recuperano le spazialità e le percorrenze originarie del convento, rimuovendo le partizioni recenti e riorganizzando la distribuzione attorno ai chiostri in parte chiusi con pareti vetrate. Una vasta campagna di saggi stratigrafici ha permesso di indagare e recuperare ampie porzioni di apparati decorativi celati da intonaci recenti; attraversare gli spazi è ora anche percorrere la storia del monumento. Le nuove esigenze distributive sono soddisfatte attraverso una serie di elementi architettonici che si sovrappongono al contesto storico in maniera discreta ma riconoscibile attraverso l’uso di materiali tecniche contemporanee.
Il CENTRO*Arezzo trae spunto dal logo Coop e dalla relazione con la città storica. Il primo elemento caratterizzante del logo è il cerchio. La ripetizione di questa forma geometrica è l’elemento chiave dell’intervento. L’aggregazione di cerchi di diverso diametro, inseriti in una griglia geometrica, genera un pattern che viene declinato nell’edificio creando effetti percettivi variabili. Il secondo spunto del logo è quello della continuità tra le lettere, che conferisce ad esso una lettura unitaria. Allo stesso modo un nastro continuo diventa l’elemento generatore degli spazi, accompagnando il visitatore in un sentiero fluido e curvilineo. Il pattern genera una superficie bianca, forata, dai raccordi curvilinei che si articola nella facciata esterna, nel soffitto del percorso interno, sviluppandosi nelle facciate della piazza. La scansione degli ambienti del CENTRO*Arezzo e l’articolazione dei percorsi è tesa a ricreare la spazialità della città storica nei suoi elementi caratterizzanti: la strada e la piazza. Il nuovo profilo dell’edificio è teso a ricreare un dialogo con l’articolazione caratteristica della città, riproponendo un elemento verticale per accentuare l’ingresso principale e richiamare con un nuovo linguaggio le forme delle torri di Arezzo. La presenza del verde sia negli spazi esterni che in quelli interni accompagna il visitatore lungo i percorsi con una serie di aiuole circolari, ed insieme alla luce solare filtrata crea un ambiente dal carattere naturale.
La struttura nata come convento nella prima metà del sec.XVII viene adattata e trasformata in Casa di Pena intorno alla metà del sec.XIX finché nel 1984 con la costruzione del carcere di Sollicciano i detenuti vengono trasferiti nel nuovo penitenziario mentre quello di Santa Teresa viene dismesso. Il valore storico che emerge come carattere determinante di questo edificio viene recepito dal progetto che si propone di mantenere visibile la sedimentazione secolare di segni e interventi diversi valorizzando attraverso il recupero sia la memoria del carcere che quella più antica del convento e riportando alla luce quando possibile l’impianto originario di quest’ultimo. Approccio che ha guidato il riordino delle attività della scuola secondo una relazione tesa tra necessità funzionali e lettura delle diverse parti di stratificazione storica del complesso: la Facoltà di Architettura occupa i corpi a pettine che risalgono all’ampliamento carcerario dell’800; il Dipartimento di Progettazione occupa il nucleo dell’antico convento con i locali intorno al chiostro. Tra le due parti dove prima c’era un vuoto di risulta salvo minori collegamenti di servizio il progetto ricava la nuova spina distributiva con ingresso da Via Mattonaia. La nuova hall vetrata attraverso affacci e stacchi architettonici ad un unico tempo riconnette e tutela la lettura delle diverse parti nonché trascende la funzione distributiva per poter essere utilizzata come galleria espositiva e di dibattito con la Città.
Il progetto del Museo degli Innocenti fonda le sue ragioni sull’interpretazione del bene monumentale come struttura viva e rappresenta la sintesi tra le istanze di uso contemporaneo degli spazi museali esistenti e la valorizzazione di ambienti fino ad oggi inutilizzati. Il progetto risolve i problemi di accessibilità grazie ai nuovi ingressi sulla piazza, all’apertura di uno spazio al livello seminterrato e al nuovo sistema di distribuzione verticale che connette i vari livelli. Realizza un allestimento dedicato all’infanzia che valorizza tanto il patrimonio storico e artistico quanto il complesso monumentale di Brunelleschi. Riscopre e ridona alla città una grande loggia, il Verone, antico stenditoio del palazzo fiorentino, che grazie al progetto ha ritrovato la sua originaria apertura panoramica sulla città di Firenze, fruibile non solo ai visitatori del museo ma a tutta la cittadinanza. Due porte in bronzo azionate meccanicamente risolvono il problema dell’accesso dalla piazza. Le porte a geometria variabile interpretano l’idea di Brunelleschi di continuità tra interno ed esterno e con un gesto simultaneo rievocano la disponibilità dell’edificio ad “accogliere”. Il progetto museografico ha evidenziato le potenzialità delle aree espositive esistenti, integrandole in un sistema più ampio che comprende tutto l’edificio. Il percorso espositivo si articola dagli spazi del seminterrato, prosegue nella Pinacoteca del piano nobile e si conclude nella loggia panoramica del Verone.
La Villa colonica del ‘400, oggetto dell’intervento di recupero, si trova nel comune di Monteriggioni (SI) a pochi passi dallo splendido castello della Chiocciola. La Villa è stata attribuita da alcuni studiosi all’opera di Baldassarre Peruzzi, pittore e architetto senese che operò in zona ad inizio XV secolo. L’intervento si concentra sul piano nobile di circa 400 mq con la realizzazione di un appartamento moderno e funzionale dotato di ogni confort. L’idea portante del progetto è stata quella di usare due registri paralleli, quello quasi filologico del restauro delle parti originali e quello assolutamente contemporaneo dei nuovi interventi e dell’arredo. Ne è scaturito un insieme in cui le due parti dialogano con espressioni anche molto diverse, ma con la costante ricerca di una sintesi finale comune. I nuovi ambienti funzionali al nuovo programma abitativo sono stati realizzati come scatole isolate dipinte con smalto bianco lucido che non arrivano mai al soffitto, ma si fermano prima, per ospitare temi di illuminazioni con luce a led. I nuovi pavimenti della zona giorno sono stati realizzati in resina cementizia di color ocra chiaro. I pavimenti della zona notte sono invece tutti realizzati con un parquet in legno di quercia naturale ossidata trattato a calce. Tutti gli arredi della casa, ad eccezione di qualche oggetto di recupero, sono stati realizzati su disegno e prodotti da artigiani locali come pezzi unici e irripetibili.
L’intervento in oggetto si colloca in via Aretina, all’interno del quartiere 2 di Firenze, nella zona denominata Varlungo sita nella parte est della città, più nota come ‘Firenze Sud’. Il progetto ha interessato la riqualificazione di capannoni industriali abbandonati risalenti ad epoche diverse per un totale di 3200 mq destinato ora a laboratori artistici, studi e spazi collettivi dedicati a chi frequenta questi ambienti. Questi edifici erano segnalati nel piano strutturale del Comune di Firenze come di particolare criticità. Con il progetto si è previsto il recupero puntuale degli immobili e delle strutture cercando di evidenziare in particolare elementi strutturali quali capriate, travature, tetti in legno e murature in mattoni. Si è scelto di lasciare visibili le tracce del tempo che aveva lasciato stratificazioni di epoche differenti: una mangiatoia laddove ora sorge un piccolo bar, metodologie costruttive varie quali capriate in legno e volte in laterizio armato, materiali e colori misti. Con questo obiettivo si è scelto di suddividere gli spazi interni con partizioni di altezza 2, 50 m così da lasciare la percezione di unità dell’intero complesso. All’interno sono stati realizzati: uffici per il personale, uno spazio lounge interno e due piazzali esterni riqualificati ed attrezzati, uno spazio bar, numerosi laboratori con attrezzature varie a seconda delle necessità delle discipline, studi privati, 4 studio per il ricovero di ospiti stranieri e un auditorium.
Oggetto: Progetto di restauro e risanamento conservativo del fabbricato n.ro 4 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva per il fabbricato n.ro 7 della Scheda Normativa n. 692 del Regolamento Urbanistico del Comune di Arezzo, Loc. Tregozzano. descrizione Si tratta del restauro del vecchio fienile adibito a deposito e della sostituzione della tettoia adiacente con una porzione di fabbricato da destinare il tutto a civile abitazione. Il progetto si è composto quindi di due momenti come meglio di seguito descritto: RESTAURO DEL FIENILE. A piano terra è stato restaurato per ricavarci la cucina e un servizio igienico con antibagno. Tramite una scala rettilinea ubicata nella parte terminale si accede al piano primo dove è stata ricavata una camera doppia con annesso servizio igienico. All’esterno al posto della vecchia concimaia è stata realizzata una pergola con canniccio nella parte superiore. PORZIONE IN SOSTITUZIONE. La vecchia tettoia regolarmente costruita in adiacenza al fienile è stata interamente demolita, strutture metalliche e pareti in bozze di tufo comprese per fare posto alla nuova porzione di edificio. Il nuovo involucro si sviluppa interamente a piano terra andando a ricalcare il vecchio perimetro, ha una forma pressochè rettangolare con ampie aperture nei due lati maggiori. Nel suo interno sono ricavati il soggiorno pranzo, due camere matrimoniali e due servizi igienici.
LA FORNACE AGRESTI Progetto di restauro Localizzazione: via delle Fornaci, Impruneta, Firenze Committente: Amministrazione Comunale di Impruneta Progetto: Guicciardini & Magni Architetti Progetto strutture: Enrico Baroni Progetto impianti: Gianni Cinellli Estensione degli interventi: mq. 1.200 La Fornace Agresti è un raro esempio di archeologia industriale. La costruzione risale infatti agli inizi del 700 ed ha subito, nel corso dei secoli, numerose modifiche e trasformazioni. Gli ambienti della Fornace sono quindi il risultato di una serie di aggiunte successive, durante le quali i vari annessi, i loggiati per l’essiccazione e l’immagazzinamento dei prodotti si sono sommati alla struttura dell’antica Fornace in un corpo organico che è quasi privo di connotazioni temporali, ma è reso unitario e significativo dalle tracce e dai segni delle lavorazioni. L’idea che ci ha guidato nella redazione del progetto è che il manufatto sia il reperto principale da mostrare, e così come si restaura un quadro o una scultura che dovranno essere esposti, con la stessa attenzione e cura abbiamo procedendo con il restauro dell’edificio. I lacerti delle pavimentazioni residue in cotto, i segni dello scorrimento dei mezzi e degli animali da soma, gli annerimenti e le bruciature delle zone adiacenti i forni costituiscono un documento unico da conservare, di interesse probabilmente superiore a quello dello stesso organismo architettonico.
Il complesso canonico è stato restaurato secondo i principi del restauro scientifico e reso accessibile ai disabili ove possibile, affinché il luogo tornasse un punto di ritrovo per la comunità. È stato eseguito il consolidamento delle murature per bloccare lo slittamento di alcune parti, che comprometteva tutto il complesso. Sono state eliminate superfetazioni e incongruenze presenti in pianta e in alzato. Sono state tolte tubazioni ed intonaci ammalorati, sostituiti con intonaci tradizionali a base di calce. Il progetto del resede tergale ha evidenziato l’antico ingresso della pieve romanica, invertito nel XVI Secolo. Sono stati individuati i piani storici, collegati da scale e rampe, il tutto rivestito in pietra serena. La terrazza di accesso all’abside è protetta da una balaustra in vetro che consente la visione continua dell’ingresso originario. Sui corpi più antichi della chiesa è stata mantenuta la muratura a vista, per distinguerli dai corpi aggiunti nei secoli, intonacati e finiti con colori storici. Il giardino e le murature in pietra forte sono stati restaurati e resi accessibili, così come la scala a doppia rampa. All’interno è stato restaurato il piano seminterrato, risalente al castello preesistente. Sono stati eliminati i grossi pilastri costruiti negli anni Settanta, che rompevano l’unitarietà planimetrica. Per le pavimentazioni si è scelta la pietra serena, mentre i solai, eccetto l’unico ligneo storico, sono stati celati da controsoffitti ad elementi lignei.
L’unità immobiliare, ante ‘67, è Classificata in Centro storico entro le mura, e in Classe 5. L’obiettivo principale del progetto di recupero e cambio di destinazione, da uffici a residenza per turisti, era quello di creare uno spazio fluido che permettesse una facile fruizione e ampia disponibilità di spazi e letti. Partendo da uno studio preliminare per capire la fattibilità del cambio di destinazione e un attento preventivo di massima, avendo ben presente le richieste precise della committenza, gli architetti sono riusciti a sviluppare liberamente un progetto, in cui si coniuga armoniosamente la luce, le forme e i materiali impiegati integrandoli nell’ambiente minimalista, attraverso una libera interpretazione degli spazi interni per meglio adattarsi alla nuova destinazione. L’atmosfera dell’interno è influenzata da diversi materiali di lusso e da un insieme cromatico molto semplice dominato dall’intonaco burro, i soffitti bianchi, il parquet chiaro, posato a lisca di pesce tradizionale, e la pietra nei bagni. I tocchi di colore sono dati dalle carte da parati scelte fra le molteplici del negozio specializzato di Via Santo Spirito, gli arredi sono stati realizzati e scelti dagli architetti nel rispetto di un unicum spaziale. Due porte a scorrere gemelle, appese nel controsoffitto, si aprono sull’ingresso dando la possibilità di utilizzare lo spazio in modo flessibile, gli specchi ampliano lo spazio, riflettendo la luce delle ampie finestre.
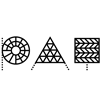
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix