

Nelle sue varie declinazioni l’abitare privato può cristallizzare la manifesta volontà di riappropriarsi di una dimensione perduta, la dimensione di una porzione di territorio residuale. In questo progetto la forma non è contesto, non è reinterpretazione della tradizione né ricerca di rapporti figurativi perduti. Si è cristallizzata l’aspirazione a una pratica della committenza: coltivare l’orto; e si è fatto con una forma pura che ha origine nella forma ancestrale del disegno infantile dei bambini della casa. Lo scopo precede la prassi metodologica di inserire architetture contemporanee in contesti territoriali fragili in modo da riattivarne, con nuove relazioni di prossimità, le potenzialità relazionali. Questo progetto rientra in quel filone di ricerca tesa a indagare come la sintesi figurativa di un’opera d’architettura sia spesso ricorsiva nell’attività di un architetto, e come essa stessa possa essere un elemento d’indagine indispensabile nel cercare risposte e/o modelli adeguati richiesti da una contemporaneità estremamente fluida e dinamica.
Un unico pattern definisce la nuova piazza per l’Isolotto: un tappeto continuo, capace di rendere le differenze delle variazioni su un tema. Sono trame diverse che partecipano alla definizione di un disegno unico, comune dove ciò che prevale è il valore simbolico del “noi”, noi tutti insieme. Un flying magic carpet, capace di rendere vicini luoghi e persone lontane; è l’immagine simbolica della volontà di rendere vicino ciò che oggi è distante: le opinioni, i valori culturali, le etnie. Per questo il simbolo principale diventa rispecchiarsi nella copertura della grande pensilina, insieme. La vivibilità di una città oggi si misura innanzitutto sulla capacità che essa ha di invitare le persone a percorrerla, ad attraversarla in bicicletta, a sostare nei suoi spazi. Camminare è il punto di partenza, perché una città è tanto più ospitale ed accogliente quanto più è disponibile a farsi attraversare, così sono stati immaginati spazi che possono essere percorsi da tutti e guardati da tutti. Quello che abbiamo indagato con questo progetto quindi, è un’idea di città come luogo d’incontro, all’interno della quale lo spazio vuoto viene considerato un’opportunità di disegnare le relazioni tra cose diverse (edifici, persone, attività, flussi ecc.), di raccontare la qualità della vita che si svolge all’interno, attraverso un’idea che tenga insieme una sequenza di spazi del fuori, quelli di tutti, dove ogni individualità si riconosce come parte di una comunità, come parte di un “Noi”.
La Scuola primaria Collodi di Sansepolcro è situata al margine interno della cinta muraria medicea della città in adiacenza ad uno dei suoi bastioni; la realizzazione dell’ampliamento in oggetto, composto da tre aule e dall’auditorium, segue il precedente intervento di ricostruzione del blocco principale a due livelli delle aule. Il completamento del complesso avviene con un impianto dei volumi a corte aperta delineata da un corpo ad “L” che termina nel volume predominante dell’auditorium. Il progetto nasce dall’evocazione delle figure e dei temi della storia di Collodi che prendono forma nei volumi e nei vuoti verdi per raccontare, e concludere, una storia che inizia nel nome stesso della scuola amplificandone la capacità comunicativa e identificativa verso la comunità che ospita. È la balena dell’auditorium che emerge al centro della corte con la sua copertura bianca dalle forme complesse, mostrando la fitta schiera delle colonne colorate all’esterno e, all’interno, la successione dei portali in legno dalla sagoma frastagliata, come il grande palato schermato dai denti della balena dai cui si affaccia Geppetto aspettando Pinocchio. il campo dei miracoli in cui si trasforma lo spazio verde della corte che accoglie i bambini per proseguire il loro lavoro come un’aula all’aperto. È il legno di Geppetto che scandisce le forme delle strutture sia delle aule che dell’auditorium con sagome complesse ed elaborate come quelle intagliate da un falegname.
Palestra scolastica dotata di campo regolamentare per il basket (Livello Base) e per la pallavolo (campo omologato per Campionati Nazionali serie B2). L’edifico si sviluppa trasversalmente a via A. Kuliscioff sulla quale si affaccia mediante una piccola piazza pubblica, dove, varcato l’ingresso, si percorre un percorso pedonale permeabile in autobloccanti di cemento in parte inerbiti, che collega la palestra con la scuola. Il fabbricato, realizzato da una struttura prefabbricata di c.a.p. si compone di tre volumi distinti: il volume che ospita l’area gioco di dimensioni in pianta di circa ml. 22×33 e H interna di ml 8.60 e due volumi più piccoli, ad esso addossati, sempre in prefabbricato di c.a., destinati uno a spogliatoi e l’altro a locale tecnico. La copertura a shed ospita l’impianto fotovoltaico. I pannelli prefabbricati in c.a. del volume principale sono caratterizzati da una finitura in cemento grigio su fondo cassero scandito da finte fughe orizzontali distanziate con andamento decrescente partendo dalla sommità del fabbricato. Un’ampia vetrata d’angolo di colore arancione e vetrofanie con figure di pallavoliste e cestisti caratterizza le facciate sulla piazza. ll blocco degli spogliatoi si distingue, invece, grazie ad una parete verde realizzata da una “pelle” in rete elettrosaldata maglia 80×80 mm, filo 6, sulle quali sono cresciute piante rampicanti (rose e gelsomini) innestate in aiuole ricavate sul marciapiede in calcestruzzo che circonda il fabbricato.
NEST, acronimo di New Enginery Solution Technology. NEST, in inglese NIDO. Il progetto, per questa Società che opera nel settore chimico-farmaceutico, prende spunto dall’idea di creare con linee semplici e moderne un ambiente di lavoro confortevole, luminoso, ben organizzato e decisamente proiettato verso il futuro, NEXT appunto! Gli spazi sono stati predisposti per creare una immediata, chiara lettura del percorso distributivo. All’ingresso, disimpegnata, la stanza delle riunioni con accanto una piccola sala di attesa e l’ufficio dell’amministrazione caratterizzato da una grande parete vetrata che si affaccia sul largo corridoio centrale. Con l’ausilio di una pensilina bianca, lungo l’asse di distribuzione, inscatolato il NIDO, uno spazio avvolgente al di sotto del quale sono riuniti gli uffici dei quattro soci fondatori allitterati sia nella forma sia nella funzione. Ogni ambiente, di colore grigio scuro, si distingue per la presenza di una grande lettera in acciaio satinato e i quattro uffici, in prospettiva, compongono la parola NEST. In fondo al corridoio, superata l’area break, l’ampio open space con le postazioni dei giovani collaboratori trova la centralità operativa con “l’isola grigia”, composta da due piccoli nidi al cui interno è possibile svolgere attività lavorative più privatizzate e direzionali.
NEST = NIDO = NEXT…LAVORO = COMFORT = FUTURO
Il progetto Area Marketing e Factory Museum Ginori 1735 è parte di una più ampia campagna di riqualificazione degli stabilimenti storici Ginori, affidati allo studio b-arch, tuttora in corso di realizzazione. Comprende uffici/headquarter, outlet, spazi aperti e restauro della torre dell’acqua, vero e proprio landmark territoriale dell’azienda sestese. Il progetto prevede la valorizzazione delle campate e delle lievi strutture in cemento armato della navata centrale, che diventano uno spettacolare contenitore di ampi spazi aperti, dedicati ad attività didattiche, espositive e di marketing, e di una trama di volumi chiusi che ospitano attività più raccolte: auditorium/multimedia, show-kitchen, meeting room e box didattici. Il brief proposto prevede la realizzazione dello spazio in due step successivi, concepiti in modo che la conclusione del primo si presenti comunque come un’opera compiuta e funzionale. B-arch concepisce un progetto dove la conclusione del primo capitolo dimostri tuttavia la sua caratteristica di “non finito”, pur fornendo tutte le funzionalità richieste. La superficie grezza del cartongesso diventa una texture pittorico-gestuale a cui viene sovrapposta la grafica gigante del marchio aziendale, fresco di re-branding. Le strutture espositive sono realizzate in blocchi grezzi di gasbeton, che al termine del loro utilizzo temporaneo potranno tornare alla funzione originale di materiale da costruzione, completando i contenuti di sostenibilità del progetto.
Un cubo di cemento appoggiato su di una lama d’acqua ed un muro a secco, sospeso su un campo di ulivi e affacciato sulla pianura che vede Firenze all’orizzonte. Concrete Barn è un edificio destinato al tempo libero ed alla convivialità. È il fienile contemporaneo di una residenza tradizionale appoggiata sulle colline del Montalbano; costruito come un tubo di cemento, aperto sullo spettacolare paesaggio che lo fronteggia, il cui cannocchiale ottico è filtrato da una membrana costruita prendendo a prestito le trame di mezzane di laterizio che ombreggiano gli interni dei fienili tradizionali. Al suo interno spazi dedicati alla convivialità, al tempo libero ed alla contemplazione. Una cucina, un forno a legna, un tavolo, un piccolo servizio sono tutto quello che serve. Il paesaggio è parte dell’architettura, reso ancora più interessante dalla vibrazione imposta dalla trama di laterizio. All’esterno il volume del forno e del camino sono rivestiti della stessa pietra dei muri a secco della campagna circostante. Cemento, pietra e laterizio si completano nel segno d’acqua della piscina, scavata nella superficie netta dell’aia, rivolta verso le colline vicine ed il lontano orizzonte della pianura. Aia di pietra chiara e di legno grigio, ombreggiata da una pergola leggera e circondata da un giardino naturale e stagionale (landscape arch. Bellesi-Giuntoli). Acqua e cemento, mattone e pietra, superfici lisce soleggiate che dialogano con facciate ombrose e materiche.
Il progetto dell’abitazione privata parte da una attenta analisi delle tipologie edilizie di case contadine della Valdichiana. La ricerca delle valide ragioni e della consapevolezza bioclimatica propria della cultura locale hanno guidato la progettazione, plasmando i suggerimenti derivanti dall’analisi dell’area d’intervento. E così l’assenza di finestre esposte a tramontana, l’orientamento delle facciate secondo i quattro punti cardinali con la facciata principale esposta a sud, la creazione di un camino centrale per scaldare la casa e di loggiati tutti attorno dimensionati per far entrare i raggi solari d’inverno e di schermarli nei mesi estivi sono diventati la strategia bioclimatica passiva dell’abitazione. Gli spazi serventi sono stati disposti nel lato nord e lungo la strada di accesso che lambisce la casa, permettendo alla zona giorno di aprirsi verticalmente con un doppio volume e orizzontalmente sui lati sud e ovest verso il parco, determinando con le grandi vetrate una continuità tra interno ed esterno. A mediare la loggia, progettata per accogliere la vegetazione. Ciò ha permesso al progetto di diventare a tutti gli effetti una autentica casa contemporanea toscana, in cui le virtù della tradizione si fondono con le innovazioni tecnologiche.
La funzionalizzazione del complesso di Palazzo Buontalenti si inserisce nel programma di espansione di EUI con la realizzazione di una nuova e prestigiosa sede. Il rapporto tra EUI e Firenze è consolidato da molti anni in un percorso di continua crescita che ha visto progressivamente aumentare il numero delle sedi: Badia Fiesolana, Villa Salviati, Villa Schifanoia, adesso Palazzo Buontalenti. Questo programma ha permesso negli anni l’instaurarsi di un virtuoso processo di valorizzazione di immobili demaniali prestigiosi e un loro utilizzo appropriato. Il primo passo per la realizzazione di questo programma è il restauro di una porzione del complesso buontalentiano, il cosi detto LOTTOZERO: il recupero di una porzione di circa 2000 mq al fine di allocarvi gli spazi della School of Transnational Governance. L’intervento prevede la creazione di spazi condivisi destinati allo staff di lavoro e spazi destinati ai ricercatori, impostati su modelli di co-working e corredati da aree per lo scambio tra persone e spazi attrezzati per ospitare incontri e riunioni. Il Lottozero è composto da un corpo di fabbrica su due livelli e un ammezzato (1600 mq), un cortile (600 mq) e il piano terra della ala nord del casino mediceo (400 mq). Ha accesso indipendente da via Cavour con il grande portale ad arco realizzato nel 1850. Si tratta sostanzialmente di una operazione di restauro, condotta in accordo con la Soprintendenza nel rispetto degli elementi costitutivi della architettura originale.
L’edificio di Palazzo agli Arcieri è stato realizzato con un cantiere aperto nel 2018 in un ex opificio industriale degradato. Nasce dall’idea di rigenerare questa area attraverso un progetto che ricucisse il tessuto urbano entrando in dialogo con le cinquecentesche Mura Medicee e il trecentesco Cassero Senese. Un dialogo sottolineato dall’assonanza formale tra il nuovo edificio e le preesistenze storiche, proponendo un volume compatto dalle vaste aperture orizzontali e dal tetto a forte spiovente. Questo progetto vuol riportare abitanti nell’area centrale della città che si sta invece spopolando, recuperando in qualche modo il valore abitativo del centro storico ,grazie a questa nuova residenza organizzata in sette appartamenti su quattro piani dove la distribuzione interna degli spazi è fatta in funzione della vista delle Mura. L’edificio è stato concepito nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente, improntato al raggiungimento della qualità della vita degli abitanti grazie alla distribuzione degli spazi e al trattamento dell’aria tramite un impianto integrato di climatizzazione e vmc. La struttura costruttiva a secco e gli infissi ad alto isolamento termico-acustico rendono l’edificio energeticamente prestazionale, raggiungendo la classe energetica A3. L’uso di pannelli fotovoltaici garantisce l’autosufficienza nella produzione di energia elettrica destinata alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda. Un modo per ridurre I consumi e la produzione di Co
La volontà del cliente era di riorganizzare gli spazi (modificati con più interventi che si sono succeduti negli anni) in modo più funzionale e rendere più omogenei gli interni. L’aspirazione era quella di ottenere un locale caldo e subito identificabile come ristorante di classe, e allo stesso tempo mettere in risalto la magnifica vista sul Ponte Vecchio da cui il ristorante prende il nome. Dopo un’attenta analisi del brand, si è deciso di riprendere e dare nuova vita e valore a quegli elementi del ristorante che nel tempo sono entrati nell’immaginario collettivo dei clienti così come dei semplici passanti: il marmo di Carrara che aveva caratterizzato l’area pescheria, l’ingresso e il bancone bar; i mobili contenitori per l’importante collezione di vini; i ricercatissimi prodotti gastronomici in bella vista. Il marmo di Carrara è stato utilizzato per costruire il frontale del nuovo bancone, con un gioco di sovrapposizione di volumi semplici tra lastre di alto spessore e tavolati di legno d’ulivo, utilizzati per il top. Il ritmo delle lastre di marmo, disposte con tre dimensioni diverse alternate, viene sottolineato da listelli anch’essi in legno d’ulivo. Sia il marmo che il legno rimandano al territorio, alla Toscanità, perché è da qui che il ristorante attinge i suoi ingredienti e la sua tradizione. Per rendere ancora più protagonista la vista, sono stati rimossi tutti gli elementi, murari o di arredo, che potevano essere di ostacolo, rendendola visibile fin dalla strada.
Il progetto, nel centro storico di Firenze, mira a trasformare una cappella rinascimentale quattrocentesca in uno showroom sperimentale per un’azienda di cucine – Officine Gullo. L’edificio, parte del complesso della chiesa di Ognissanti, ricca di dipinti di famosi maestri come Giotto, Ghirlandaio e Botticelli, nei secoli ha ricoperto le più disparate funzioni, da cappella funeraria, a cinema, da ristorante a night club. Il progetto vuole riportare questo spazio alla semplicità e purezza originali, senza rimuovere le alterazioni del passato. Con pochi interventi e modifiche specifiche ai materiali e al layout della circolazione, il progetto separa ciò che è vecchio da ciò che è nuovo, sottolineando la diversa storia dei singoli elementi. Il volume triangolare al centro, aggiunto negli anni ’80, viene liberato dai rivestimenti e mostra la sua struttura, dichiarando la propria diversità dalle parti originali della cappella e offrendo l’opportunità di creare uno spazio polifunzionale, trasformabile ed estremamente flessibile. Le scale vengono invece riportate nell’intercapedine tra la cappella e la chiesa di Ognissanti, originariamente staccate tra loro. Il concetto di showroom viene quindi reinterpretato, esponendo un’unica cucina attiva al centro dello spazio. La visita diventa un’esperienza museale, dove il visitatore prima ancora di conoscere i prodotti, viene a contatto con la storia della cucina italiana attraverso oggetti antichi esposti e video multimediali.
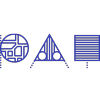
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix