

Non si tratta della “classica casa con giardino”, ma della sapiente declinazione in forma del concetto del vivere in consapevolezza dell’intorno e dell’ambiente: immersa nel verde delle colline toscane, la villa è concepita in modo da integrarsi e fondersi con il mondo naturale che la circonda. Il progetto interpreta, in chiave contemporanea, la tradizione costruttiva locale coniugando elementi tipologici, quali la copertura a falda e materiali ricorrenti (intonaco, legno e pietra) in un disegno architettonico che richiama, nel corpo principale, l’archetipo per eccellenza della casa, introducendo ampie vetrate, portici profondi ed un’addizione, dal sapore contemporaneo, in vetro ed acciaio. La zona notte e living, poste sullo stesso livello, si articolano secondo il concetto dell’open space: eliminati gli spazi-disimpegno, i necessari passaggi distributivi sono aperti e funzionalizzati con lo scopo di dare il massimo valore percettivo e fruitivo degli spazi. La zona all’aperto, in stretta relazione con l’ambiente interno, diventa elemento protagonista attraverso un continuo dialogo visivo tra il “dentro” ed il “fuori”. L’atmosfera di apertura è accentuata dal volume trasparente che sporge dal profilo principale e si immerge nella natura, eclissando totalmente la sensazione di qualsiasi confine.
I materiali e l’attenzione al contesto storico e ambientale rappresentano il fulcro del progetto; la reinterpretazione di elementi della tradizione ha consentito di trovare un nuovo linguaggio, una nuova estetica legata in maniera indissolubile alla tradizione. Il progetto prevede la ristrutturazione di un podere di 600 mq che si sviluppa su tre livelli: un piano terra che era adibito a locali di servizio per l’agricoltura, un piano primo con due appartamenti e un secondo piano, costituito da due torrette, a servizio delle abitazioni. Attraverso un nuovo assetto degli ambienti interni è stata ricreata un’abitazione unica cercando di rispettare i caratteri essenziali della tipologia tradizionale. Al piano terra sono stati posizionati i locali di servizio (tavernette, lavanderia, spa, garage), al piano primo la zona giorno e due suite, nelle due torrette sono state localizzate le suite di maggiore pregio. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta dei materiali di tutte le finiture ed in particolare i pavimenti risultano l’elemento caratterizzante dell’intervento. Nella scelta dei pavimenti e nella loro posa si riflette la filosofia dell’intervento che reinterpreta ed arricchisce di nuovi significati elementi della tradizione. Tutte le pareti sono finite a calce naturale stesa come da tradizione in maniera irregolare, per sottolineare la bellezza del materiale è stato scelto di non dipingere le pareti ma di lasciarle del colore della calce.
L’attuale fase di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Firenze si inserisce in una lunga scia di interventi che nel corso degli ultimi quattro secoli hanno interessato l’omonimo complesso. L’intervento si è sviluppato lungo due direttrici principali: l’inserimento di funzioni contemporanee con i necessari adeguamenti da una parte, e il mantenimento dell’integrità storica della struttura dall’altra. Il progetto ha lavorato per l’armonizzazione dell’insieme, studiando e analizzando, negli spazi esistenti al piano terra e al piano primo, le varie possibilità che rispondessero alle esigenze richieste dalle varie attività da insediare, unitamente alle indicazioni fornite dal maestro Franco Zeffirelli, senza però sminuire la natura di manufatto storico, architettonico e monumentale del complesso, raro esempio di architettura barocca a Firenze. Lo scopo è di suddividere gli spazi mantenendo una separazione netta tra le varie destinazioni, tutte comunque sempre in simbiosi tra loro attraverso la fluidità dei percorsi. Un recupero, con la creazione di un nuovo contenitore culturale dell’opera del maestro Franco Zeffirelli, grazie al riuso del complesso di San Firenze in risposta alle nuove funzioni, nel pieno rispetto e tutela di un edificio storico monumentale che potrà finalmente riaprire le sue porte alla città, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori occasionali, in stretto legame e simbiosi con il circostante patrimonio storico del tessuto urbano di Firenze.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Il progetto in piazza Gino Bartali rappresenta un esperimento attraverso il quale abbiamo unito la necessità di creare uno spazio polivalente che potesse accogliere, nel periodo estivo, un programma culturale di eventi e la volontà di costruire la base di un processo di riqualificazione a lungo termine. La struttura del progetto prevede trenta moduli funzionali alle principali esigenze per la fruizione dello spazio pubblico. Attraverso il movimento ed il gioco, l’intento è stato quello di innescare nuove interazioni tra gli abitanti e i luoghi della loro quotidianità. La strategia applicata, infatti, assume come fautori dei luoghi urbani gli stessi abitanti e attraverso essi ricerca una maggiore aderenza alle reali necessità. Primo tassello di un processo step by step, la flessibilità dell’intervento prevede un progressivo adattamento secondo scenari urbani possibili. Il progetto analizza e ripensa quindi i luoghi della città come insiemi aperti dove lo spazio urbano è il risultato di un meta-progetto comune. Purtroppo in fase esecutiva è stata negata, per questioni di sicurezza, la possibilità di dotare i moduli di ruote. Nonostante questa limitazione i feedback degli utenti sono stati possibili grazie a dei questionari presenti in loco. La scelta dei materiali ed il loro reperimento si inserisce all’interno di un modello di economia sostenibile definito circolare tramite il quale, una volta utilizzati, questi vengono reinseriti all’interno del loro processo produttivo.
Un muro recinto percorso avvolge i volumi essenziali dell’atelier disegnando spazi vuoti… spazi per l’arte. L’idea di Atelier alla base del progetto è che abbia le potenzialità per evolversi gradualmente nel tempo in un organismo più complesso, un polo delle arti contemporanee che possa ospitare mostre e performance, in stretto rapporto con il territorio e le sue specificità, con una grande attenzione alle accademie d’arte e in stretto contatto con i laboratori artigianali presenti nel luogo. Dalla corte centrale si svolge la rampa che, con la sua leggera pendenza, a spirale, dinamizza e mette in relazione tutti gli spazi esterni, penetra il corpo principale, lambisce le ampie terrazze e ridiscende infine nel cuore della collina per diventare un percorso ipogeo a supporto dello spazio di futura espansione previsto interamente scavato nel profilo della collina. La superficie del muro-percorso è realizzata con un impasto di terre e pozzolana steso su un sottofondo di giunchi intrecciati e parzialmente bruciati. Il muro ha il colore della terra, una pelle viva, mai uguale nel tempo, che seguirà il lento degrado del giunco, supporto ideale per la vegetazione che man mano lo sostituirà. Il progetto per sua vocazione pone grande attenzione ai materiali ed all’utilizzo di criteri di sostenibilità, in particolare è stato previsto l’utilizzo del legno per le strutture e una parte dei rivestimenti esterni. Pietra, fibre naturali, calce e argilla per gli altri rivestimenti esterni.
L’oggetto dell’intervento è stato la realizzazione di nuove volumetrie destinate ad accogliere spazi amministrativi, all’interno di un opificio industriale ad uso conceria. Nel dettaglio del progetto al piano terra viene ampliato l’ingresso e la reception e creati quattro locali uso ufficio e una sala riunioni. È stato realizzato inoltre un livello intermedio soppalcato, dove è stata collocata la sala campionaria. L’intervento ha inoltre portato alla rivisitazione completa dell’aspetto esterno che risulta ben integrato all’esistente grazie all’utilizzo omogeneo dell’acciaio corten come rivestimento e ad ampie vetrate che ne alleggeriscono l’impatto. L’utilizzo del corten, oltre a migliorarne l’aspetto estetico, ha aumentato anche le prestazioni energetiche dell’edificio poiché il pannello è coibentato. All’interno si trovano richiami al mondo naturale: una cascata realizzata su parete verticale in pietra che prosegue sul pavimento lasciando una traccia che funge da elemento separatore tra gli spazi; la presenza di due elementi vegetali di media dimensione (Bucida buceras) e di rivestimenti e forniture in legno di rovere naturale.
L’attuale fase di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Firenze si inserisce in una lunga scia di interventi che nel corso degli ultimi quattro secoli hanno interessato l’omonimo complesso. L’intervento si è sviluppato lungo due direttrici principali: l’inserimento di funzioni contemporanee con i necessari adeguamenti da una parte, e il mantenimento dell’integrità storica della struttura dall’altra. Il progetto ha lavorato per l’armonizzazione dell’insieme, studiando e analizzando, negli spazi esistenti al piano terra e al piano primo, le varie possibilità che rispondessero alle esigenze richieste dalle varie attività da insediare, unitamente alle indicazioni fornite dal maestro Franco Zeffirelli, senza però sminuire la natura di manufatto storico, architettonico e monumentale del complesso, raro esempio di architettura barocca a Firenze. Lo scopo è di suddividere gli spazi mantenendo una separazione netta tra le varie destinazioni, tutte comunque sempre in simbiosi tra loro attraverso la fluidità dei percorsi. Un recupero, con la creazione di un nuovo contenitore culturale dell’opera del maestro Franco Zeffirelli, grazie al riuso del complesso di San Firenze in risposta alle nuove funzioni, nel pieno rispetto e tutela di un edificio storico monumentale che potrà finalmente riaprire le sue porte alla città, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori occasionali, in stretto legame e simbiosi con il circostante patrimonio storico del tessuto urbano di Firenze.
La spa nasce all’interno dell’Hotel Grandvca di Grosseto, una struttura ricettiva di categoria quattro stelle. È stata concepita nella zona seminterrata dell’albergo, dove vi era un ampio spazio di circa trecento metri quadri una volta dedicata a garage. Il fulcro del centro benessere è la piscina, posizionata tra gli elementi strutturali dell’edificio costituiti da una serie di pilastri in cemento armato. Attorno a questa si sviluppano tutte le altre funzioni: il percorso con docce emozionali, il bagno turco, la sauna finlandese, la zona relax. Mentre in una zona soprelevata (filo piscina) si trova il percorso Kneipp, e separata da vetrata per evitare interferenze è stata posizionata l’area fitness. A causa delle travi rovesce della fondazione, una parte della piscina è stata realizzata fuori terra. L’accesso avviene attraverso una scala “nascosta” frontale all’ingresso, che serve anche la zona Kneipp. Al fine di sfruttare al massimo gli spazi e ampliare la piscina, tra i pilastri sono state inserite le sedute con getti per l’idromassaggio e getto cervicale, mentre una lama di acqua accentua l’apparato scenografico della parete di fondo. I pilastri sono stati collegati da “travi” a formare dei portali quasi fossero delle quinte e, ad enfatizzare l’effetto dei riquadri con luci perimetrali. Per la pavimentazione e il rivestimento è stato stato scelto un grès porcellanato effetto travertino di due tonalità dal beige al grigio come pure le pareti che si attestano sulla medesima tonalità.
Edificio pontremolese del XVIII secolo, Palazzo Damiani è parte privato –ancora in stato di abbandono– e parte comunale, affidato a ERP spa per la realizzazione di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica. Molto articolato, con tre corti, due scaloni monumentali, vani per depositi di merci, spazi commerciali, piano nobile e numerosissimi ambienti residenziali, affianca al restauro calibrato e rispettoso, con opere di consolidamento eseguite con materiali ad alta tecnologia ma di bassissimo impatto o realizzate con tecniche tradizionali per esaltare la materia antica, un progetto che ha arricchito lo spazio di nuovi modi d’uso per imprimere all’edificio la vitalità necessaria a superare il tema scontato di luogo di accoglienza ma anche isolamento per famiglie disagiate: le superfici “sprecate”, diventano ambienti comuni e condivisi ai vari piani, le corti coperte a vetri, luoghi di vita quotidiana, gli ambienti per i magazzini, centro per il coworking e il vano adiacente l’androne di ingresso verso il quartiere di San Giacomo si trasforma in galleria pubblica che caratterizza e apre il palazzo alla città insieme all’area di sosta, allo spazio verde con parco giochi e rampa di accesso inclusiva, al rinnovato rapporto con la zona extra moenia della stazione, di recente recuperata con ampio parcheggio scambiatore. L’intervento di ERP spa innesca e favorisce la rinascita dell’edificio storico integrando antiche funzioni e nuovi valori, urbani, architettonici e sociali.
Il progetto di riqualificazione di piazza Bianchini a Iolo, frazione di Prato, è figlio di una progettazione partecipata con la cittadinanza per realizzare un luogo di valore e di socializzazione per il paese. Prima dell’intervento la piazza era impostata in due settori, disposti in modo simmetrico attorno ad una vasca, che ospitavano le sedute e le alberature. La vasca era ormai in disuso da tempo, gli alberi ormai cresciuti troppo creavano un eccessivo ombreggiamento che aveva causato la completa degradazione del tappeto erboso con le parti verdi diventate zone in terra battuta. L’elemento centrale e fulcro del progetto è oggi la fontana a terra, che zampilla per offrire divertimento refrigerio ed effetto scenografico, attorno alla quale si organizzano con un movimento centripeto una serie di spazi diversificati con aiuole multiformi e spazi dedicati alla sosta e ai camminamenti. La piazza è oggi caratterizzata da tre pavimentazioni nei vari settori della piazza. La pietra arenaria che dal centro della fontana e con linee poste a raggiera orienta i visitatori, le piastrelle esagonali di cemento che individuano e marcano le isole della sosta e l’asfalto colorato fa da sfondo e coagula le forme della piazza. Ai toni caldi delle pavimentazioni si aggiungono le aiuole in corten, che contengono la vegetazione della piazza articolata per offrire colore e forme diverse durante tutto l’anno, con i grandi alberi che garantiscono ombra alle sedute e colore nel periodo di fioritura.
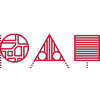
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix