

La libreria BRAC è uno spazio multifunzionale che offre una reinterpretazione dell’idea del classico café littéraire e comprende una libreria di arte contemporanea, un caffè e una cucina dove vengono preparati piatti vegetariani e vegani. Lo studio è intervenuto nella corte interna prima con un’installazione temporanea (realizzata in collaborazione con V. Muscedra e S. Leone), poi questa installazione si è evoluta e trasformata per rispondere ad un problema acustico ed con infine il progetto di restyling di tutti gli spazi che porta il locale alla configurazione attuale. Il cuore dell’intervento è la corte che collega visivamente le due sale principali: uno spazio caratterizzato da verticalità, colore, flessibilità, concepito con l’obiettivo di limitare la trasmissione del rumore alle residenze circostanti. Oltre 5.000 strisce di tessuto, di nove diversi colori, di lunghezze variabili, scendono dall’alto e coinvolgono il visitatore in uno spazio emozionale. Gli spazi del locale, seppur contenuti, sono stati resi più funzionali attraverso alcune soluzioni puntuali, come la trasformazione dell’ingresso, che ha portato a guadagnare uno spazio vetrina, la realizzazione di una una parete attrezzata in metallo che fa da filtro con la cucina, la sostituzione delle librerie esistenti con moduli a parete dall’ingombro ridotto. Sono stati ridisegnati gli infissi delle due grandi vetrate e sostituiti i rivestimenti interni ed esterni. È stato inoltre rinnovato il servizio igienico.
Rinnovamento di un appartamento sul lungomare di Lido di Camaiore in Versilia. Un ambiente unico adibito a soggiorno, studio, pranzo e cucina si affaccia sul mare, da questo si può accedere alla camera da letto e ai servizi, un deposito accessibile dal pianerottolo completa l’appartamento. Da ogni ambiente è possibile traguardare il Mar Tirreno. La spiaggia è entrata in casa. Le onde hanno scavato lo spazio e depositato legni chiari portati da lontano. Venti sabbiosi invernali hanno lasciato traccia del loro passaggio sulle facce di due blocchi di pietra, bianchi del marmo delle vicine Alpi Apuane.
Rinnovamento di un appartamento sul lungomare di Lido di Camaiore in Versilia. Un ambiente unico adibito a soggiorno, studio, pranzo e cucina si affaccia sul mare, da questo si può accedere alla camera da letto e ai servizi, un deposito accessibile dal pianerottolo completa l’appartamento. Da ogni ambiente è possibile traguardare il Mar Tirreno. La spiaggia è entrata in casa. Le onde hanno scavato lo spazio e depositato legni chiari portati da lontano. Venti sabbiosi invernali hanno lasciato traccia del loro passaggio sulle facce di due blocchi di pietra, bianchi del marmo delle vicine Alpi Apuane.
Nella cantina di una villa sulle colline di Firenze, a Pian dei Giullari, si è tentato di risolvere un problema attraverso un esperimento abitativo: convertire l’ambiente composto da un’unica stanza in un appartamento, non cadendo nell’errore di separare gli ambienti nettamente con pareti vere e proprie togliendo aria, luce, spazio e rimpicciolendo la percezione visiva della dimensione totale del volume; né tanto meno in quello di lasciare un ambiente unico indiviso e invivibile composto da zone con funzioni diverse separate solo idealmente da linee immaginarie (loft). Il principale talento di un architetto è quello di risolvere, con un unico gesto, il maggior numero di problemi progettuali. La soluzione, ovvero il gesto, che si adotta può essere formale o tecnica, ma l’importante è che risponda sempre al tentativo di una sintesi architettonica: “faire d’une pierre deux coups” o “to kill two birds with one stone”. In questo caso il gesto e il progetto coincidono. La soluzione è un cubo che divide e determina gli spazi. Non si deve però pensare al cubo come ad un’opera d’arte: “l’architettura non è un’arte, poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte” (A. Loos). Il cubo è in definitiva un mezzo, formale e tecnico allo stesso tempo, per arrivare allo scopo di convertire una cantina di una antica villa fiorentina in un appartamento in cui gli ambienti siano piacevoli e indipendenti tra loro; che poi era la sfida progettuale proposta dal committente.
Nella cantina di una villa sulle colline di Firenze, a Pian dei Giullari, si è tentato di risolvere un problema attraverso un esperimento abitativo: convertire l’ambiente composto da un’unica stanza in un appartamento, non cadendo nell’errore di separare gli ambienti nettamente con pareti vere e proprie togliendo aria, luce, spazio e rimpicciolendo la percezione visiva della dimensione totale del volume; né tanto meno in quello di lasciare un ambiente unico indiviso e invivibile composto da zone con funzioni diverse separate solo idealmente da linee immaginarie (loft). Il principale talento di un architetto è quello di risolvere, con un unico gesto, il maggior numero di problemi progettuali. La soluzione, ovvero il gesto, che si adotta può essere formale o tecnica, ma l’importante è che risponda sempre al tentativo di una sintesi architettonica: “faire d’une pierre deux coups” o “to kill two birds with one stone”. In questo caso il gesto e il progetto coincidono. La soluzione è un cubo che divide e determina gli spazi. Non si deve però pensare al cubo come ad un’opera d’arte: “l’architettura non è un’arte, poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte” (A. Loos). Il cubo è in definitiva un mezzo, formale e tecnico allo stesso tempo, per arrivare allo scopo di convertire una cantina di una antica villa fiorentina in un appartamento in cui gli ambienti siano piacevoli e indipendenti tra loro; che poi era la sfida progettuale proposta dal committente.
Nella cantina di una villa sulle colline di Firenze, a Pian dei Giullari, si è tentato di risolvere un problema attraverso un esperimento abitativo: convertire l’ambiente composto da un’unica stanza in un appartamento, non cadendo nell’errore di separare gli ambienti nettamente con pareti vere e proprie togliendo aria, luce, spazio e rimpicciolendo la percezione visiva della dimensione totale del volume; né tanto meno in quello di lasciare un ambiente unico indiviso e invivibile composto da zone con funzioni diverse separate solo idealmente da linee immaginarie (loft). Il principale talento di un architetto è quello di risolvere, con un unico gesto, il maggior numero di problemi progettuali. La soluzione, ovvero il gesto, che si adotta può essere formale o tecnica, ma l’importante è che risponda sempre al tentativo di una sintesi architettonica: “faire d’une pierre deux coups” o “to kill two birds with one stone”. In questo caso il gesto e il progetto coincidono. La soluzione è un cubo che divide e determina gli spazi. Non si deve però pensare al cubo come ad un’opera d’arte: “l’architettura non è un’arte, poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte” (A. Loos). Il cubo è in definitiva un mezzo, formale e tecnico allo stesso tempo, per arrivare allo scopo di convertire una cantina di una antica villa fiorentina in un appartamento in cui gli ambienti siano piacevoli e indipendenti tra loro; che poi era la sfida progettuale proposta dal committente.
Il contesto in cui è inserito l’ampliamento è un terreno collinare tipico della campagna toscana, utilizzato a giardino privato, dove sono presenti rade alberature tradizionali quali ulivi e cipressi. La costruzione di un piccolo edificio ad un solo piano – ampliamento di un edificio monofamiliare realizzato negli anni Novanta, a cui è collegato da un corpo leggermente arretrato – è stata realizzata con l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile che hanno garantito la classe energetica “A”. Il nuovo edificio è rivestito esternamente in doghe di legno ed ha una copertura piana ricoperta in ghiaia, mentre il corpo di collegamento con l’edificio preesistente è intonacato. L’intervento è stato poi completato dalla secondo corpo, interamente vetrato sui due lati liberi, con copertura leggera in tavolato di legno orizzontale. La struttura portante del corpo vetrato è in acciaio verniciato bianco mentre la struttura secondaria della copertura è realizzata con travetti in legno dal profilo allungato. L’altezza esterna ha permesso l’inserimento della costruzione al di sotto degli aggetti di gronda dei corpi di fabbrica preesistenti. Esternamente l’ampliamento è completamente circondato da un deck in legno. L’ampio aggetto della copertura in legno del corpo vetrato protegge i prospetti mentre a terra prosegue, anche internamente, la pavimentazione del deck in legno esterno.
La realizzazione della cappella per il DEAS della AOUC, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, ha rappresentato una delicata sfida progettuale, felicemente concretizzata. Il tema prevedeva di realizzare un nuovo locale dedicato al culto cattolico nell’atrio di distribuzione del Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità, in corso di completamento, all’interno di uno spazio di passaggio interessato dalla fitta maglia dei pilastri strutturali. La soluzione adottata presenta una linea architettonica morbida, femminile, che ha consentito di coniugare questo luogo sacro col contesto sanitario, delineando la sempre presente dicotomia umana tra corpo e spirito. La nuova cappella, con una capienza ordinaria di cinquanta persone, prevede la possibilità di rimuovere i pannelli perimetrali allargando lo spazio all’intero atrio per le funzioni più partecipate. La caratteristica tecnica del progetto di potersi dilatare fino a inglobare tutto lo spazio circostante assume qui una valenza allegorica di accoglienza universale. Il disegno in pianta si scosta notevolmente dalla rigidità delle pareti circostanti andando a creare una “mandorla” asimmetrica, svincolata dalla maglia strutturale esistente. Questa linea morbida nasce dalla ricerca di una forma avvolgente capace di accogliere all’interno i fedeli, ma anche di accompagnare con la sua curvatura le persone di passaggio nell’atrio. Per il design degli arredi sacri, è stato prescelto un linguaggio contemporaneo e innovativo.
Due case quasi gemelle costruite secondo i principi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico che dominano su una splendida valle dell’Appennino Tosco-Romagnolo. L’idea progettuale, delle due parti orizzontali del corpo di fabbrica incernierate su un elemento verticale rivestito in pietra, riflette l’immagine di un’apertura di ali che prendono il volo verso la valle. Particolare attenzione è stata data all’integrazione dei corpi edilizi con la morfologia del luogo, prevedendo quindi la tutela e la valorizzazione dell’impianto paesaggistico esistente. Gli edifici hanno una struttura portante in legno, coibentata internamente con fibra di legno e cappotto esterno in sughero, che conferiscono all’involucro, unitamente ai solai e al piano di copertura in legno lamellare, delle elevate performance in tema di risparmio energetico. L’impiego di materiali ecologici, garantisce una ottima traspirabilità e quindi un ambiente interno salubre con un confort abitativo elevato. Gli edifici sono dotati di un impianto meccanizzato di ricambio dell’aria, così da garantire costantemente condizioni igrotermiche ottimali; il riscaldamento-raffredamento a pavimento è alimentato da pompa di calore integrata ad un impianto fotovoltaico in copertura.
La casa è stata costruita in una radura tra ulivi, lecci e pini marittimi a metà collina tra la piana di Lucca e l’altopiano delle Pizzorne. Alla costruzione esistente sono stati aggiunti due ampliamenti, uno sulla testata nord-ovest, l’altro, parzialmente interrato, verso nord-est. La parte esistente è intonacata e tinteggiata a calce, quella nuova in pietra di Guamo (Verrucano dei Monti Pisani). Il fronte sud dell’ampliamento è un infilata di pilastri massicci a doppia altezza e i serramenti sono arretrati per ripararsi meglio dal sole e dall’acqua. Il volume dell’entrata della casa è l’unione tra il vecchio e il nuovo: a sud l’esistente mentre a nord una galleria si allunga per spingere il nuovo volume a trovare lo spazio libero e la vista verso valle e Lucca. L’infilata dei nuovi volumi inclinandosi verso nord-est facilitano l’apertura della corte verso il verde della radura. Le due facciate dell’entrata sono due portali uguali in pietra di Santafiora sabbiata, una è il fondale di un cortile stretto e lungo ed è l’entrata principale della casa, l’altra del cortile aperto verso il verde. I serramenti e le persiane sono in legno verniciato. I cortili e i marciapiedi sono in Santafiora sabbiata. Una scala è in ferro, l’altra è in ferro e legno wengé. Le tinteggiature interne sono chiare. La struttura del nuovo edificio è un telaio in c.a. con appoggiati il tetto a capriate e il solaio in travi e travicelli in legno di castagno. I nuovi edifici sono in classe energetica A3.
Progettare in un contesto paesaggistico ricco di storia come quello della campagna toscana ha costituito per Settanta7 una sfida irresistibile, colta portando all’interno di questo territorio una pratica dell’architettura contemporanea e sostenibile, un lieve gioco di linee e colori che dialoga con il paesaggio senese. L’asilo di Ponte d’Arbia, posizionato lungo la Francigena, si pone come obiettivo quello di divenire una scuola riconoscibile ma integrata con il paesaggio. La disposizione planimetrica mira a massimizzare il rapporto di permeabilità tra l’edificio e il paesaggio: gli spazi della didattica si affacciano verso l’esterno, e i colori della campagna si fondono nei prospetti color Terra di Siena. Il particolare profilo frastagliato della copertura genera un motivo unitario e riconoscibile che ricorda il profilo collinare della campagna senese. A partire dall’aspetto esterno dell’edificio, posizionando le finestre molto in basso, abbiamo voluto dichiarare con forza l’attenzione per una progettazione a misura di bambino. L’ampio spazio fluido attorno al patio centrale è dedicato ai diversi aspetti della didattica e caratterizzato da materiali e attrezzature che accentuano l’aspetto ludico. La struttura in x-lam, i pavimenti in linoleum colorato e gli arredi in materiali naturali contribuiscono a definire un ambiente e fresco e stimolante. Grazie alle caratteristiche tecnologiche dell’involucro, l’edificio raggiunge la classe energetica A.
La pizzeria osteria “Enry” come la conosciamo adesso nasce da un restyling di un’attività storica del paese di Cecina, aperta dal 1926: non un locale raffinato, ma famoso per i suoi prodotti da asporto come la pizza al taglio e la torta di ceci. Il fondo si trova sul corso pedonale principale del paese. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di mantenere nell’immaginario della cittadinanza il collegamento tra locale e tipologia di prodotti distribuiti, ma innalzare decisamente il livello dell’ambiente e aumentarne le funzioni. Avendo voluto ampliare l’attività delle sole merende pomeridiane con un servizio al tavolo di pizzeria e osteria, il principale obiettivo è stato quello di rendere l’ambiente più intimo e aver fatto sì che l’utente traesse piacere nel sostare per consumare sia una merenda che una cena. L’aspetto estetico è stato totalmente rivoluzionato: si è voluto comunicare in modo deciso che la nuova gestione avrebbe voluto innalzare il livello del servizio, aprendo il locale a un pubblico più ampio. Sono state prese le caratteristiche di un ambiente rustico e sono state ripulite da tutte le linee ridondanti e dai colori troppo classici. Il nuovo “Enry” ti accoglie con colori caldi ma non brillanti e con luci delicate e mirate a un preciso obiettivo. I materiali a contatto con la clientela sono gentili al tatto, sia che si tratti di travertino che di legno. Tutti gli arredi sono stati disegnati e realizzati su misura ad eccezione delle sedie e dei tavoli da esterno.
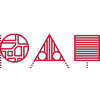
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix