

Il CENTRO*Arezzo trae spunto dal logo Coop e dalla relazione con la città storica. Il primo elemento caratterizzante del logo è il cerchio. La ripetizione di questa forma geometrica è l’elemento chiave dell’intervento. L’aggregazione di cerchi di diverso diametro, inseriti in una griglia geometrica, genera un pattern che viene declinato nell’edificio creando effetti percettivi variabili. Il secondo spunto del logo è quello della continuità tra le lettere, che conferisce ad esso una lettura unitaria. Allo stesso modo un nastro continuo diventa l’elemento generatore degli spazi, accompagnando il visitatore in un sentiero fluido e curvilineo. Il pattern genera una superficie bianca, forata, dai raccordi curvilinei che si articola nella facciata esterna, nel soffitto del percorso interno, sviluppandosi nelle facciate della piazza. La scansione degli ambienti del CENTRO*Arezzo e l’articolazione dei percorsi è tesa a ricreare la spazialità della città storica nei suoi elementi caratterizzanti: la strada e la piazza. Il nuovo profilo dell’edificio è teso a ricreare un dialogo con l’articolazione caratteristica della città, riproponendo un elemento verticale per accentuare l’ingresso principale e richiamare con un nuovo linguaggio le forme delle torri di Arezzo. La presenza del verde sia negli spazi esterni che in quelli interni accompagna il visitatore lungo i percorsi con una serie di aiuole circolari, ed insieme alla luce solare filtrata crea un ambiente dal carattere naturale.
La struttura nata come convento nella prima metà del sec.XVII viene adattata e trasformata in Casa di Pena intorno alla metà del sec.XIX finché nel 1984 con la costruzione del carcere di Sollicciano i detenuti vengono trasferiti nel nuovo penitenziario mentre quello di Santa Teresa viene dismesso. Il valore storico che emerge come carattere determinante di questo edificio viene recepito dal progetto che si propone di mantenere visibile la sedimentazione secolare di segni e interventi diversi valorizzando attraverso il recupero sia la memoria del carcere che quella più antica del convento e riportando alla luce quando possibile l’impianto originario di quest’ultimo. Approccio che ha guidato il riordino delle attività della scuola secondo una relazione tesa tra necessità funzionali e lettura delle diverse parti di stratificazione storica del complesso: la Facoltà di Architettura occupa i corpi a pettine che risalgono all’ampliamento carcerario dell’800; il Dipartimento di Progettazione occupa il nucleo dell’antico convento con i locali intorno al chiostro. Tra le due parti dove prima c’era un vuoto di risulta salvo minori collegamenti di servizio il progetto ricava la nuova spina distributiva con ingresso da Via Mattonaia. La nuova hall vetrata attraverso affacci e stacchi architettonici ad un unico tempo riconnette e tutela la lettura delle diverse parti nonché trascende la funzione distributiva per poter essere utilizzata come galleria espositiva e di dibattito con la Città.
Il Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso, è il frutto di oltre 35 anni di collaborazione tra il Comune di Arcidosso e l’Associazione Culturale Comunità Dzogchen di Merigar, un’associazione culturale senza scopo di lucro, diretta dal Prof. Namkhai Norbu, un professore in pensione di lingue tibetane e mongole presso l’Università orientale di Napoli.Molto importante per il successo dell’intero progetto, è stato il desiderio di utilizzare il museo per coltivare un dialogo tra le due comunità, vale a dire tra la comunità “tibetana” e la popolazione locale, per contribuire ad una maggiore comprensione interculturale e creare una armonia superando preconcetti.Per portare avanti questo obiettivo, si è ritenuto che fosse importante creare un’esperienza di “museo vivente” per i visitatori. Il tema centrale ed unificante di tutto il progetto è il mandala, questo tema è stato utilizzato sia sul piano concettuale museologico che sulla progettazione architettonica. Il mandala è una rappresentazione del cosmo, (microcosmo e macrocosmo) di fondamentale importanza nell’architettura sia buddista che indù.Si è deciso di creare una replica tridimensionale della cappella centrale del tempio Jokhang a Lhasa, dove risiede la statua Jowo Buddha, la più venerata e sacra.Abbiamo utilizzato l’interno di un Palazzo del 1700 per esplorare l’evoluzione dell’architettura monastica buddhista ed abbiamo creato un contenitore tridimensionale per un percorso di esperienze sensoriali e realtàaumenta
Nel museo abbiamo evocato l’antica facciata con un modello a grandezza naturale, basato sul disegno di Bernardo Poccetti, realizzato con membrature architettoniche in resina caricata con polvere di marmo su una struttura metallica e ricollocando le sculture nelle loro posizioni originali. La grande sala che un tempo era il Teatro degli Intrepidi (prima di diventare un malinconico garage) ora è un teatro dell’architettura e costituisce la scena fissa su cui si muovono le opere d’arte intrattenendo i loro mutevoli rapporti e i loro dialoghi con i visitatori. Sui due lati lunghi si confrontano due facciate: quella Arnolfiana (abitata dalle sculture) e quelle di marmo bianco con tre porte (quelle del Battistero) e trenta finestre. Dietro alla facciata di marmo bianco, su tre gallerie a diversi livelli, sono ospitate le statue antiche, quelle del campanile e i modelli storici per la facciata del duomo. Attraverso le finestre le statue dialogano con quelle della facciata. La parete traforata prosegue con lo stesso ritmo nei lacunari della copertura della grande sala, dove le aperture, fanno piovere la luce zenitale proveniente dai lucernari. Molte altre sale sono le sale del museo: accennerò solo a quella della Pietà. La Pietà ha avuto una storia travagliata, finalmente approdata al Museo… volevamo darle una collocazione serena, dove potesse trovare lo spazio e la luce che le era destinata, così sta su una sorta di mensa di pietra in una stanza alta sotto la luce che viene dall’alto.
Il progetto del Museo degli Innocenti fonda le sue ragioni sull’interpretazione del bene monumentale come struttura viva e rappresenta la sintesi tra le istanze di uso contemporaneo degli spazi museali esistenti e la valorizzazione di ambienti fino ad oggi inutilizzati. Il progetto risolve i problemi di accessibilità grazie ai nuovi ingressi sulla piazza, all’apertura di uno spazio al livello seminterrato e al nuovo sistema di distribuzione verticale che connette i vari livelli. Realizza un allestimento dedicato all’infanzia che valorizza tanto il patrimonio storico e artistico quanto il complesso monumentale di Brunelleschi. Riscopre e ridona alla città una grande loggia, il Verone, antico stenditoio del palazzo fiorentino, che grazie al progetto ha ritrovato la sua originaria apertura panoramica sulla città di Firenze, fruibile non solo ai visitatori del museo ma a tutta la cittadinanza. Due porte in bronzo azionate meccanicamente risolvono il problema dell’accesso dalla piazza. Le porte a geometria variabile interpretano l’idea di Brunelleschi di continuità tra interno ed esterno e con un gesto simultaneo rievocano la disponibilità dell’edificio ad “accogliere”. Il progetto museografico ha evidenziato le potenzialità delle aree espositive esistenti, integrandole in un sistema più ampio che comprende tutto l’edificio. Il percorso espositivo si articola dagli spazi del seminterrato, prosegue nella Pinacoteca del piano nobile e si conclude nella loggia panoramica del Verone.
Toscana Ricicla – piattaforma di comunicazione integrata che coinvolge 12 soggetti regionali, tra aziende pubbliche ed Enti (Regione Toscana, Revet, Quadrifoglio, Publiambiente, Seitoscana, …), legati all’economia circolare dei rifiuti – da quest’anno ha dato vita alla “Settimana della Qualità”, appuntamento periodico e itinerante che punta alla comunicazione e alla corretta informazione per innalzare la qualità dei materiali raccolti. Per questo l’Arch. Chiara Fanigliulo è stata incaricata di progettare uno stand che ospiti conferenze ed incontri e che mostri cosa si può produrre dal riciclo di materia. Il padiglione, inaugurato a Novembre 2016 in Piazza Repubblica a Firenze e che nei mesi a venire si sposterà in varie città della Toscana, utilizza materiali provenienti dalla filiera del riciclo: profili, rivestimenti, pavimentazioni e coppi in plastica, arredi in cartone, una rastrelliera in acciaio, oggetti in alluminio, bottiglie di vetro, decorazioni di carta, tutto rigorosamente ottenuto dal riciclo. I setti, dati da un gioco di “pieni-vuoti” di profili, orientati lungo gli assi diagonali dello stand, aprono lo spazio e individuano 4 aree: area espositiva, ambiente chiuso ravvivato da luci e verde; area kids, provvista di casetta per bambini; area garden, con parete di verde verticale; area lounge, allestita con arredi in cartone riciclato e coperta da un tetto trasparente, che contribuisce a mantenere il contatto e l’integrazione del padiglione con l’intorno.
Una “striscia” edificata che richiama l’immagine delle mura urbane e tre elementi che vi si addossano: un elemento “lineare” , un elemento a “capannone industriale” ed un elemento “torre”. I tre elementi sono composti ed uniti a formare una sorta di “trancia” di tessuto urbano caratterizzato proprio dal tema dell'”addossamento”, dalla convivenza simbiotica di quattro parti. Come il Ponte Vecchio che dichiara la compresenza dei due elementi fondanti con identità distinte e diverse quali il corridore e le “casette degli orafi”, Come i centri fortificati nei quali la crescita interna per stratificazioni successive ha condotto le case ad addossarsi alle mura, Come nelle fortezze trasformate in borghi proprio attraverso l’addossamento delle case lungo il perimetro interno delle mura. Da questi “modelli” storici di architettura spontanea si è formato il progetto che tende a regolarizzare quattro elementi “conosciuti” in una composizione tipologico-figurativa analogica. Il progetto si fonda quindi sull’aggregazione di quattro parti singolari, dove ad ogni singola funzione corrisponde una singola “fisionomia” (forma, aperture, colori,etc.). Tre elementi (il “capannone”, la “torre”, il “palazzo” ) sono racchiusi e raccolti da un quarto elemento (il “muro”) e sono rivolti sulla piazzetta nella quale convergono tutti i principali accessi verso l’interno della costruzione che ospita funzioni di accoglienza,uffici amministrativi,residenze provvisorie,mensa, servizi generali.
La Villa colonica del ‘400, oggetto dell’intervento di recupero, si trova nel comune di Monteriggioni (SI) a pochi passi dallo splendido castello della Chiocciola. La Villa è stata attribuita da alcuni studiosi all’opera di Baldassarre Peruzzi, pittore e architetto senese che operò in zona ad inizio XV secolo. L’intervento si concentra sul piano nobile di circa 400 mq con la realizzazione di un appartamento moderno e funzionale dotato di ogni confort. L’idea portante del progetto è stata quella di usare due registri paralleli, quello quasi filologico del restauro delle parti originali e quello assolutamente contemporaneo dei nuovi interventi e dell’arredo. Ne è scaturito un insieme in cui le due parti dialogano con espressioni anche molto diverse, ma con la costante ricerca di una sintesi finale comune. I nuovi ambienti funzionali al nuovo programma abitativo sono stati realizzati come scatole isolate dipinte con smalto bianco lucido che non arrivano mai al soffitto, ma si fermano prima, per ospitare temi di illuminazioni con luce a led. I nuovi pavimenti della zona giorno sono stati realizzati in resina cementizia di color ocra chiaro. I pavimenti della zona notte sono invece tutti realizzati con un parquet in legno di quercia naturale ossidata trattato a calce. Tutti gli arredi della casa, ad eccezione di qualche oggetto di recupero, sono stati realizzati su disegno e prodotti da artigiani locali come pezzi unici e irripetibili.
La Villa colonica del ‘400, oggetto dell’intervento di recupero, si trova nel comune di Monteriggioni (SI) a pochi passi dallo splendido castello della Chiocciola. La Villa è stata attribuita da alcuni studiosi all’opera di Baldassarre Peruzzi, pittore e architetto senese che operò in zona ad inizio XV secolo. L’intervento si concentra sul piano nobile di circa 400 mq con la realizzazione di un appartamento moderno e funzionale dotato di ogni confort. L’idea portante del progetto è stata quella di usare due registri paralleli, quello quasi filologico del restauro delle parti originali e quello assolutamente contemporaneo dei nuovi interventi e dell’arredo. Ne è scaturito un insieme in cui le due parti dialogano con espressioni anche molto diverse, ma con la costante ricerca di una sintesi finale comune. I nuovi ambienti funzionali al nuovo programma abitativo sono stati realizzati come scatole isolate dipinte con smalto bianco lucido che non arrivano mai al soffitto, ma si fermano prima, per ospitare temi di illuminazioni con luce a led. I nuovi pavimenti della zona giorno sono stati realizzati in resina cementizia di color ocra chiaro. I pavimenti della zona notte sono invece tutti realizzati con un parquet in legno di quercia naturale ossidata trattato a calce. Tutti gli arredi della casa, ad eccezione di qualche oggetto di recupero, sono stati realizzati su disegno e prodotti da artigiani locali come pezzi unici e irripetibili.
La necessità di ampliare la scuola primaria I Ciliani nasce per soddisfare la domanda di spazi didattici in quest’area del territorio. E’ stato realizzato un edificio che ha incrementato le aule didattiche, i laboratori, la mensa e un archivio. La superficie è di mq 1300 disposta su due piani oltre al seminterrato e si attesta sulla struttura della scuola esistente su un asse est-ovest a confine con la proprietà. Le aule sul giardino sono dotate di grandi vetrate con lamelle frangisole. Sul lato nord le finestre sono a nastro e sono posti i percorsi distributivi dei piani. In copertura è presente un lucernario che illumina gli ambienti sottostanti fino al piano terra mediante un taglio vetrato nel solaio del piano primo. Le murature esterne hanno caratteristiche termiche ed acustiche rispondenti alle normative, negli ambienti sono presenti pannelli in fibra di legno colorati per eliminare il fenomeno di riverbero del rumore, il riscaldamento è a pannelli radianti a soffitto e tutta la scuola è dotata di connessione wifi. Esternamente sul confine è stato utilizzato un rivestimento in lamiera microforata di alluminio spessore 20/10 anodizzata montata su struttura in acciaio zincata. Vicino all’ingresso e al camminamento pedonale il rivestimento è caratterizzato da un disegno con alcuni alberi che richiamano la vegetazione esistente nel giardino scolastico e dà una propria connotazione all’intervento.
Piazza Carducci si configura, oggi, come il centro dell’insediamento di Seravezza e, in quanto tale, presenta una spiccata valenza polare, a livello sia funzionale che sociale. L’origine peculiare di tale spazio, creatosi in seguito alla deviazione dell’alveo del torrente Vezza, ha fatto sì che un elemento divisorio, un corso d’acqua, desse luogo a degli assi unificanti e ad un nuovo polo, univocamente riconosciuto come centro cittadino. Tale trasformazione ha comportato una serie di incoerenze a livello di tessuto edilizio: la zona a monte e quella a valle, prima separate nettamente dal torrente e quindi poco collegate tra loro (si transitava dall’una all’altra attraverso un ponte), una volta venuto a mancare l’elemento di discontinuità, sono entrate fisicamente in contatto. Il progetto di Piazza Carducci, oltre a ridisegnare tutti gli spazi contermini attraverso una nuova viabilità, si concentra sulla parte basamentale con nuovi materiali e un disegno completo del luogo centrale del capoluogo di Seravezza. Il progetto realizzato ha previsto nuovi elementi scultorei, inserti di essenze arboree elementi luminosi e nuove sedute ed una pavimentazione in calcestruzzo architettonico arricchita da inerti in marmo.
Oggi, ciò che era uno spazio anonimo, dove era impossibile svolgere dignitosamente le manifestazioni pubbliche e commerciali, è divenuto un luogo dove le rappresentazioni di teatro dialettale e le altre forme di spettacolo legate alla vita cittadina sono divenuta regola. Il progetto, in definitiva, attraverso un’indagine sulle regole che governano lo spazio urbano si è agganciato alla storia urbana delle piazze italiane, al contenuto che esse devono esprimere, in termini di socialità e spazi da abitare.
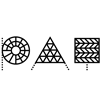
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix