

Il progetto sì è posto l’obiettivo di riqualificare l’area prospiciente la Chiesa della Vergine (Arch. G. Michelucci) attraverso la demolizione di un edificio fatiscente costruito nel dopoguerra e la costruzione di un nuovo centro polifunzionale destinato ad attività pastorali e di servizio. Centrale è la ricerca di un rapporto di forte interazione con gli spazi esterni, oltre che per l’attenzione alla sostenibilità ed all’efficienza energetica. La cappella feriale presenta una marcata interazione con lo spazio esterno, mediata da un portico ed un sagrato; ciò emerge sia in termini di percezione visiva che di continuità spaziale dei percorsi. La sistemazione interna tende a privilegiare l’accoglienza e il movimento visivo legato ai giochi di luce. L’articolazione delle aperture ha permesso di dotare la cappella di una multiforme luce naturale con “lame di luce” che, durante il giorno, valorizzano in particolare i luoghi della liturgia. Gran parte della copertura è occupata da pannelli fotovoltaici che alimentano gli apparecchi illuminanti a led e l’impianto di climatizzazione a pompe di calore, con una potenza di 15 Kw in regime di scambio sul posto. Si tratta di un impianto che possiamo definire “ibrido”, in quanto i moduli non sono integrati in senso stretto (ossia in sostituzione di parti della copertura) ma ne seguono la morfologia e l’inclinazione e sono collocati in apposite “vasche di alloggiamento”, ricavate nel profilo della copertura metallica in zinco-titanio.
La Casa comunale vuole essere punto di riferimento energeticamente efficiente e sostenibile per la popolazione di una area montana periferica, scelta strategica del committente per avvicinare i propri servizi con ridotti costi di gestione e fornire un esempio concreto alla cittadinanza di buone pratiche architettoniche e costruttive. Ospita un ambulatorio medico, una medicheria, un punto servizi e una sala polivalente idonea ad accogliere diverse tipologie di iniziative ed eventi sia pubblici che privati. È realizzato con struttura in pannelli di legno X-Lam e isolamento termico in fibra di legno, fibra di canapa e sughero. Il legno utilizzato per le finiture e gli arredi è della specie douglasia (pseudotsuga menziesii) di produzione locale proveniente dalle foreste del demanio regionale. Le scelte progettuali hanno mirato a inserire l’edificio armoniosamente nel contesto, senza rinunciare a caratterizzarlo, e a ottimizzarne il comportamento bioclimatico e passivo, in modo che la ridottissima richiesta di energia possa essere quasi integralmente coperta dalla produzione dei pannelli fotovoltaici. Questo con uno sguardo all’utilizzo dei materiali, e in particolare delle finiture esterne, improntato a un’estetica finalmente libera da quell’accanimento contro il sano e naturale invecchiamento che rischia spesso avvelenare i nostri edifici e l’ambiente, ma saldamente basato su quelli accorgimenti tecnici indispensabili per far durare nel tempo un edificio a struttura lignea.
Il contesto ambientale in cui è inserito il progetto fa parte della prima fascia collinare alle spalle dì Montecatini Terme destinata, per la sua pregevole valenza paesaggistica, prevalentemente a residenze mono familiari di villeggiatura . L’accentuato declivio del lotto che dalla strada si dirige verso il fondo valle ha suggerito uno sviluppo altimetrico che asseconda l’andamento del terreno risolvendo così la volumetria su un solo livello al pianoterra e portando la zona notte sul piano inferiore traslata di un modulo. La casa si presenta chiusa sul fronte strada e si apre con pareti interamente vetrate sul lato interno rivolto al paesaggio collinare, proiettandosi al suo interno con un volume estroflesso e compenetrandosi con il contesto verde. La struttura é costituita da una parte basamentale in cemento armato al livello inferiore su cui poggia lo sbalzo in acciaio rivestito con un sistema a secco. La casa é realizzata con i massimi criteri di efficienza energetica e si inserisce nel contesto naturalistico con un linguaggio architettonico assolutamente contemporaneo che cerca attraverso l’utilizzo di materiali naturali quali i legni , le pietre e la scelta di colori neutri recuperati dalla natura stessa l’integrazione con ciò che la circonda. Il progetto interpreta il desiderio e dei sui familiari di far vivere a EDOARDO , affetto dalla nascita da una grave forma di disabilità, la magia del contesto naturalistico in cui è nato ad ogni ora del giorno è della notte.
Romanico è un intervento realizzato nel centro storico di Pistoia, in un’area a lungo dimenticata. Il processo di recupero di questo spazio, a cura dell’associazione Spichisi, intende valorizzare l’area di Piazzetta Sant’Atto e Vicolo dei Bacchettoni attraverso un programma di residenze artistiche ed eventi correlati. Questo luogo oggi, grazie ad un patto di collaborazione e gestione dei beni comuni, stretto tra l’associazione, alcuni residenti e l’amministrazione comunale, prende il nome di Giardino di Cino. Il progetto fa forza sulla particolare scala di questo luogo, trasformandolo da vicolo dimenticato in spazio pubblico, intimo e raccolto, una sorta di giardino inaspettato popolato da interventi artistici e dispositivi di aggregazione sociale. La prima fase, Romanico Automatico, consiste nella realizzazione di un disegno a terra frutto di un’astratta, seppur rigorosa, manipolazione dei temi compositivi dell’architettura romanica. L’intervento si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità dell’area mediante l’uso di una matrice grafica ben radicata nell’immaginario comune dei cittadini pistoiesi, instaurando un dialogo di continuità e trasformazione con i numerosi esempi di architettura romanica del centro storico. La seconda fase, realizzata a distanza di due anni a causa dell’emergenza Covid, ha visto l’installazione di dispositivi pensati per la seduta e funzionali allo svolgimento degli eventi curati dall’associazione in programma per primavera 2022.
Un cubo di cemento appoggiato su di una lama d’acqua ed un muro a secco, sospeso su un campo di ulivi e affacciato sulla pianura che vede Firenze all’orizzonte. Concrete Barn è un edificio destinato al tempo libero ed alla convivialità. È il fienile contemporaneo di una residenza tradizionale appoggiata sulle colline del Montalbano; costruito come un tubo di cemento, aperto sullo spettacolare paesaggio che lo fronteggia, il cui cannocchiale ottico è filtrato da una membrana costruita prendendo a prestito le trame di mezzane di laterizio che ombreggiano gli interni dei fienili tradizionali. Al suo interno spazi dedicati alla convivialità, al tempo libero ed alla contemplazione. Una cucina, un forno a legna, un tavolo, un piccolo servizio sono tutto quello che serve. Il paesaggio è parte dell’architettura, reso ancora più interessante dalla vibrazione imposta dalla trama di laterizio. All’esterno il volume del forno e del camino sono rivestiti della stessa pietra dei muri a secco della campagna circostante. Cemento, pietra e laterizio si completano nel segno d’acqua della piscina, scavata nella superficie netta dell’aia, rivolta verso le colline vicine ed il lontano orizzonte della pianura. Aia di pietra chiara e di legno grigio, ombreggiata da una pergola leggera e circondata da un giardino naturale e stagionale (landscape arch. Bellesi-Giuntoli). Acqua e cemento, mattone e pietra, superfici lisce soleggiate che dialogano con facciate ombrose e materiche.
L’edificio, a pianta rettangolare, è costituito da tre ambienti contigui e comunicanti: uno destinato alla cucina-cambusa; un secondo con carattere polifunzionale e l’ultimo occupato dai servizi. Esteticamente, il fabbricato si presenta come un poliedro a base rettangolare la cui sezione trasversale riproduce l’immagine elementare della casa con tetto a due falde. Per sottolineare questa forma primigenia i due lati minori sono stati rivestiti con una lamina brunita di rame, la stessa che ricopre il tetto a capanna. La scelta è stata dettata anche dalla necessità di proteggere efficacemente le murature, recuperando la pratica presente nel nostro Appennino di coprire con lamiere le facciate più esposte alle intemperie. Le due pareti lunghe, protette dalla sporgenza delle gronde, sono foderate con tavole di legno di abete al naturale; identica essenza per i portelloni delle aperture. La scelta di nascondere le componenti tecnologiche e dunque di concepire i canali di raccolta delle acque meteoriche come due fessure in prossimità delle gronde e di incassare i canali discendenti all’interno delle murature è stata dettata dalla volontà di far risaltare la pulizia formale del volume. La tecnica costruttiva adottata è la muratura portante. Questo nuovo edificio, pur rifacendosi a criteri tipologici e costruttivi propri della nostra Montagna, intende rifuggire facili e falsi esiti mimetici nella ricerca di un appropriato rapporto con il contesto ambientale.
Il progetto ha visto la realizzazione di un nuovo centro direzionale, in ampliamento dei locali della sede centrale della Banca Alta Toscana – Credito Cooperativo, con il fine di realizzare un polo di aggregazione a favore sia della stessa banca che della comunità di Quarrata (Pistoia). Al piano primo del nuovo edificio si trovano uffici (circa 750 mq) che si sviluppano sui fronti est – sud – ovest, ovvero sopra l’atrio d’ingresso ed il corpo servizi dell’auditorium, in corrispondenza del prospetto posteriore della Sede della banca, cui si collega con una passerella sospesa in acciaio e vetro, nonché sopra il deposito e l’archivio cartaceo. L’accesso avviene dal vano scale/ascensore e blocco servizi posto in posizione baricentrica, vano che si sviluppa poi – per permetterne l’accesso agli addetti alla manutenzione – fino alla copertura, ove sono collocati i vani tecnici – in parte coperti ed in parte a cielo aperto – e la schiera dei pannelli fotovoltaici. Al vano scala d’accesso principale si aggiungono altre due scale aperte, quali vie di esodo a norma di legge, in acciaio, collocate alle due estremità del piano primo. Il piano terra invece è destinato a funzioni per la collettività ed il sociale; vi troviamo infatti la grande aula/auditorium con capienza di 850 posti, per conferenze, assemblee, mostre, esposizioni temporanee e manifestazioni della Banca, mentre sul fronte della viabilità pubblica, si trovano altri spazi con funzioni collegabili all’attività sociale.
L’idea progettuale lavora sul tema “della scatola nella scatola” per riqualificare lo spazio operativo degli uffici della sede della Confcommercio di Pistoia. L’edificio è un parallelepipedo a base quadrata (36×36 metri) costruito nel 1970 con una tipologia prossima all’edilizia industriale più che a quella ad uffici. Gli elementi strutturali verticali posti secondo una maglia quadrata ad interasse costante di 6 metri, ripartiscono e vincolano lo spazio. Le scelte progettuali sono state orientate ad articolare gli ambienti interni così da creare flussi, spazialità e dinamiche rispondenti alle necessità degli spazi di lavoro sia “aperti” che “confinati”. Il progetto ha come fulcro la zona centrale, nella quale lo stare e l’attraversare, la relazione e l’incontro sono azioni che lo spazio sottolinea caratterizzandosi rispetto all’intorno per materiale, altezza e illuminazione. Il concept è stato sviluppato partendo da quattro parole chiave; sostenibilità, accessibilità, flessibilità ed informatizzazione, che sono state declinate nelle loro diverse accezioni all’interno del programma edilizio. Dal punto di vista funzionale il progetto si organizza con una pianta a “ferro di cavallo” che si sviluppa sul perimetro dell’edificio per quanto riguarda gli uffici “operativi” e racchiude al suo interno un “cuore”, uno spazio posto in relazione visiva con gli uffici convenzionali che è l’area di rappresentanza per la nuova sede della Confcommercio. Lo spazio del “Futuro Anteriore”.
L’idea progettuale lavora sul tema “della scatola nella scatola” per riqualificare lo spazio operativo degli uffici della sede della Confcommercio di Pistoia. L’edificio è un parallelepipedo a base quadrata (36×36 metri) costruito nel 1970 con una tipologia prossima all’edilizia industriale più che a quella ad uffici. Gli elementi strutturali verticali posti secondo una maglia quadrata ad interasse costante di sei metri, ripartiscono e vincolano lo spazio. Le scelte progettuali sono state orientate ad articolare gli ambienti interni così da creare flussi, spazialità e dinamiche rispondenti alle necessità degli spazi di lavoro sia “aperti” che “confinati”. Il progetto ha come fulcro la zona centrale, nella quale lo stare e l’attraversare, la relazione e l’incontro sono azioni che lo spazio sottolinea caratterizzandosi rispetto all’intorno per materiale, altezza e illuminazione. Il concept è stato sviluppato partendo da quattro parole chiave; sostenibilità, accessibilità, flessibilità ed informatizzazione, che sono state declinate nelle loro diverse accezioni all’interno del programma edilizio. Dal punto di vista funzionale il progetto si organizza con una pianta a “ferro di cavallo” che si sviluppa sul perimetro dell’edificio per quanto riguarda gli uffici “operativi” e racchiude al suo interno un “cuore”, uno spazio posto in relazione visiva con gli uffici convenzionali che è l’area di rappresentanza per la nuova sede della Confcommercio. Lo spazio del “Futuro Anteriore”.
Il progetto nasce come sostituzione di una vecchia serra per accogliere la crescente collezione di agrumi durante i mesi più freddi. Coltivatori per passione, i proprietari desideravano un nuovo padiglione per il riposo invernale delle piante, una piccola architettura dove sostare in silenzio e meditazione tra di esse. Il nuovo volume si inserisce in un terrazzamento della collina attenuando il contrasto fra natura ed architettura, fra forme organiche e frammento artificiale a cui i ritmi prospettici e le vibrazioni tridimensionali delle scansioni lignee dei listelli donano una solenne domesticità. Le facciate sono realizzate con assi di legno grezzo di larice naturale fissate alla struttura interna in larice lamellare assieme ai pannelli in policarbonato opalino. La superficie della copertura in continuità con il fronte sud rivolto verso la campagna circostante, mantiene l’integrità del volume elementare e la forma dinamica come solidificata. Oltre a soddisfare alcune funzioni pragmatiche, il progetto si è sviluppato per divenire una ricerca sulla traslucenza e sul rapporto fra natura e architettura. Durante il giorno, mentre i pannelli in policarbonato diffondono la luce del sole il padiglione diventa un corpo traslucido, a differenza della notte in cui diviene una lanterna scultorea fluttuante nell’orizzonte delle colline. Un’architettura in grado di ascoltare la specificità del luogo inserendosi nel paesaggio come un ulteriore frammento di paesaggio.
Il progetto nasce come sostituzione di una vecchia serra per accogliere la crescente collezione di agrumi durante i mesi più freddi. Coltivatori per passione, i proprietari desideravano un nuovo padiglione per il riposo invernale delle piante, una piccola architettura dove sostare in silenzio e meditazione tra di esse. Il nuovo volume si inserisce in un terrazzamento della collina attenuando il contrasto fra natura ed architettura, fra forme organiche e frammento artificiale a cui i ritmi prospettici e le vibrazioni tridimensionali delle scansioni lignee dei listelli donano una solenne domesticità. Le facciate sono realizzate con assi di legno grezzo di larice naturale fissate alla struttura interna in larice lamellare assieme ai pannelli in policarbonato opalino. La superficie della copertura in continuità con il fronte sud rivolto verso la campagna circostante, mantiene l’integrità del volume elementare e la forma dinamica come solidificata. Oltre a soddisfare alcune funzioni pragmatiche, il progetto si è sviluppato per divenire una ricerca sulla traslucenza e sul rapporto fra natura e architettura. Durante il giorno, mentre i pannelli in policarbonato diffondono la luce del sole il padiglione diventa un corpo traslucido, a differenza della notte in cui diviene una lanterna scultorea fluttuante nell’orizzonte delle colline. Un’architettura in grado di ascoltare la specificità del luogo inserendosi nel paesaggio come un ulteriore frammento di paesaggio.
Il progetto fa seguito ad un concorso di progettazione nazionale promosso dalla Provincia di Pistoia del quale il gruppo è risultato il vincitore. La Fonderia d’Arte Michelucci ha rappresentato un esempio significativo della storia produttiva ed artistica pistoiese del XX secolo, in stato di abbandono dal 1979. Abbiamo individuato gli elementi di permanenza capaci di dare continuità al segno urbano da sviluppare in nuove forme ed espressioni coerenti con il programma funzionale. Le murature costituenti i fronti corti dell’impianto originario a capanna, quelle della torre dei modelli, il muro storico esterno su via dell’Anguillara sono stati consolidati e ripristinati nella loro forma e posizione originarie. Le nuove funzioni sono state ricercate sul resede dell’impianto generale della ex fonderia optando per soluzioni seminterrate (lo spazio di attività) e completamente interrate (spazio di servizio) rendendo alla sua antica originaria funzione lo spazio verde aperto, eliminando le superfetazioni accumulatesi all’intorno. Lo spazio viene individuato dalla traslazione dell’originario piano a quota terra in modo da lasciar passare la luce per illuminare lo spazio interno di attività a quota meno tre metri inteso come traslazione verticale negativa, raggiungibile tramite una rampa continua dalla quota dell’ingresso che garantisce un disimpegno accessibile di tipo urbano. La capanna diviene ideale copertura dello spazio tecnico sul tetto dove sono previsti pannelli solari e fotovoltaici.
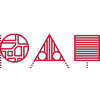
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix