

L’intervento in oggetto prevede l’armonizzazione e quindi una sensibile rigenerazione di un complesso edilizio attraverso il recupero del corpo principale, ovvero una “capanna” storica e di un attiguo “corpo secondario” realizzato successivamente e privo di qualità architettonica. Il volume principale, già indicato nelle antiche carte del Catasto Leopoldino, è stato oggetto di un intervento attento, oculato, sensibile, volto a mantenere inalterata la lettura architettonica e razionale dello stesso nonostante la suo nuova destinazione abitativa. All’interno, le opere strutturali in carpenteria metallica con funzione di sostegno del nuovo tetto ventilato e del parziale solaio di mezzeria, sono state pensate e realizzate per essere ben visibili e quindi senza nascondere o alterare la natura strutturale principale del volume storico composto da una muratura perimetrale portante. Il corpo secondario, alla luce dell’assenza di elementi architettonici da tutelare, è stato oggetto di una totale rigenerazione anche attraverso la realizzazione di una pelle esterna in legno larice non trattato e quindi pronta a mutare nel tempo raggiungendo dolcemente dei cromatismi in perfetta simbiosi con l’adiacente massa muraria. L’immagine finale si compone quindi di un architettura lineare, il corpo secondario avrà il compito di relazionarsi con la forza espressiva della capanna in pietra, contribuendo a dare impeto e valore ad un insieme compositivo basato su un equilibrio cromatico e strutturale
Il progetto architettonico elimina ogni superfetazione, concentrandosi sulla razionalità e sulla pulizia stilistica. L’idea architettonica determina un oggetto di facile lettura, composto da pochi elementi e materiali; un oggetto trasparente sollevato da terra attraverso uno zoccolo di rete stirata metallica scura, caratterizzato da una facciata continua strutturale in vetro selettivo che ha sostituito le vecchie pareti esterne per lo più opache. Internamente la grande hall di ingresso è in continuità con lo show-room, volutamente posto al piano dell’officina e delimitato da alte vetrate trasparenti, reso così visibile e strettamente connesso alla quotidiana attività dell’azienda. Gli uffici sono flessibili e trasparenti, la corte del primo piano contribuisce a ulteriore luce naturale. Il risultato finale è quello di un complesso produttivo moderno, minimale e razionale, energeticamente performante, funzionale nei relativi spazi interni, un edificio luminoso e illuminato.
Sistemazione dell’area su cui erano state realizzate le prime opere di messa in sicurezza a seguito dell’eccezionale alluvione del 2011 che ha cancellato in modo quasi indelebile lo storico complesso che insisteva nell’area, costituito da una fontana, un lavatoio coperto e una gradonata di accesso alla parte superiore dell’area che si ricollegava all’area del parco pubblico (pregevole impianto di sequoie e tuie dei primi del ‘900). Il progetto propone, in primo luogo, il recupero funzionale di tale luogo nel modo più equilibrato possibile, senza procedere ad una ricostruzione filologica dei volumi distrutti procedendo con una integrazione fisica e funzionale delle parti mancanti. L’intervento mira ad un futuro e più ampio progetto di valorizzazione architettonica, naturalistica e funzionale dell’area, attraverso la realizzazione di opere e manufatti che possano amplificare le potenzialità dell’area, integrandone le funzionalità con un più ampio sistema di percorsi e aree verdi attrezzate. L’ area è luogo della memoria dell’evento alluvionale che così fortemente ha segnato il territorio nel 2011, i cui segni visibili sono rimasti concentrati in questo fazzoletto di terra, tra un suggestivo parco di storico impianto e un torrente tornato a essere gioioso e affascinante con le sue cascate e pozze limpide e profonde. Memoria ma anche nuova vita attraverso la realizzazione di un nuovo spazio dove le testimonianze fisiche sono recuperate e integrate, “rifunzionalizzate” con opere.
Il tentativo di citazione difficilmente può essere relegato all’interno di ambiti definiti o limitati poiché, superando schematismi, classificazioni e tendenze, attinge con estrema spontaneità e libertà all’inesauribile patrimonio tipologico e formale della tradizione contadina traendo da essa gli elementi essenziali propri di un amplissimo e inesauribile abaco lessicale. L’elemento di ispirazione è la casa, ovvero il suo archetipo e quindi origine ed essenza della casa stessa. Il progetto richiama, nella sua impostazione generale, un’immagine primordiale e sintetica della dimora rurale toscana, riprodotta nella molteplicità delle sue varianti nei disegni dei quaderni e impressa nei ricordi d’infanzia. La capanna monolitica, rievocazione della casa primordiale (microcosmo, rifugio, protezione, intimità), è composta da elementi essenziali: l’attacco a terra, il muro (dominio dell’architettura), la copertura, enfatizzata dal grande camino (coronamento e rimando al cielo). L’impianto che ne consegue ricerca l’unitarietà architettonica che si traduce in un blocco articolato sulla massa muraria volta a sottolineare, con l’unità materica, una tettonica semplificata. La stessa costruzione tettonica viene enunciata dall’attacco alla terra: un basamento alto staccato sessanta centimetri dal piano di campagna che intende instaurare con il suolo una relazione di intima continuità, una sorta di naturale concrescenza.
L’immobile oggetto di intervento è un grande appartamento ubicato all’ultimo piano di un condominio degli anni ’70, al limitare del centro storico di San Casciano verso la bella campagna del Chianti Fiorentino, in una zona con caratteristiche paesaggistiche di pregio. Un approfondito studio di fattibilità, fatto a monte della compravendita, si è focalizzato sulla possibilità di ristrutturare l’unità immobiliare nella distribuzione interna, nel design e nelle finiture. Dopo diverse soluzioni progettuali, è stata trovata una versione che riuscisse a fondere lo stile desiderato con le funzionalità richieste, rimanendo nel budget. Il progetto si è così concretizzato unendo le necessità del Committente, intendendo sia le richieste funzionali che economiche, la struttura dell’immobile, che dava poco margine di intervento, alle scelte progettuali intraprese. Si è così costituito un susseguirsi di ambienti luminosi dal design pulito e lineare, zona living, cucina e pranzo collegate da ampie aperture, una zona notte divisa da quella giorno ma unita a questa dal pavimento in listoni di legno e da una pallette di colori che fa da trait d’union in tutto il percorso visivo.
La cultura del progetto e il legame tra committente illuminato e creativo libero: investire nell’architettura e nel progetto per dare una nuova immagine ai propri spazi di lavoro. L’immobile oggetto di intervento è risultante di interventi realizzati negli anni ’70 e di successive modifiche esterne ed interne realizzate fino ad oggi. Per adeguarsi alle sempre maggiori sfide future, l’azienda ha deciso di modificare la disposizione di aule, uffici e master-plan aziendale, oltre all’istallazione di un ascensore. Prendendo spunto dal lavoro flessibile si è deciso di cambiare la disposizione degli uffici attuali, le forniture e le attrezzature di quelli futuri per creare uno spazio più agile. In questo sforzo di modernizzazione che ha intrapreso con tanto impegno, l’azienda ha deciso di attrezzarsi per rendere la vita lavorativa più semplice e piacevole, praticando politiche di lavoro flessibili che facciano recuperare alle persone il piacere di lavorare, l’affezione verso il proprio posto di lavoro e una comunanza di intenti con il proprio datore di lavoro. Il committente si è presentato con Il Manifesto della Sede del Futuro nel nostro studio, da qui siamo partiti, destreggiandoci fra le normative e le visioni, fra una struttura esistente e lo spazio che non basta mai, tra i tempi strettissimi e la volontà di chiudere l’azienda meno giorni possibili, fra creare spazi diversi e flessibili, egocentrici, ma la necessità di avere anche zone per la gestione di tutti gli impianti.
“Procchio for all” è un progetto di spazio pubblico contemporaneo che integra accessibilità e valorizzazione del luogo, attraverso lo sviluppo di soluzioni in grado di potenziare/incrementare l’uso della spiaggia in/a favore di un’utenza il più ampia possibile anche al di là della stagione turistica. L’intervento si colloca alla fine della passeggiata a mare sulla spiaggia di Procchio, unico golfo con comodo ed esteso arenile presente nel comune di Marciana all’Isola d’Elba. Il sito scelto per il progetto rappresenta un luogo di ritrovo per i giovani grazie anche alla vicina palestra. Utilizzato per attività sportive, oggi risulta essere uno spazio di socialità e di aggregazione importante anche nei mesi fuori stagione. Durante l’estate la spiaggia è meta privilegiata da associazioni legate alla disabilità. Il risultato è un’architettura in legno di iroko, realizzata completamente a secco in grado di garantire a tutti l’accesso all’arenile recuperando attraverso l’uso pubblico il rapporto tra contesto antropizzato ed elementi naturali. Una piattaforma continua, sempre fruibile, diventa rampa per l’accesso al mare e seduta per vivere la spiaggia in tutte le stagioni. La pedana è anche basamento per il punto accessibile: un piccolo volume che ospita al chiuso i locali di servizio igienico e spogliatoi, idonei ad accogliere anche persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, ed include in esso uno spazio coperto ma aperto dedicato a docce pubbliche.
Il Museo delle Arti in Ghisa nella MAremma è una scatola magica, dove muri secolari convivono con le ultime tecnologie multimediali. Un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio alla scoperta della culla della siderurgia italiana, in uno straordinario monumento di archeologia industriale. Il MAGMA nasce dalla volontà di raccontare la storia tecnologica, artistica e umana dello stabilimento siderurgico di Follonica nel momento massimo della sua produzione. Per buona parte dell’Ottocento, l’edificio che ospita il museo funziona infatti come un modernissimo forno fusorio per la produzione della ghisa: il San Ferdinando. Il nuovo allestimento interattivo e multimediale ridona vita al vecchio forno, con un percorso espositivo che si snoda in tre grandi sezioni, una per piano. L’arte, al piano primo, espone l’alto livello di specializzazione e raffinatezza raggiunto dalle fonderie di Follonica. La storia, al piano secondo, esamina le ragioni di quel genius loci che ha permesso a questa terra di venire sfruttata a livello siderurgico per millenni. La produzione, al piano seminterrato, mostra il complesso sistema tecnologico utilizzato dallo stabilimento per la fusione della ghisa. Attraverso documenti e testimonianze, filmati e ricostruzioni, l’esposizione aiuta così a comprendere quale complesso di relazioni viene innescato con la creazione di questo piccolo, ma storico stabilimento.
Il paesaggio della riserva naturale dei Monti Rognosi ha ospitato, sin dall’epoca etrusca, attività minerarie legate all’estrazione di rame e ferro. I suoi rilievi sono costituiti da rocce ofiolitiche di origine magmatica, ricche di minerali. La lavorazione dei metalli avveniva nella Ferriera, costruita lungo il torrente Sovara per sfruttarne l’energia idraulica. Il grande “stabilimento metallurgico” si estendeva per circa 1.200 mq e si sviluppava su due piani. L’area, al momento dell’intervento di recupero e riqualificazione, risultava abbandonata da decenni e le archeologie erano quasi completamente ricoperte di terra e di piante infestanti. Il progetto è stato principalmente rivolto al recupero del “grande muro” trasversale dello “stabilimento metallurgico”, rinvenuto durante gli scavi archeologici, e alla riqualificazione degli spazi aperti contigui ai ruderi della Ferriera. Quest’ultimi interventi hanno garantito l’accessibilità all’area archeologica, la sua fruibilità e la protezione delle parti pericolose per l’incolumità dei visitatori. È stata infatti pavimentata l’area di fronte al “grande muro”, con la riproposizione di una delle due ellissi riportate nella cartografia storica, raffiguranti le basi dei forni fusori. Le sistemazioni hanno inoltre interessato l’argine fluviale, degradato dalle continue esondazioni, attraverso il consolidamento con massi di provenienza locale che hanno creato un manufatto artificiale integrato con l’ambiente naturale circostante.
L’edificio, che risale alla prima metà del Novecento, ospitava una distilleria e poi un’officina meccanica. La posizione su un importante asse di comunicazione ha suggerito un’ipotesi di recupero dell’immobile per destinarlo a spazio espositivo per le arti visive. All’esterno, un grande portale in ferro grezzo segnala, sulla piccola corte privata, l’ingresso allo spazio espositivo. Lo spessore di pochi centimetri dell’infisso esistente è sostituito da uno di quasi due metri. Il portale raccorda i due spazi, assumendo il ruolo di tramite fisico tra interno ed esterno, dilatando la soglia. L’ampia copertura a volta e il pavimento, seppure molto usurato, sono stati conservati in una filosofia progettuale che intende riflettere sul possibile rapporto tra preesistente e nuovo. Il nuovo si sovrappone al preesistente seguendo il principio della stratificazione: sulle pareti perimetrali si appoggia un rivestimento leggero, ad altezza variabile. Sull’asse longitudinale dell’aula, una sequenza di cinque celle cubiche di lato tre metri, aperte su un lato e prive di copertura. Vuoti che riempiono il vuoto. Un basamento della stessa dimensione in pianta, ma alto solo un terzo del lato di base, apre la sequenza. I volumi sono staccati tra loro: pause che consentono di traguardare, lasciando scoprire l’effettiva larghezza della sala. Un percorso anulare consente l’accesso alle stanze espositive, che si lasciano scoprire nell’alternanza di pieni e vuoti che caratterizza la composizione.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, con sede in Firenze via ponte di Mezzo, aveva necessità di avere uno spazio in cui poter confrontarsi con i suoi associati, tenere conferenze e corsi di formazione. Il progetto di ampliamento della sede ha dato risposta a questa esigenza creando una sala conferenze da quaranta posti a sedere oltre ad area break, reception, tre uffici e servizi. Non essendo possibile, per motivi di spazio, realizzare un collegamento interno abbiamo riprogettato la scala condominiale, utilizzata soltanto dall’associazione Ebret, che oltre al primo piano del fabbricato occupa anche il secondo ed ultimo, oggetto dell’intervento. Lo spazio disponibile per sala conferenze aveva una forte dominanza longitudinale che abbiamo cercato di interrompere mediante l’introduzione di tre portali luminosi, in modo da suddividere lo spazio in quattro campate. Le lampade a striscia led continua abbinate ai faretti da incasso tondi sono regolabili per intensità ed accensione, per creare scenari adattabili ad usi diversi, come ad esempio le conferenze o le proiezioni. Le pareti dogate con finitura in pelle sono di tipo acustico, così come il controsoffitto per garantire un ottimo confort sia per i relatori sia per gli ascoltatori. Tutti gli impianti della sala, acustici, illuminotecnici, lo schermo e le tapparelle oscuranti sono gestibili da remoto.
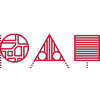
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix