

La Legnaia “Campo alla Cesta” rappresenta una piccola architettura che va a sostituire un precedente annesso precario di lamiera ponendosi nel paesaggio come sintesi fra tradizione e modernità per fornire una risposta convincente all’inserimento di un fabbricato in un contesto sensibile. Evocando da un lato le tradizionali capanne in legno e paglia, con falde di copertura molto inclinate, che punteggiavano un tempo la zona, ma palesando la sua contemporaneità con la pulizia del volume, l’assenza delle sporgenze di gronda e l’unitarietà del rivestimento di parete e copertura. La progettazione ha dovuto tenere conto che il fabbricato sarebbe stato realizzato in auto-costruzione dal proprietario. La struttura è un telaio in legno di castagno irrigidito da pannelli in scaglie di legno orientate. Le strutture sono protette per durare nel tempo, il rivestimento esterno di sacrificio in sciaveri di castagno (scarti della lavorazione di segheria), coniuga il basso costo con la possibilità di ottenere una tessitura materica in grado di evocare un’elevata sensazione di naturalità. Utilizzata per la conservazione di legna e attrezzature per l’orticoltura della famiglia, è accessibile dai due lati corti, uno dei quali è protetto da un loggiato. L’elevata pendenza delle falde permette un proficuo utilizzo del sottotetto come rimessa. Processo di progettazione partecipato dalla committenza che si è fortemente autoidentificata nel risultato di riqualificazione architettonica e paesaggistica.
La struttura dell’Arsenale si presentava in uno stato di degrado, privo di copertura, delle grandi arcate, dei piani di calpestio ed era completamente invaso dalla vegetazione con un rinterro di circa due metri oltre la quota medievale; di fatto si trattava di un vero e proprio rudere seppure di grande fascino. La ricostruzione e il restauro degli Arsenali Repubblicani ha affrontato diversi temi, dalla scoperta dei resti archeologici, dalla ricerca storica, alla ricostituzione filogica che ha guidato le scelte progettuali, agli interventi strutturali di rilevanza sismica fino all’inserimento degli impianti tecnologici necessari per la pubblica fruizione. L’agibilità dei locali prevede attività culturali, museali, di pubblico spettacolo ed auditorium con capienza fino a seicento persone per cui l’immobile ha una attrattività gestionale significativa soprattutto perché si tratta di un bene storico straordinario monumentale che si offre non soltanto alla città di Pisa ma al turismo internazionale. La valorizzazione degli Arsenali Repubblicani contribuisce in ogni caso alla conservazione del patrimonio culturale, allo sviluppo intelligente e sostenibile, fornisce infrastrutture e servizi culturali, promuove l’industria culturale e creativa, rendono attraente la cultura e usano la cultura per unire le comunità. Il risultato raggiunto fa immergere il visitatore nell’antica Terzanaia medievale all’interno degli arsenali che nella contemporaneità trovano l’originario splendore.
La sala polifunzionale del complesso delle Felci, si trova all’interno dell’oasi naturalistica WWF del Dynamo Camp (struttura dedita alla terapia ricreativa, in cui vengono ospitati bambini affetti da gravi patologie, in gruppo o accompagnati dalle famiglie). È stata ricavata dalla ristrutturazione di un lungo corpo di fabbrica, denominato La Malga, in origine destinato a stalla per bovini. Esigenze di tempi costruttivi particolarmente contenuti e la volontà del committente di realizzare un edificio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, hanno stimolato la soluzione progettuale di una “struttura nella struttura”. Del fabbricato esistente rimanevano le sole murature esterne, quindi è stato deciso di inserire all’interno del perimetro murario una struttura prefabbricata in legno, con pareti a telaio e copertura su capriate leggere con tiranti metallici. Le altre esigenze erano quelle di avere una sala versatile e adatta a diverse funzioni (sala da pranzo, aula didattica, con predisposizioni anche per corsi di cucina, e sala conferenze) ma senza far palesare le numerose dotazioni impiantistiche necessarie. Tutti gli impianti corrono a pavimento, compresi i canali di mandata e di ripresa dell’aria, e si dipanano all’interno delle contropareti interne fino alle due cornici sommitali che corrono sui lati lunghi dell’aula. Gli infissi sono riquadrati da telai in legno che “incorniciano” vedute del bosco estremamente suggestive.
La proprietà si trova nel centro del paese e vi insistono la “chiesa vecchia”, un edificio di cui si hanno notizie già nel 1383 e la “chiesa nuova”, ultimata nei primi anni Settanta. Il rapporto tra i due edifici non è mai risultato armonico. I nuovi locali di ministero pastorale oggetto dell’intervento sorgono in aderenza e direttamente collegati alla chiesa nuova. L’intento del progetto è stato quello di generare aree esterne di cerniera, ricucendo le zone di relazione e creando un continuum tra chiesa vecchia, sagrato, ampliamento, chiesa nuova e giardino, in modo da imprimere valenza urbana e vitalità all’intero organismo, come fulcro socio-religioso e luogo di aggregazione. Davanti alla chiesa vecchia si apre ora una sorta di piazza, un nuovo nucleo. Un grande portale incornicia la vetrata che fronteggia e riflette l’antico portico; ampie aperture mettono i nuovi locali in diretto contatto con lo spazio a verde retrostante; si aprono interessanti scorci prospettici. Dal punto di vista compositivo, è stato reinterpretato il linguaggio architettonico della chiesa nuova: volumi netti, grandi falde in contropendenza, pareti inclinate, patii. Il rivestimento metallico esterno, la tipologia degli infissi, i materiali interni per esprimere leggerezza e semplicità. Contestualmente si è provveduto al recupero delle pareti della chiesa nuova, caratterizzate da importanti episodi di deterioramento, rivestendole con la medesima tecnologia dell’ampliamento, ma variandone cromia e orditura secondo il disegno preesistente.
La proprietà si trova nel centro del paese e vi insistono la “chiesa vecchia”, un edificio di cui si hanno notizie già nel 1383 e la “chiesa nuova”, ultimata nei primi anni Settanta. Il rapporto tra i due edifici non è mai risultato armonico. I nuovi locali di ministero pastorale oggetto dell’intervento sorgono in aderenza e direttamente collegati alla chiesa nuova. L’intento del progetto è stato quello di generare aree esterne di cerniera, ricucendo le zone di relazione e creando un continuum tra chiesa vecchia, sagrato, ampliamento, chiesa nuova e giardino, in modo da imprimere valenza urbana e vitalità all’intero organismo, come fulcro socio-religioso e luogo di aggregazione. Davanti alla chiesa vecchia si apre ora una sorta di piazza, un nuovo nucleo. Un grande portale incornicia la vetrata che fronteggia e riflette l’antico portico; ampie aperture mettono i nuovi locali in diretto contatto con lo spazio a verde retrostante; si aprono interessanti scorci prospettici. Dal punto di vista compositivo, è stato reinterpretato il linguaggio architettonico della chiesa nuova: volumi netti, grandi falde in contropendenza, pareti inclinate, patii. Il rivestimento metallico esterno, la tipologia degli infissi, i materiali interni per esprimere leggerezza e semplicità. Contestualmente si è provveduto al recupero delle pareti della chiesa nuova, caratterizzate da importanti episodi di deterioramento, rivestendole con la medesima tecnologia dell’ampliamento, ma variandone cromia e orditura secondo il disegno preesistente.
La sistemazione di un appartamento su due livelli –secondo e terzo piano– cerca di adattare l’esistente, frutto di continui rimaneggiamenti, alle nuove esigenze abitative. Caratteristica peculiare dello stato di fatto sono gli scarti, le imperfezioni i piccoli e continui cambi di quota che rappresentano sia un ostacolo da arginare che un’occasione per connotare le dinamiche della casa. Questo raumplan naturale generato delle sovrascritture del tempo si manifesta già dall’ingresso, che malgrado si trovi al secondo piano introduce a quattro gradini verso il basso ed alla zona di distribuzione principale, al centro della quale si posiziona la scala. Questa viene pensata come corpo che poggia su di un podio costruito ex novo. L’intervento si incastra all’interno dei dislivelli esistenti come grande meccanismo che attraverso un solo gradino uniforma i flussi del piano. La pavimentazione in corda dell’ingresso interrotta con il parquet, che a sua volta viene posato con diversa orditura in modo da denunciare il dislivello presente. La scala, costruita attraverso un telaio in legno di frassino e tamponata con fogli di paglia di Vienna tirati poggia su un grande podio impiallacciato in legno di rovere. Un elemento in graniglia evidenzia l’imbocco della rampa e si pone come soluzione di continuità tra un piano e l’altro. La camera padronale è il risultato di un’interpretazione radicale nel modo di vivere il tempo del riposo: non avere nient’altro che il letto sul quale dormire.
Il progetto si concentra in un importante revisione degli interni con l’intento di qualificare e restituire all’abitazione spazi aperti per l’utilizzo conviviale e luoghi privati per esigenze familiari. Dove necessario si rimuove elementi murari incongrui enfatizzando ambienti unici distinti dalle fasce di servizio integrate nella progettazione con rivestimenti e dettagli su misura. Si privilegiano atmosfere differenti nella luminosità e nei colori ma legate da ricordi di finiture e disegno. L’accoglienza della casa avviene in un nucleo centrale costituito dalla sala giorno, luogo unico longitudinale composto da una successione eterogenea di fondali: libreria, studio, diaframma di disimpegno, armadiatura integrata, seduta in pietra e focolare, cassettiera, guardaroba. L’ingresso trasposto in asse si pone come inizio e fine di un concetto di arredo che si prospetta continuum vario nei diversi utilizzi ma uniforme-omogeneizzante nella sua composizione. Il legno di rovere della pavimentazione, che assorbe le ombre sfumandone i bordi, si ritrova nelle superfici degli arredi laccati di bianco o laminati di azzurro nebbia. L’innesto della scala è definito da tre gradini rivestiti in pietra serena spazzolata che continua come grande mensola di appoggio del camino. Il luogo del fuoco descrive un’atmosfera calda e colloquiale grazie ai rapporti tra seduta, illuminazione e poltrone.
Il Museo Novecento di Firenze è dedicato all’arte italiana del XX secolo e propone una selezione di circa 300 opere distribuite in 15 ambienti espositivi, oltre ad una sala studio, un gabinetto disegni e stampe ed una sala per conferenze e proiezioni. La sede espositiva è l’antico Spedale delle Leopoldine di piazza Santa Maria Novella. I locali che ospitano il museo sono ambienti storici ristrutturati che presentano dimensioni eterogenee, discontinuità spaziali, di dettagli e di finiture. Per raggiungere la continuità nel progetto abbiamo articolato lo spazio attraverso setti liberi che nascono, al primo piano, dal pavimento in ferro e al piano superiore dalle contropareti laterali. La finalità di questa scelta è duplice: la visione il più possibile libera degli ambienti esistenti, dall’altro lato interpretazione innovativo del progetto museologico. L’idea espositiva principale è caratterizzata da una sospensione libera delle opere nello spazio. La trascrizione architettonica è un sistema espositivo costituito da pannelli che non si differenziano dai cromatismi principali delle sale, ma anzi assumono i materiali ed i colori in base alla superficie da cui nascono: i pannelli verticali che nascono dal pavimento sono in ferro, quelli che nascono dalle pareti sono del colore e del materiale delle pareti.
Il nuovo quartier generale della Forti spa, situato tra Pisa e Livorno, ospita gli uffici e il centro direzionale del gruppo aziendale. Il centro rappresenta un chiaro esempio di architettura sostenibile. Le performance energetiche dell’edificio sono diretta conseguenza di una progettazione attenta agli aspetti bioclimatici; lo studio delle superfici opache e trasparenti è studiato in base al loro specifico orientamento. A piano terra, una grande hall accoglie i visitatori e si apre in una grande facciata ventilata. La facciata sud-est è invece caratterizzata da grandi vetrate continue schermate da frangisole lineari. Queste scelte si riflettono all’interno in ambienti di lavoro con vista aperta sul verde. Il verde è presente anche all’interno dell’edificio con giardini pensili e terrazze rivestite in materiali naturali, contribuendo alla regolazione del microclima. La facciata sud è stata interamente rivestita con pannelli fotovoltaici. Grazie allo sviluppo di apposite soluzioni architettoniche, l’involucro diventa il primo impianto tecnologico dell’edificio. Insieme all’involucro è stato sviluppato un apparato impiantistico all’avanguardia, che impiega impianti di illuminazione LED, un sistema geotermico per la climatizzazione degli spazi interni e recuperatori di calore. Il mix di fonti rinnovabili e fanno di questo complesso un punto di riferimento per l’edilizia sostenibile di tutta la Regione Toscana, che ha ottenuto la certificazione di sostenibilità LEED Gold.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Vi è stato un periodo (fine XVI secolo) in cui Lucca si presentava come città “picta” grazie all’estro di Agostino Ghirlanda, artefice di una nuova frenesia decorativa delle dimore lucchesi riscontrabile nei graffiti che avrebbero reso il Palazzo Dipinto uno degli episodi più suggestivi ed apprezzati di un certo gusto di decorazione urbana. È in questo scorcio di città che si trova uno degli edifici più antichi, nato come stazione di posta ma che oggi rivive come prestigioso boutique hotel. L’aura e l’aspetto tradizionale degli ambienti sono stati preservati ed armoniosamente integrati con un linguaggio contemporaneo ed attuale: il piano terra, destinato a welcome area (hall, bar e giardino d’inverno), è ampiamente illuminato da luce naturale sia grazie alla valorizzazione delle grandi aperture esistenti che alla struttura in acciaio e vetro del giardino, posto nel cuore dell’hotel. È, inoltre, visibile la tessitura muraria originale, lasciata a vista nella zona della hall, così come anche gli elementi lignei del solaio di copertura. Le venti stanze, al piano primo e secondo dell’edificio, sono state progettate in modo da integrarsi con la struttura storica esistente, mantenendo quanto possibile gli elementi originari senza tralasciare le necessità della nuova realtà. Particolare attenzione e cura sono state poste anche nella progettazione degli elementi di arredo, pensati e disegnati per ogni tipologia di alloggio, prediligendo l’utilizzo di materiali, tessuti e finiture di pregio.
Tutto è collegato: l’ombra e la luce, il negativo ed il positivo, il nero ed il bianco, l’amore ed il dolore, il bello ed il brutto, perché la vera armonia si raggiunge anche attraverso l’accettazione degli equilibri tra momenti diversi. Il progetto vede la riconversione di una vecchia stalla in nuova residenza, dislocata su due piani. L’intenzione progettuale è stata quella di mantenere l’impronta originaria, esaltando i materiali autentici ed affiancandoli a lavorazioni contemporanee. Sul pavimento in resina scura poggiano i vecchi scalini in pietra che conducono al piano primo la cui muratura è stata lasciata a faccia vista e trattata in maniera uniforme con il resto delle superfici verticali mentre i prospetti esterni sono stati interamente preservati e mantenuti sia nell’aspetto materico che formale. Il risultato parla di ambienti che, seppur pensati e modellati come un unico organismo, riescono ad evocare sensazioni eterogenee, frutto di spazi colmi di identità propria grazia anche al continuo dialogo tra dentro-fuori.
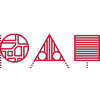
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix