

L’intervento intende recuperare e integrare un vecchio presidio già adibito ad orfanotrofio sito su una porzione di territorio collinare prossima al centro storico di San Miniato. Riattivandone le connessioni relazionali attraverso il riuso dei “vicoli carbonari” utilizzati fino al secolo scorso dai carbonai per portare il carbone in città ed attraverso il riutilizzo di percorsi nel bosco circostante il plesso per garantire la sorveglianza e la manutenzione dei versanti. Il progetto “Casa Verde”, così storicamente chiamata per la forte valenza sociale (Casa/orfanotrofio – Verde/immersa in un bosco di Lecci), è di fatto una ricerca di legami di fratellanza: 1_Con il bosco, per mezzo dello studio delle sfumature di colore che le foglie hanno nelle diverse stagioni; 2_Con le “ragazze ospiti”attraverso la rilettura dei loro lavori grafici riportati attraverso il lettering adesivo sulla facciata in vetro; 3_Con la città tramite il recupero dei “vicoli carbonai” (utili e necessari per la manutenzione dei versanti); 4_ Con la ricerca verso la luce naturale (filtro vano scala principale); 5_Con il vecchio paesaggio attraverso il mantenimento del filare secolare di cipressi tangenti alla struttura. 6_Con l’arte attraverso l’artista Mercurio-S17S71 che rileggendo il volto degli “ospiti” ha creato una collezione di opere contemporanee.
Il progetto riguarda il completo recupero di un magazzino industriale in abbandono per la realizzazione della nuova Sede di un importante Studio Legale. L’immobile si trova all’interno di un isolato nella zona otto-novecentesca a ridosso dei Viali ed occupa l’intero piano terra di un edificio del 1960 ed una piccola costruzione adiacente posta nel cortile tergale. La planimetria dell’esistente, caratterizzata da una grande profondità del corpo di fabbrica e dalla conseguente scarsità di aperture in rapporto alle grandi superfici disponibili, è stata risolta con la creazione di una “piazza interna” che costituisce uno spazio polifunzionale posto all’interno dell’edificio dove, oltre ad essere il cuore del sistema distributivo dello Studio, è anche sala di lettura e spazio per ospitare incontri e seminari. Lungo le pareti sono presenti una serie di nicchie che contengono i numerosi volumi della biblioteca dello Studio alternate alle aperture che, grazie a pannelli scorrevoli, danno l’accesso a tutti gli uffici. Nella palazzina adiacente sono collocati gli studi direzionali ai quali si accede, seguendo il lungo banco in legno della reception, salendo una scala a sbalzo con gradini che aggettano da un setto murario rivestito in travertino con finitura “cannetè”. I prospetti sul cortile sono stati ridefiniti così come l’accesso che dalla strada conduce all’interno dell’isolato dove un lungo “tappeto” in legno posto sulla ghiaia del cortile accompagna i visitatori verso l’ingresso
Castagneto Carducci è un borgo tra i più suggestivi della Costa degli Etruschi ed è dove nasce l’ex Officina del Gusto, un caffè con cucina. Il contesto vede i centri storici svuotarsi e diventare come delle cartoline piuttosto che essere fulcri della vita sociale, sempre più attività chiudono e le rimanenti non tengono il passo coi tempi. Nasce quindi l’esigenza di un rinnovamento generale che va dal ripensare un intero contesto urbano ed arriva nel particolare a far rinascere le attività esistenti. E’ in questo senso che il fondo dove aveva sede un’officina meccanica viene convertito in un locale che si distingue dagli altri sia per la spazialità che per i servizi dati. L’idea alla base del progetto è quella di eliminare le superfetazioni riportando alla luce e valorizzando le caratteristiche identitarie costruttive dell’edificio storico e farlo rivivere in chiave contemporanea. La matericità di pareti in pietra ed archi in mattoni si contrappone alle linee semplici di arredi e luci in metallo; il calore viene esaltato dall’utilizzo del legno sia per la superficie pavimentata che per bancone, mensole e tavoli, quest’ultimi inoltre raccontano un po’ di storia del territorio grazie al reimpiego di barrique usate per il vino Bolgheri DOC. Lo spazio è organizzato per esaltarne la fluidità e per mantenere sempre il contatto con la vallata esterna, proprio in tal senso è stata ideata la “cucina a vista-con vista”, uno spazio aperto sia sulla sala consumazioni che sul paesaggio.
Il progetto muove nel rispetto e nella valorizzazione degli elementi maggiormente caratterizzanti l’edificio originario, non con una logica di mera conservazione ma attraverso la rilettura e l’interpretazione. L’involucro esterno, caratterizzato dalla composizione ritmata delle aperture, dal rigore della forma composta e dalla ricchezza di modanature, è stato mantenuto nella sua geometria. La rilettura in chiave contemporanea ha determinato la scelta della colorazione monocroma di tutti i prospetti, comprese le modanature e l’intradosso della gronda lignea. L’unico intervento esterno è coinciso con la sostituzioni delle superfetazioni incongruenti con una loggia a sbalzo, costituente un volume diafano dagli inconsueti effetti di luce. Internamente sono stati esaltati due elementi fondamentali della spazialità originaria e della nuova architettura risultante: le grandi altezze di interpiano e la scala in pietra con balaustra Liberty. La distribuzione interna è stata adeguata alle esigenze della vita contemporanea perseguendo la massima fluidità spaziale. Conseguentemente gli ambienti, originariamente austeri ed in penombra, sono ora invasi dalla luce. Nel volume diafano della loggia la luce assume delle caratteristiche assolutamente inedite per l’edificio: la microforatura permette di avere un ambiente aperto ma protetto dall’irraggiamento diretto, cangiante e confortevole. Lo spazio è a tutti gli effetti una ambiente esterno, ma si coniuga con un senso di protezione e privacy.
L’edificio esistente non è mai stato un esempio significativo di archeologia industriale. Il progetto propone di enfatizzare la più importante delle sue qualità che è la dimensione. L’idea è quella di trattare in modo uniforme l’intero volume con un rivestimento in alluminio anodizzato color bronzo con l’obiettivo però di non cancellare completamente la preesistenza. Questa nuova pelle metallica avvolge interamente l’edificio rafforzando la sua grande volumetria e il suo essere “un fuori scala” nel contesto urbano ma, allo stesso tempo, grazie all’effetto di trasparenza consente di mantenere parzialmente visibili le caratteristiche architettoniche dell’edificio esistente. La nuova immagine che la Camera di Commercio di Prato offre alla città è una sorta di sfocatura dell’edificio industriale del quale si continuano a vedere gli elementi principali: la serialità delle aperture, le cornici marcapiano e gli elementi decorativi rappresentativi. Una sorta di vedo-non vedo che moltiplica le possibilità di percezione del nuovo edificio contemporaneo.
Villa M, dal passato introverso e buio, ha inaugurato con questo progetto, sensibile alla memoria storica e al tempo stesso espressione di un linguaggio contemporaneo, una nuova stagione della sua vita. In questo scenario il progettista ha trasferito la sua visione di dialogo fra storia e contemporaneità, dalla reinterpretazione degli spazi alla scelta delle finiture, passando per il disegno degli arredi realizzati su misura. La neutralita’ dei colori, il grigio della pietra ed il bianco delle pareti nonche’ la linearita’ degli interventi e dei dettagli stimola il contrasto con il calore del legno rinnovato della scala centrale e degli arredi storici, i quali a loro volta dialogano con quelli contemporanei come la cucina o gli arredi in ferro. La sala centrale, grazie allo spostamento della scala, e’ oggi uno spazio luminoso e pieno di complessita’, vivibile su tutti e tre i suoi livelli e permette inediti scorci sul contesto esterno. Al piano terra tutti gli spazi sono aperti e fruibili fluidamente: ad una parete manovrabile e’ affidata la separazione della cucina per eventi formali. La pavimentazione in pietra serena locale amplifica questa continuita’ fra gli spazi e la estende anche quelli esterni della nuova terrazza. Ai piani superiori si sviluppano le funzioni piu’ private, l’atmosfera si scalda grazie all’uso Di una pavimentazione in rovere termotrattato ed il segno si fa meno rigido concedendo tutti i comfort di una abitare moderno.
Il progetto per restauro e adeguamento in oggetto conserva le caratteristiche storiche ed architettoniche dell’edificio vincolato di origine quattrocentesca e lo adegua alle funzioni preesistenti attraverso interventi contemporanei, puntuali, coordinati e leggeri che, pur mantenendo la propria individualità e riconoscibilità, ben si integrano con le preesistenze storiche. Questi interventi di natura più progettuale sono accompagnati da un intervento generale di restauro conservativo dei vari ambienti interni interessati e dei paramenti esterni, in parte in laterizio, e della terrazza, al primo piano, caratterizzata da un pavimento in pietra con botole, anch’esse in pietra, utilizzate in passato per riempire il granaio che era posto al piano terra. L’intervento mantiene le volumetrie attuali, elimina le superfetazioni e riorganizza i percorsi funzionali e distributivi. Al piano primo e secondo rimane ubicata la biblioteca che è collegata al piano terra dalla scala esterna esistente e da un nuovo ascensore per consentire l’accesso anche ai disabili senza intervenire in modo invasivo sul fabbricato. Un ulteriore ascensore esterno è previsto vicino alla terrazza e rifinito con un rivestimento esterno di lamiera in corten incisa da parole dedicate ai Cavalieri del Tau, la via Francigena e la Biblioteca. Al piano terra è previsto un adeguamento di tipo strutturale per realizzare la soprastante biblioteca e conservare i reperti archeologici ritrovati durante i lavori di restauro.
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area dove sono collocati una coppia di blocchi di loculi a fila verticale tra due manufatti esistenti nell’ultimo ordine del Cimitero Monumentale di Arezzo, in prossimità del bastione della Fortezza Medicea. Il progetto ha riguardato la trasformazione dell’attuale spazio in una cappella funeraria chiusa ad uso privato, nel riaspetto dei caratteri del sito e di tutela paesaggistica delle presenze storiche esistenti. La scelta progettuale è stata quella di realizzare una cappella con caratteri di leggerezza e trasparenza in modo tale da non alterare i rapporti morfologici e le finiture dei manufatti esistenti mediante uno spazio chiuso e utilizzo di componenti opachi; inoltre, mantenere libere le visuali lungo i percorsi interni che guardano la fortezza. Le dimensioni dell’area sono: larghezza 3.40 ml, lunghezza 2.65 ml, altezza 4.60 ml. Il sistema costruttivo utilizzato è costituito da un telaio metallico in acciaio inox satinato e vetro strutturale. Anche le griglie laterali svolgono funzioni strutturali per consentire di avere lastre sottili.
L’edificio, posto appena fuori dalla città storica, è il frutto di un progetto di recupero di un’antica fabbrica tessile che ha re-interpretato la stereometria e la regolarità dell’edificio esistente, ed aperto il volume alla città. La nuova immagine offerta è una sorta di “sfocatura” dell’opificio industriale, che, come nei dipinti di Richter, introduce nuove dimensioni di significato. La struttura è stata rivestita da un tessuto in alluminio traforato bronzato, al fine di rendere visibile, in trasparenza, le caratteristiche architettoniche della costruzione preesistente. La progettazione degli interni è stata concepita come dialogo tra gli elementi caratterizzanti l’ex edificio industriale ed i nuovi elementi funzionali, generando degli spazi interni polivalenti aperti al pubblico, collegati da corridoi che rivestono la funzione di ambienti di relazione, e che restituiscono un’immagine rappresentativa del ruolo pubblico. L’apertura su via Baldanzi, che apre la sala Consiglio verso la città, ed una serie di “tagli” operati sull’edificio esistente, introducono segni contemporanei caratterizzati dalle forme architettoniche articolate e dal rivestimento in acciaio corten, enfatizzati dal nuovo ponte di collegamento in Uglass. La classe energetica dell’edificio è A+, conseguita utilizzando fonti di energie rinnovabili in ogni condizione di funzionamento, in particolare solare elettrico e termico, geotermia, tetto ventilato con isolamento in lana di pecora.
Il progetto di recupero e trasformazione di un dismesso fabbricato artigianale disvela la primitiva morfologia di abbandonati edifici produttivi, reinterpretandone l’arcaicità della forma e l’unicità dello spazio interno. La conversione, di ciò che ieri era luogo di produzione familiare in nuovo territorio per l’abitare, garantisce il permanere di quei rapporti di convivialità spaziale tra l’ex annesso lavorativo e l’adiacente abitazione principale. Il volume monolitico esistente si evolve in una piccola casa per una giovane coppia generando nuove connessioni, spaziali visive e materiche, tra interno ed esterno, tra il territorio della casa e gli altri territori: il giardino, la strada, il luogo. Il collegamento tra l’edificio ed il giardino è articolato nella continuità d’uso del pavimento in cemento gettato in opera, un nuovo suolo in forma di aia o seduta. Lo sviluppo cromatico dei prospetti è trattato con un profondo bruno, intonaco in pasta per le facciate, elementi in laterizio per la copertura. Finestre-cornice come nicchie lignee creano una soglia abitata, mentre il portico d’ingresso in forma di vuoto protetto diviene loggia-soggiorno. All’interno un nuovo paesaggio si dipana nella successione di piani sequenza, un’enfilade prospettica di scorci per l’abitare articolata in piccoli universi dalle singole specificità. La luce, filtrata da elementi frangisole lignei, penetra nella profondità di tale scenario fino a cadere dall’alto a narrare paesaggi altri.
Il Casale “Casiscala” è un gioiello incastonato fra le verdi colline di Castelfalfi, nel cuore della Toscana tra Firenze e Siena, immerso in un incontaminato paesaggio di riserva di caccia. Il Casale, con una superficie di 310 mq e circondato da circa 3.500 mq di verde privato, trovato in stato di abbandono e pressoché diruto, è stato oggetto di un’attenta opera di restauro dal 2013 al 2016 attraverso il quale è tornato al suo antico splendore come Villa indipendente, dimora esclusiva dotata di tutti i comfort moderni. Il recupero architettonico ha cercato di preservare le originali ed autentiche forme del casale rurale, nel rispetto dell’ambiente e della tradizione storica della Toscana, in armonia con le proporzioni, i materiali (cotto, pietra e legno quanto più possibile recuperati) ed i cromatismi dell’originario Casale. La residenza si sviluppa su un piano terra costituito da una zona di ingresso con ampio camino, cucina con parete in pietra faccia vista, una camera da letto ed un bagno; scendendo sei gradini si raggiunge il soggiorno, in contatto visivo con la zona del camino e l’area esterna della piscina. Salendo una rampa di scale si raggiunge il primo piano formato da tre camere da letto ciascuna con proprio bagno, un’ampia loggia regala un affaccio ad ovest sulla suggestiva vallata. Completano il complesso un annesso di 78 mq destinato a garage ed una piscina con solarium; il tutto circondato da olivi ed essenze tipiche locali: alloro, ginestra, timo e rosmarino.
La Chiesa di San Pellegrino, costruita presso un’antica porta delle fortificazioni romane, fu ampliata alla metà del XVII sec. e nel 1808 fu chiusa al culto. Nel XX sec. fu sede di un’officina organaria e più recentemente divenne un magazzino. La Chiesa versava in uno stato di degrado avanzato, l’obiettivo era di restaurare gli esterni, le coperture e gli interni con l’intento di trasferirvi la collezione di calchi di gesso del Polo Museale Toscano. La collezione è formata da 230 pezzi. Il progetto ha riguardato anche i vani adiacenti che sono stati connessi alla Chiesa con la riapertura di un’antica porta. L’intervento progettuale è stato impostato alla massima economicità e rispetto del manufatto storico, lo spazio è stato riportato all’antico splendore e l’illuminazione artificiale è stata realizzata con apparecchi posti sul cornicione dell’aula al fine di nascondere ogni elemento tecnologico alla vista. La luce è la materia che definisce lo spazio. Gli elementi architettonici introdotti dal progetto sono le lastre di acciaio del vano porta di collegamento con i locali adiacenti, i gradini mancanti del presbiterio, le aree dove erano originariamente collocati gli altari laterali e la bussola d’ingresso. La pavimentazione di marmo bianco e bardiglio è stata pulita e patinata conservando il livello di usura che testimonia la stratificazione dei molteplici usi avvenuti nell’ultimo secolo. Il Deposito dei Gessi è realizzato con tubi innocenti e bancali di legno.
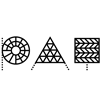
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix