

Il bastione del Parlascio è stato realizzato a ridosso di una delle porte di accesso alla città, facente parte della cinta muraria del XII secolo, che ha subito numerosi interventi di ampliamento. I primi interventi riguardarono la costruzione di una torre portaia del 1320 e di un’antiporta eretta nel 1324, la costruzione di un fortilizio su progetto del Brunelleschi a partire dal 1435 e la costruzione del bastione di Nanni Ungaro eretto tra il 1542 e il 1544. Il bastione perse la sua funzione difensiva nel corso del XVIII secolo, quando venne utilizzato come deposito per il ghiaccio; successivamente durante l’ultimo conflitto, a seguito di modifiche, la struttura è stata usata come rifugio antiaereo. Dagli anni 60 agli anni 90 del secolo passato la struttura è stata usata come autofficina. Il bastione del Parlascio, che è parte integrante e sostanziale del progetto mura, è situato in prossimità dell’area archeologica delle Terme Romane, sul prolungamento dell’asse pedonale di Borgo Stretto e Borgo Largo, risulta un punto strategico dal punto di vista dell’interesse architettonico e dal punto di vista dell’accessibilità al percorso in quota alle mura urbane, in quanto al suo interno è previsto uno dei punti di salita. Il complesso architettonico con il restauro e recupero garantisce un’accoglienza turistica al suo interno con l’utilizzo degli spazi per informazioni, sosta, mostre; inoltre consentirà il suo attraversamento interno con un percorso pedonale pubblico.
Oggetto della presente proposta è la realizzazione di una sala multifunzionale nel Comune di Pisa, quartiere “I Passi”, nell’ambito del progetto “PIU” (PIANI DI INNOVAZIONE URBANA), che ha lo scopo di dotare la comunità di uno spazio che diventi luogo di incontro, di scambio e di arricchimento personale e collettivo. L’edificio ha la funzione principale di auditorium fruibile sia dal quartiere che dall’intera città, ma come già detto, si configura come uno spazio multifunzionale. Nella fase di studio sono stati presi a riferimento gli edifici presenti nel quartiere ed è emerso che la gran parte dei fabbricati esistenti sono di natura residenziale e realizzati con mattoni facciavista, mentre il complesso parrocchiale del quartiere è un edificio dalle forme nette e squadrate in calcestruzzo armato, che quindi si distingue dal resto dell’edificato rendendolo facilmente identificabile. L’area oggetto dell’intervento si colloca a nord di Pisa in un’area a prevalenza residenziale di origine popolare derivante principalmente da una lottizzazione INA Casa degli anni 50 e 60. Nel quartiere sono presenti i principali servizi: la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, la chiesa ed un complesso sportivo. Il volume della sala polivalente è articolato su due piani fuori terra; il piano terra è realizzato su strutture puntiformi, offrendo così un porticato ed una piazza coperta dalla quale si accede al piano primo, dove si è ubicata la sala che ha una disponibilità di 120 posti.
Il complesso industriale sede della società “Pharmanutra S.p.a.” è stato realizzato nella zona nord del comune di Pisa nel 2023. Le dimensioni lotto sono 11.885 mq. La Superficie utile lorda è di 3095,49 mq. L’impianto ha sostituito edifici industriali dismessi, con il recupero di uno di essi per il settore produttivo. Il nuovo fabbricato ospita le funzioni direzionali. L’edificio si sviluppa su due piani: Il piano primo: un parallelepipedo, sostenuto da due travi “Warren” laterali che permettono di avere un ponte di circa 22 mt nel collegamento con l’edificio della produzione mentre, sulla testata est, sostengono un aggetto di circa 9 mt. Il piano terra accoglie servizi come: sala conferenze, sale riunioni, sala pranzo aziendale e palestra. Al piano primo vi sono gli uffici, organizzati in open space. Sul grande aggetto ad est si trovano gli uffici della direzione. I due settori sono messi in relazione dal ballatoio che si affaccia sul doppio volume della hall. Le due fasce laterali sono caratterizzate da superfici ampiamente vetrate schermate da frangisole a sud. Le parti opache sono rivestite con pannelli in fibra di legno al piano primo, le pareti sottostanti, presentano pannelli in Alucobond. I punti sostanziali del progetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Progettazione impiantistica basata sui principi della bioclimatica. CONFORT ACUSTICO Elementi di involucro con potere fonoisolante. SOSTENIBILITA’ SOCIALE Aspetti connessi all’accessibilità, flessibilità e fruibilità
L’area a verde del parco Europa è strategica per la qualità della vita dei numerosi cittadini residenti nel quartiere di Cisanello ma risulta ancor di più di rilevante importanza perché fa da tessuto di connessione e attrazione tra gli abitanti dei diversi quartieri della città e gli utenti del vicino ospedale di Cisanello che nel bosco urbano possono trovare occasioni di benessere, rigenerazione e di socializzazione. Le strategie, azioni, interventi, del progetto si sono basate sulla natura per aumentare la resilienza della città (N.S.B.) realizzando: 1. La piantumazione di 500 alberi di prima grandezza, delle seguenti specie: Acer campestre, Alnus cordata o g., Betula pendula, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Populus alba, Populus nigra, Quercus ilex, Quercus robur, Salix alba, Tilia x vulgaris e Ulmus minor; 2. La messa a dimora di 750 erbacee e arbusti perenni per favorire l’avifauna delle seguenti specie: Cornus mas, Ilex aquifolium, Pyracantha coccinea, Viburnum e Crataegus monogina; 3. Il mantenimento di un’area depressa nella parte centrale che formerà ristagni d’acqua nelle stagioni piovose per circa 3.000 mc. ritenuti estremamente importanti per favorire la biodiversità ed inoltre è una cassa di laminazione idraulica naturale; 4. La realizzazione di una pista ciclabile di lunghezza di 500 ml. di connessione con la rete ciclabile cittadina e l’installazione di sensori ambientali gestiti in remoto per monitorare i parametri NO2 – NO – O3 – PM1 – PM2.5 – PM10.
L’idea del progetto nasce da una riflessione sui modi di studiare e di fare ricerca in un momento storico in cui le tecnologie di trasmissione ed edizione digitale invitano ad una reinterpretazione degli spazi tradizionali dedicati alle biblioteche. L’intervento si sviluppa su tutti e sei i piani dell’edificio, per una superficie totale di circa 2000 m2. Scopo primario del progetto è proporre un insieme di soluzioni d’arredo reiterabili nelle varie stanze del palazzo in modo da creare una continuità linguistica riconoscibile dagli utenti della scuola. Il progetto cerca di ‘pulire’ le stanze, sature di ostacoli fisici e visuali che impediscono la godibilità funzionale e inibiscono la fruizione distributiva dello spazio. L’esigenza principale è di ricondurre in una trama di pochi segni e di spazi, facilmente identificabili, gli ambiti bibliotecari interessati dal progetto, favorendone la cucitura e l’integrazione con l’articolato impianto planimetrico dell’edificio storico. L’architettura degli interni viene concepita come organica alla forma dell’edificio, in modo da evitare al visitatore la sensazione di trovarsi di fronte ad un intervento di semplice collocazione degli arredi. L’idea principale quindi si muove attorno all’esigenza di creare l’identità della nuova biblioteca attraverso i due elementi principali dell’arredo: le scaffalature librarie, pensate come fondali alle pareti, e gli arredi, pensati come delle isole, elementi riconoscibili ed ordinatori dello spazio.
Quest’opera tenta di restituire decoro e significato a architetture indispensabili al nostro vivere. L’idea progettuale nasce dalle emergenze paesaggistiche proprie dell’area, lungo la Via Fossa Ducaria, dominata dalla vicinanza dell’argine del Fiume Arno. Conformazione del terreno, vegetazione ed elemento acqua sono protagonisti di un’esperienza progettuale tesa alla ricerca di valore estetico e qualitativo e di integrazione ambientale. Gradevolezza e sobrietà sono alla base della definizione di spazi, linee, forme e colori. Ci si muove perseguendo il minor impatto paesaggistico: visibilità e percezione sono mitigate dal parziale effetto schermante e dalla generale ricucitura tra l’uso agricolo, i soprassuoli arborei, la vegetazione ripariale ed il margine stradale. Dell’elemento Verde si enfatizza la tridimensionalità. Un movimento tellurico profondo anima il terreno; le piantumazioni, tipiche della golena, definiscono le scarpate; il prato si solleva come in equilibrio con il leggero declivio, fino a raccordarsi nuovamente con la strada vicina. In questa reinterpretazione e riprogettazione del Verde si inserisce il costruito: l’area di servizio (pavimentazione in asfalto ecologico colorato e cemento) l’edificio di servizio al gestore e alle utenze i manufatti per la distribuzione di carburante il “recinto-canneto” della cabina del gas metano le pensiline disegnate a suggerire scheletri di alberature Tutti questi “oggetti” sono voluti in acciaio verniciato
Il restauro in oggetto, punta a completare un percorso progettuale iniziato nel 2008, mirato ad allargare l’offerta per la piena fruizione a cittadini e studenti del “Giardino Scotto”, o anche detta Fortezza Nuova e di cui il Bastione Sangallo ne è parte. Con la riqualificazione della copertura del Bastione Sangallo si è inteso lasciare traccia di quel periodo storico che alla fine del ‘700, quando la fortezza non dovendo più assolvere alla sua originaria funzione difensiva, fu venduta alla famiglia Chiesa e poi agli Scotto che costruirono sulle mura un corridoio coperto per le passeggiate romantiche trasformando il complesso in giardino delle delizie. In quest’ ottica il restauro definitivo della copertura, iniziato anni fa con il consolidamento delle volte soprastanti i locali interni al bastione, è intenzionato a riportare sulla sommità della fortezza le essenze arboree originali che a cavallo tra il ‘700 e ‘800 conferirono alla fortificazione l’appellativo di “Torrione dei Lecci”. Con il restauro conservativo delle pareti perimetrali del mastio si è voluto inibire lo sviluppo dei processi di degrado riscontrati. Le scelte di restauro adottate hanno perseguono i principi condivisi dalla moderna cultura del restauro: minimo intervento, scarsa invasività dei lavori, conservazione della materia e della “facies” storicizzata del manufatto, la “distinguibilità” delle addizioni. L’intervento si è concluso a settembre 2023.
Nel Museo dell’Opera del Duomo di Pisa la successione delle opere è espressione della devozione e della magnificenza di Pisa a partire dal Dodicesimo Secolo. Nella potente e ricca repubblica marinara si sono incontrate culture artistiche diverse, da quelle d’oltre Alpi a quelle islamiche, e nel sec. XIII, con l’arrivo di Nicola Pisano, inizia una stagione di sperimentazione nell’ambito della scultura che ha in sé tutti i semi che germoglieranno con il Rinascimento. Il nuovo progetto museografico si pone come obbiettivo la realizzazione di un percorso fluido, in cui le opere della grande scultura pisana sono valorizzate dagli allestimenti e nello stesso tempo dialogano con il contesto storico. Le opere sono contestualizzate mediante allestimenti che evocano il luogo, la collocazione e le atmosfere originarie. Si tratta di una operazione complessa, mai imitativa della realtà, ma volta a cogliere l’essenza e i significati reconditi per veicolarli. Le finiture, i colori e i materiali rimandano a quelli storici usati nei monumenti della piazza, reinterpretati in chiave contemporanea. I basamenti e le pedane sono in pietra arenaria lavorata in modo da creare una leggerissima vibrazione della superficie. I fondali delle opere sono realizzati in resina o in encausto, per evocare i colori della piazza o i finti marmi dell’interno duomo. Il percorso espositivo si sviluppa su 3000 mq interni, e su una porzione del porticato esterno. Le 380 opere esposte sono suddivise in 26 sezioni.
L’intervento di restauro comprende sia l’immobile denominato “Frati Bigi” che le sue aree verdi pertinenziali. Il complesso, tutelato da vincolo diretto dalla Soprintendenza, era abbandonato da anni e versava in condizioni pessime di degrado. La riqualificazione urbana ha interessato circa 5.000 mq di verde, da destinarsi a parco pubblico e 2.800 mq di edificato, realizzato in classe energetica A, con residenze (primo, secondo e terzo piano), servizi e commerciale (piano terra.). Le venti residenze, servite da scale e ascensori collegati fino al piano interrato-rimessaggio, sono poste in due blocchi con caratteristiche diverse: edificio neogotico (solai in travi travicelli e mezzane, alla maniera toscana), blocco più recente ampi terrazzi schermati da verde rampicante. Su via Matteucci, è ubicato l’accesso: auto, moto, biciclette e parcheggio privato interrato, trattato come un’estensione della superficie a verde con il posizionamento di tre alberi di olmo. L’uscita del parcheggio è realizzato in vetro per non interrompere la continuità visiva sul giardino. La zona a sud è stata progettata come spazio ludico per tutte le età, con giochi per bambini ed uno dedicato al gioco delle bocce, con sedute di varie dimensioni e tipologia, e fontane. La pavimentazione: per la zona a nord è stata realizzata in pietra “colombina” con varie finiture e tagli, cotto sotto la loggia, cemento architettonico nella zona carrabile, ghiaia per l’aiuola sul fronte principale e teak per i camminamenti di penetrazione posti a sud.
La struttura dell’Arsenale si presentava in uno stato di degrado, privo di copertura, delle grandi arcate, dei piani di calpestio ed era completamente invaso dalla vegetazione con un rinterro di circa due metri oltre la quota medievale; di fatto si trattava di un vero e proprio rudere seppure di grande fascino. La ricostruzione e il restauro degli Arsenali Repubblicani ha affrontato diversi temi, dalla scoperta dei resti archeologici, dalla ricerca storica, alla ricostituzione filogica che ha guidato le scelte progettuali, agli interventi strutturali di rilevanza sismica fino all’inserimento degli impianti tecnologici necessari per la pubblica fruizione. L’agibilità dei locali prevede attività culturali, museali, di pubblico spettacolo ed auditorium con capienza fino a seicento persone per cui l’immobile ha una attrattività gestionale significativa soprattutto perché si tratta di un bene storico straordinario monumentale che si offre non soltanto alla città di Pisa ma al turismo internazionale. La valorizzazione degli Arsenali Repubblicani contribuisce in ogni caso alla conservazione del patrimonio culturale, allo sviluppo intelligente e sostenibile, fornisce infrastrutture e servizi culturali, promuove l’industria culturale e creativa, rendono attraente la cultura e usano la cultura per unire le comunità. Il risultato raggiunto fa immergere il visitatore nell’antica Terzanaia medievale all’interno degli arsenali che nella contemporaneità trovano l’originario splendore.
Il nuovo quartier generale della Forti spa, situato tra Pisa e Livorno, ospita gli uffici e il centro direzionale del gruppo aziendale. Il centro rappresenta un chiaro esempio di architettura sostenibile. Le performance energetiche dell’edificio sono diretta conseguenza di una progettazione attenta agli aspetti bioclimatici; lo studio delle superfici opache e trasparenti è studiato in base al loro specifico orientamento. A piano terra, una grande hall accoglie i visitatori e si apre in una grande facciata ventilata. La facciata sud-est è invece caratterizzata da grandi vetrate continue schermate da frangisole lineari. Queste scelte si riflettono all’interno in ambienti di lavoro con vista aperta sul verde. Il verde è presente anche all’interno dell’edificio con giardini pensili e terrazze rivestite in materiali naturali, contribuendo alla regolazione del microclima. La facciata sud è stata interamente rivestita con pannelli fotovoltaici. Grazie allo sviluppo di apposite soluzioni architettoniche, l’involucro diventa il primo impianto tecnologico dell’edificio. Insieme all’involucro è stato sviluppato un apparato impiantistico all’avanguardia, che impiega impianti di illuminazione LED, un sistema geotermico per la climatizzazione degli spazi interni e recuperatori di calore. Il mix di fonti rinnovabili e fanno di questo complesso un punto di riferimento per l’edilizia sostenibile di tutta la Regione Toscana, che ha ottenuto la certificazione di sostenibilità LEED Gold.
L’intervento si è rilevato per condizioni e per scelta, composito, in quanto ha adottato e combinato tra loro più registri di mera conservazione, di risarcimento, di aggiunta, di manutenzione. Il progetto ha ricercato un’assonanza temperata tra le parti attraverso l’utilizzo di materiali affini e compatibili, proponendo un risultato che ha voluto essere sobrio ma ha rifiutato di essere neutrale ha cercato cioè di riconnettere le parti preesistenti alle nuove integrazioni senza rimarcare la discontinuità ma senza nemmeno mascherarla, affidandosi sopratutto al differenziale dovuto all’assenza di degrado e patinatura dei nuovi materiali rispetto agli antichi e a contatti nitidi che rispettano le tracce antiche senza però ostentarle in modo “scientifico“. La scelta è stata quella di condurre un intervento per così dire prudente, discreto in un certo qual modo timido da risultare quasi “trasparente” che ha permesso di conservare e rispettare i caratteri delle superficie preesistenti. L’intervento sulle strutture è stato anch’esso sviluppato in modo da minimizzare l’impatto e non alterare il meccanismo statico preesistente, dove ciò non è stato possibile si è reso reversibile al fine di poterlo rimuovere nel caso di mutate necessità o di avanzamento tecnologico: non sostituzione dell’organismo statico con uno diverso, ma restituzione alle strutture preesistenti dei loro compiti e delle loro caratteristiche con l’eventuale aiuto, dove si è reso necessario, di strutture integrative.
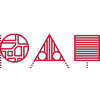
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix