

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, con sede in Firenze via ponte di Mezzo, aveva necessità di avere uno spazio in cui poter confrontarsi con i suoi associati, tenere conferenze e corsi di formazione. Il progetto di ampliamento della sede ha dato risposta a questa esigenza creando una sala conferenze da quaranta posti a sedere oltre ad area break, reception, tre uffici e servizi. Non essendo possibile, per motivi di spazio, realizzare un collegamento interno abbiamo riprogettato la scala condominiale, utilizzata soltanto dall’associazione Ebret, che oltre al primo piano del fabbricato occupa anche il secondo ed ultimo, oggetto dell’intervento. Lo spazio disponibile per sala conferenze aveva una forte dominanza longitudinale che abbiamo cercato di interrompere mediante l’introduzione di tre portali luminosi, in modo da suddividere lo spazio in quattro campate. Le lampade a striscia led continua abbinate ai faretti da incasso tondi sono regolabili per intensità ed accensione, per creare scenari adattabili ad usi diversi, come ad esempio le conferenze o le proiezioni. Le pareti dogate con finitura in pelle sono di tipo acustico, così come il controsoffitto per garantire un ottimo confort sia per i relatori sia per gli ascoltatori. Tutti gli impianti della sala, acustici, illuminotecnici, lo schermo e le tapparelle oscuranti sono gestibili da remoto.
L’idea progettuale lavora sul tema “della scatola nella scatola” per riqualificare lo spazio operativo degli uffici della sede della Confcommercio di Pistoia. L’edificio è un parallelepipedo a base quadrata (36×36 metri) costruito nel 1970 con una tipologia prossima all’edilizia industriale più che a quella ad uffici. Gli elementi strutturali verticali posti secondo una maglia quadrata ad interasse costante di sei metri, ripartiscono e vincolano lo spazio. Le scelte progettuali sono state orientate ad articolare gli ambienti interni così da creare flussi, spazialità e dinamiche rispondenti alle necessità degli spazi di lavoro sia “aperti” che “confinati”. Il progetto ha come fulcro la zona centrale, nella quale lo stare e l’attraversare, la relazione e l’incontro sono azioni che lo spazio sottolinea caratterizzandosi rispetto all’intorno per materiale, altezza e illuminazione. Il concept è stato sviluppato partendo da quattro parole chiave; sostenibilità, accessibilità, flessibilità ed informatizzazione, che sono state declinate nelle loro diverse accezioni all’interno del programma edilizio. Dal punto di vista funzionale il progetto si organizza con una pianta a “ferro di cavallo” che si sviluppa sul perimetro dell’edificio per quanto riguarda gli uffici “operativi” e racchiude al suo interno un “cuore”, uno spazio posto in relazione visiva con gli uffici convenzionali che è l’area di rappresentanza per la nuova sede della Confcommercio. Lo spazio del “Futuro Anteriore”.
Il complesso monumentale dei Bottini dell’Olio–Luogo Pio, realizzato all’inizio del XVIII secolo, costituisce un intero isolato urbano nel cuore dello storico quartiere della Venezia Nuova. L’intervento di restauro degli edifici esistenti ha compreso anche il completamento delle parti distrutte dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale realizzando, purtroppo ancora non in maniera completa, nuovi volumi sul sedime di quelli storici tesi a ricucire il tessuto urbano sfrangiato dalle bombe. In essi mediante l’utilizzo di materiali quali il vetro, il metallo ed il laterizio scialbato a vista, si sono introdotti linguaggi architettonici distinguibili ma che trovano riferimenti nel contesto del quartiere. L’intervento ha realizzato anche nuovi collegamenti funzionali interni, scale, ascensori, rampe e passaggi coperti, che hanno reso il complesso funzionale al nuovo ruolo e completamente accessibile. Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, utilizzando l’acqua del vicino canale, realizzano un alto risparmio energetico, le reti distributive sono celate ed integrate negli elementi architettonici e negli allestimenti. Negli spazi così restaurati e ricostruiti, si sono ricavati nuovi locali espositivi e nuove dotazioni di servizi per l’esistente Biblioteca Labronica. All’interno dei Bottini dell’Olio, negli ampi saloni voltati, è stato allestito il nuovo Museo della Città, mentre gli ambienti e la Chiesa del Luogo Pio ospitano la collezione comunale di arte contemporanea.
L’idea progettuale lavora sul tema “della scatola nella scatola” per riqualificare lo spazio operativo degli uffici della sede della Confcommercio di Pistoia. L’edificio è un parallelepipedo a base quadrata (36×36 metri) costruito nel 1970 con una tipologia prossima all’edilizia industriale più che a quella ad uffici. Gli elementi strutturali verticali posti secondo una maglia quadrata ad interasse costante di 6 metri, ripartiscono e vincolano lo spazio. Le scelte progettuali sono state orientate ad articolare gli ambienti interni così da creare flussi, spazialità e dinamiche rispondenti alle necessità degli spazi di lavoro sia “aperti” che “confinati”. Il progetto ha come fulcro la zona centrale, nella quale lo stare e l’attraversare, la relazione e l’incontro sono azioni che lo spazio sottolinea caratterizzandosi rispetto all’intorno per materiale, altezza e illuminazione. Il concept è stato sviluppato partendo da quattro parole chiave; sostenibilità, accessibilità, flessibilità ed informatizzazione, che sono state declinate nelle loro diverse accezioni all’interno del programma edilizio. Dal punto di vista funzionale il progetto si organizza con una pianta a “ferro di cavallo” che si sviluppa sul perimetro dell’edificio per quanto riguarda gli uffici “operativi” e racchiude al suo interno un “cuore”, uno spazio posto in relazione visiva con gli uffici convenzionali che è l’area di rappresentanza per la nuova sede della Confcommercio. Lo spazio del “Futuro Anteriore”.
La maestà di Duccio di Buoninsegna, commissionata per essere posta sull’altare maggiore del Duomo di Siena è dipinta sulle due le facce. Sul fronte rivolto all’assemblea è la Madonna in trono col figlio sulle ginocchia. Sul retro, rivolto verso il coro, sono dipinte scene della vita di Cristo, inquadrate in uno spartito geometrico. Per cogliere nel suo insieme il valore di quest’opera occorre osservare le due facce, scoprirne le due dimensioni. Le “Logge del Papa”, propongono un singolare innesto nella complessa morfologia del tessuto urbano medievale. Un’architettura “leggera”, composta da tre campate aperte, delimitate sul fronte principale da una cancellata, ormai chiusa da anni. Il carattere delle due opere descritte confluisce nel progetto di uno spazio espositivo temporaneo da realizzarsi nell’antico monumento senese. Lo spazio sotteso all’architettura di archi e vele, isolato e inaccessibile, si apre ora alla città. Un’architettura temporanea è composta da un basamento-seduta che risolve l’attacco con il suolo e da una struttura verticale, costituita da due “C” sovrapposte, posta al centro della composizione. In alto, una “nicchia”, un tabernacolo o un trono che si rivolge, si mostra, all’esterno e accoglie un’immagine fotografica, “icona” contemporanea. In basso, il suo doppio, una “stanza segreta” che si rivela solo a chi decide di entrare sotto la loggia. Nella stanza la narrazione prosegue con immagini di piccole dimensioni disposte in una sequenza regolare.
“La civiltà toscana ha avuto come poche altre un carattere di continuità nel suo sviluppo lungo quasi sei secoli, in cui si è costantemente mantenuta viva maturando le sue rivoluzioni in seno a una tradizione sostanzialmente così conservatrice da rendere i momenti innovatori piuttosto dei ritorni che delle scoperte”. Due basamenti quadrati si inseriscono nel pendio della collina uno dietro all’altro. Il primo verso valle contiene la piscina, sul secondo è appoggiata la casa, anch’essa di pianta quadrata con una distribuzione interna molto semplice. L’archetipo della casa si riflette nella copertura a capanna che ne definisce proporzioni e misure, accompagnata da due elementi della tradizione che caratterizzano l’immagine complessiva. Il primo dei due è la loggia che “svuota” per intero la facciata principale, riflettendone i contorni con i muri laterali in pietra che sorreggono le grandi travi metalliche inclinate della copertura. Le scale, il secondo elemento, sono scavate sul fianco del basamento e superano il dislivello tra il piano di campagna e quello della casa. La distribuzione interna priva lo spazio domestico di una gerarchia, accorpando le stanze in un nucleo compatto rivolto all’esterno per privilegiare la vista costante sul paesaggio.
L’edificio, che risale alla prima metà del Novecento, ospitava una distilleria e poi un’officina meccanica. La posizione su un importante asse di comunicazione ha suggerito un’ipotesi di recupero dell’immobile per destinarlo a spazio espositivo per le arti visive. All’esterno, un grande portale in ferro grezzo segnala, sulla piccola corte privata, l’ingresso allo spazio espositivo. Lo spessore di pochi centimetri dell’infisso esistente è sostituito da uno di quasi due metri. Il portale raccorda i due spazi, assumendo il ruolo di tramite fisico tra interno ed esterno, dilatando la soglia. L’ampia copertura a volta e il pavimento, seppure molto usurato, sono stati conservati in una filosofia progettuale che intende riflettere sul possibile rapporto tra preesistente e nuovo. Il nuovo si sovrappone al preesistente seguendo il principio della stratificazione: sulle pareti perimetrali si appoggia un rivestimento leggero, ad altezza variabile. Sull’asse longitudinale dell’aula, una sequenza di cinque celle cubiche di lato tre metri, aperte su un lato e prive di copertura. Vuoti che riempiono il vuoto. Un basamento della stessa dimensione in pianta, ma alto solo un terzo del lato di base, apre la sequenza. I volumi sono staccati tra loro: pause che consentono di traguardare, lasciando scoprire l’effettiva larghezza della sala. Un percorso anulare consente l’accesso alle stanze espositive, che si lasciano scoprire nell’alternanza di pieni e vuoti che caratterizza la composizione.
Canalicchio di Sotto è un insediamento poderale che risale alla metà del XIX secolo, adiacente all’antica strada che dà il nome al podere e che collega Montalcino a nord, verso Siena. Situato nel piano di Val di Cava, nel corso dei decenni al nucleo primario si sono aggiunti i vari annessi agricoli che formano l’attuale struttura aziendale. Questa si sviluppa intorno ad un asse sud-nord sul quale è stato fondato anche il nuovo intervento. La sua collocazione ipogea, raccogliendo la sfida dell’impatto ambientale, fa emergere in superficie solo segni indelebili dei margini della copertura. Così, nel “campo” sotto casa, si colloca il nuovo disegno dell’azienda attraverso l’incrocio dei due assi, quello sopracitato e quello ortogonale rappresentato dalla strada parallela al vecchio percorso del Canalicchio. Il progetto del nuovo annesso è dunque una copertura verde, come il resto del campo circostante, evidenziata solo da due muri che da nord a sud rimarcano, ma che da est a ovest scompaiono sotto il grande ombrello che il portico offre. Il risultato è un segno lievissimo che si integra con il paesaggio circostante scomparendo alla vista dell’orizzonte verso chi guarda a nord e apparendo, nell’ombra, come margine evidente nel controcampo da sud. La struttura interna è in calcestruzzo facciavista con sei portali composti da colonne binate ed una trave in corten mentre le pareti esterne sono rivestite in lastre di travertino e si integrano cromaticamente con la natura circostante.
Canalicchio di Sotto è un insediamento poderale che risale alla metà del XIX secolo, adiacente all’antica strada che dà il nome al podere e che collega Montalcino a nord, verso Siena. Situato nel piano di Val di Cava, nel corso dei decenni al nucleo primario si sono aggiunti i vari annessi agricoli che formano l’attuale struttura aziendale. Questa si sviluppa intorno ad un asse sud-nord sul quale è stato fondato anche il nuovo intervento. La sua collocazione ipogea, raccogliendo la sfida dell’impatto ambientale, fa emergere in superficie solo segni indelebili dei margini della copertura. Così, nel “campo” sotto casa, si colloca il nuovo disegno dell’azienda attraverso l’incrocio dei due assi, quello sopracitato e quello ortogonale rappresentato dalla strada parallela al vecchio percorso del Canalicchio. Il progetto del nuovo annesso è dunque una copertura verde, come il resto del campo circostante, evidenziata solo da due muri che da nord a sud rimarcano, ma che da est a ovest scompaiono sotto il grande ombrello che il portico offre. Il risultato è un segno lievissimo che si integra con il paesaggio circostante scomparendo alla vista dell’orizzonte verso chi guarda a nord e apparendo, nell’ombra, come margine evidente nel controcampo da sud. La struttura interna è in calcestruzzo facciavista con sei portali composti da colonne binate ed una trave in corten mentre le pareti esterne sono rivestite in lastre di travertino e si integrano cromaticamente con la natura circostante.
Dall’unione di due unità è stato ricavato un unico spazio abitativo su tre piani, adatto a soddisfare le esigenze di una famiglia. I lavori sono stati orientati a valorizzare i tratti più caratteristici dell’esistente, come la scala originale dei primi del novecento che unisce i tre livelli, recuperata e reinventata. Un elemento del passato che rivive nella nuova abitazione. La scala, in resina di colore grigio, è invece il segno della nuova distribuzione dello spazio. Il progetto interviene con un’idea volumetrica a doppio volume solo nella zona del soggiorno, da cui parte il collegamento fra il piano primo e secondo: la scala esistente, le linee minimalistiche con la resina a pavimento, il colore bianco delle pareti e la luce che arriva dalla copertura creano un aspetto semplice e raffinato ma insolito per la tipologia di casa. Che interessi una o più stanze della casa, le pareti, gli arredi o il pavimento, il bianco è il colore che meglio sa far splendere gli interni riflettendo la luce proveniente dall’esterno. Sicura nella sua eleganza monocromatica è questo loft nei dintorni di Firenze, progettato da Alessandro Bruni a reinterpretare la perfezione e l’armonia dello spazio domestico contemporaneo. All’interno domina il senso di leggerezza, reso interessante dalla modernità dell’openspace. Per la sua capacità di dilatare lo spazio, il bianco è stato scelto come colore guida, declinato in più sfumature, che vanno dalle pareti a ogni singolo arredo.
Esposizione temporanea realizzata nell’autunno del 2014 al Palazzo Ducale di Massa. L’esposizione ha presentato una raccolta di sculture africane in legno donate dall’artista argentino Julio Silva e dalla moglie alla città di Massa. Le opere rappresentative delle varie culture del Camerun, connesse ai riti che scandiscono la vita dei villaggi, erano costituite da figure, maschere, oggetti che definiscono ruoli e gerarchie sociali. Per sottolineare il valore espressivo delle sculture in legno rappresentative del carattere collettivo dell’arte africana, il progetto di allestimento ha previsto un “percorso di avvicinamento” all’arte tribale africana tentando di restituire la molteplicità di significati che le varie tipologie di oggetti rappresentavano. Stimolante è stata la relazione che è venuta ad istituirsi tra le sculture in legno e il luogo scelto per l’esposizione: il Salone degli Svizzeri e la Sala degli Specchi del Palazzo Ducale di Massa, edificio realizzato dai Cybo-Malaspina dal 1563. L’allestimento si è misurato con l’apparato decorativo del salone, un involucro avvolgente che ha condizionato l’articolazione del progetto espositivo; lo spazio della mostra è stato reso riconoscibile affinché si confrontasse dialetticamente con l’architettura del palazzo: una moquette grigia delimitava orizzontalmente la superficie dell’esposizione, un tappeto su cui si appoggiavano i volumi bianchi degli apparati espositivi.
Il nuovo lucernario dell’ex “Cinema Moderno” è forse la metafora più esaustiva di una più complessa ristrutturazione dell’intero immobile. Il particolarissimo edificio a punta, un “Flatiron Building” di origine medievale nel cuore di Siena, di fronte allo storico Palazzo Tolomei, irrompe nella piazza omonima creando una “Y”, simbolo della storica suddivisione in terzi di città. Diventa così l’impronta su cui insiste la nuova lanterna sul tetto, landmark urbano, virus contemporaneo generatore della nuova struttura interna che si innesta come nuovo ordine compositivo e distributivo. I muri esterni, interamente in mattoni faccia vista e pietra nel basamento del piano terra, hanno fatto da scenario alla spettacolare asportazione di tutte le superfetazioni, fino al completo svuotamento dell’intero volume. Oggi, dopo un dettagliato rilievo laser scan e un accurato restauro, continuano a fare da cortina alla nuova struttura metallica. L’attuale destinazione dell’edificio è mista. Il residenziale è caratterizzato da un numero limitato di appartamenti per privilegiarne la qualità, mentre la parte commerciale, trova la sua entrata in corrispondenza della prua dell’edificio, al piano terra, attraverso lo spazio compreso tra le prime due arcate, lasciate aperte per la fruizione pubblica. Un dono alla città che riporta alla memoria l’antica στοά, luogo per l’incontro, lo scambio e la crescita culturale.
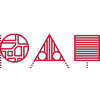
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix