

La nuova sede dell’azienda MAIOR srl (Management, Artificial Intelligence & Operations Research), si inserisce nel centro di un isolato nella zona nord est di Firenze raggiungibile tramite la nuova via della tramvia T1 passante dal quartiere Statuto. L’azienda fondata nel 1989 ha come obiettivo quello di offrire collaborazione, servizi e sistemi software a operatori ed agenzie del trasporto pubblico. Gli spazi sono stati ricavati all’interno di una vecchia falegnameria poi trasformata negli anni duemila in uffici nei quali venivano montate e stampate le cartografie della regione. L’intervento è proiettato al recupero degli spazi principali eliminando il più possibile i filtri murari esistenti al fine di ottenere come richiesto dalla committenza grandi spazi nei quali i gruppi di lavoro possono collaborare in stretto contatto. Residenza, città, natura e lavoro tendono in questo progetto quindi ad essere parte di un unico variegato universo al fine di intraprendere quel cambiamento decisivo sia per il mantenimento dei livelli di produttività sia per la capacità di attrarre le migliori risorse umane.
La casa si trova al piano nobile di un palazzo storico di Firenze ridisegnato nel 1735 dagli architetti Giovacchino Fortini e Ferdinando Ruggieri per Giuliano Dami, favorito del Gian Gastone de’ Medici. Il progetto aveva come concept principale, quello di rivisitare in chiave contemporanea questa dimora storica, attraverso l’inserimento di elementi di arredo di elevata modernità e dallo stile molto minimalista. L’atmosfera si intuisce fin dall’ingresso, dove a causa delle decorazioni a parete, veniamo catapultati in uno spazio storico ben contrastato dagli arredi presenti. Ecco poi la fuga prospettica della galleria affrescata da Niccolò Pintucci, che ritrae paesaggi antichi, schermati da capricci architettonici, parzialmente coperti da una selvaggia vegetazione. Nell’ampio salone, scandito dal soffitto a cassettoni del Quattrocento dipinto a motivi geometrici, gli arredi donano uno stile moderno in contrapposizione con la storicità della sala, come nella stessa sala da pranzo. In quella che una volta era la cappella di famiglia ora è stato ricavato uno studiolo, ma l’atmosfera riporta sempre ad una modernità molto sobria e discreta. Anche la camera padronale segue il mood di tutto l’abitazione, come la testiera del letto in pietra serena imbottita di pelle bianca, e le due sedute moderne ai piedi del letto. Movenze e atmosfere di un tempo che disegnano la cucina, dove ancora il moderno si fonde con l’antico, con il grande acquaio in bardiglio grigio e la credenza in corten.
Il Museo Novecento di Firenze è dedicato all’arte italiana del XX secolo e propone una selezione di circa 300 opere distribuite in 15 ambienti espositivi, oltre ad una sala studio, un gabinetto disegni e stampe ed una sala per conferenze e proiezioni. La sede espositiva è l’antico Spedale delle Leopoldine di piazza Santa Maria Novella. I locali che ospitano il museo sono ambienti storici ristrutturati che presentano dimensioni eterogenee, discontinuità spaziali, di dettagli e di finiture. Per raggiungere la continuità nel progetto abbiamo articolato lo spazio attraverso setti liberi che nascono, al primo piano, dal pavimento in ferro e al piano superiore dalle contropareti laterali. La finalità di questa scelta è duplice: la visione il più possibile libera degli ambienti esistenti, dall’altro lato interpretazione innovativo del progetto museologico. L’idea espositiva principale è caratterizzata da una sospensione libera delle opere nello spazio. La trascrizione architettonica è un sistema espositivo costituito da pannelli che non si differenziano dai cromatismi principali delle sale, ma anzi assumono i materiali ed i colori in base alla superficie da cui nascono: i pannelli verticali che nascono dal pavimento sono in ferro, quelli che nascono dalle pareti sono del colore e del materiale delle pareti.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Il podere. Il Bussolaio è un’antica casa colonica di Travalle, Calenzano, lungo l’antica via che attraverso l’Appennino portava in Emilia. Un complesso di fabbricati costruiti negli anni attorno ad una vecchia torre. Utilizzato nei secoli come fattoria, stalla, deposito, salumeria, atelier d’artista, versava in condizioni di abbandono. La sfida è stata quella di realizzare una residenza contemporanea senza disperdere quella preziosa patina che il tempo aveva disegnato sulle superfici e negli spazi.
I committenti. Due sorelle con le loro famiglie. Giovani, imprenditori, viaggiatori. Cercavano una casa, aperta, verde, sospesa, dove ritirarsi nei momenti di vita famigliare. Il loro desiderio era di condividere gran parte dei momenti di vita domestica. Una doppia residenza, che sapesse armonizzare vita collettiva e spazi privati, senza stravolgerne l’identità rurale.
Progetto. L’edificio, prossimo al collasso, è stato completamente recuperato; le parti più compromesse sono state ricucite con materiali di recupero e tecniche originarie. I volumi più recenti sono stati sostituiti da architetture contemporanee, in un dialogo dinamico e schietto.
Il podere. Il Bussolaio è un’antica casa colonica di Travalle, Calenzano, lungo l’antica via che attraverso l’Appennino portava in Emilia. Un complesso di fabbricati costruiti negli anni attorno ad una vecchia torre. Utilizzato nei secoli come fattoria, stalla, deposito, salumeria, atelier d’artista, versava in condizioni di abbandono. La sfida è stata quella di realizzare una residenza contemporanea senza disperdere quella preziosa patina che il tempo aveva disegnato sulle superfici e negli spazi.
I committenti. Due sorelle con le loro famiglie. Giovani, imprenditori, viaggiatori. Cercavano una casa, aperta, verde, sospesa, dove ritirarsi nei momenti di vita famigliare. Il loro desiderio era di condividere gran parte dei momenti di vita domestica. Una doppia residenza, che sapesse armonizzare vita collettiva e spazi privati, senza stravolgerne l’identità rurale.
Progetto. Il progetto comprende anche tutto l’interior design, il disegno degli arredi fissi e la scelta degli arredi mobili. Pavimenti in cemento-resina, arredi in ferro grezzo, modernariato e arredi contemporanei, dialogano con la straordinaria luce dei fienili, le antiche travi, gli spessi muri a calce naturale.
L’attuale fase di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Firenze si inserisce in una lunga scia di interventi che nel corso degli ultimi quattro secoli hanno interessato l’omonimo complesso. L’intervento si è sviluppato lungo due direttrici principali: l’inserimento di funzioni contemporanee con i necessari adeguamenti da una parte, e il mantenimento dell’integrità storica della struttura dall’altra. Il progetto ha lavorato per l’armonizzazione dell’insieme, studiando e analizzando, negli spazi esistenti al piano terra e al piano primo, le varie possibilità che rispondessero alle esigenze richieste dalle varie attività da insediare, unitamente alle indicazioni fornite dal maestro Franco Zeffirelli, senza però sminuire la natura di manufatto storico, architettonico e monumentale del complesso, raro esempio di architettura barocca a Firenze. Lo scopo è di suddividere gli spazi mantenendo una separazione netta tra le varie destinazioni, tutte comunque sempre in simbiosi tra loro attraverso la fluidità dei percorsi. Un recupero, con la creazione di un nuovo contenitore culturale dell’opera del maestro Franco Zeffirelli, grazie al riuso del complesso di San Firenze in risposta alle nuove funzioni, nel pieno rispetto e tutela di un edificio storico monumentale che potrà finalmente riaprire le sue porte alla città, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori occasionali, in stretto legame e simbiosi con il circostante patrimonio storico del tessuto urbano di Firenze.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Il progetto per l’enoteca BUCA 10 è un pentagramma di ferro che esalta le volumetrie degli ambienti differenziati del locale. La sala concerti affaccia sulla strada con una prospettiva allungata che il progetto enfatizza con due lunghe panche da convivio, che invitano a sedersi l’uno accanto all’altro. All’intradosso, delle sedute estraibili ampliano all’occorrenza i posti disponibili. I tavoli in ferro segnano una metrica verticale, con la caratteristica forma a “stelo”, che sintetizza le gestualità conviviali: un elemento longilineo nasce dal pavimento e si ramifica in tre piatti saldati in opera; i piccoli incavi accolgono il collo del calice. Il complesso di elementi sottili o estraibili, permette di utilizzare l’ambiente sia come sala concerti che come sala degustazione. Gli spazi connettivi, dopo una dilatazione all’ingresso che accoglie il bancone, si rastremano in una stretta galleria. Un pentagramma di tubolari disegna qui una sovrastruttura che ora accoglie i corpi illuminanti, ora espone pregiate etichette, ora espone le opere d’arte, e ci accompagna verso la conclusione della promenade: la sala degustazioni. In questo spazio cubico quattro tavoli quadrati fluttuano sospesi ad un sistema reticolare. L’innesto distribuisce l’illuminazione e gli stessi tavoli diventano a loro volta supporto per piani removibili in legno. Il rituale della degustazione incontra uno scenario che ne esalta la sacralità, arricchendo le percezioni alla ricerca di una seducente sinestesia.
Il progetto in piazza Gino Bartali rappresenta un esperimento attraverso il quale abbiamo unito la necessità di creare uno spazio polivalente che potesse accogliere, nel periodo estivo, un programma culturale di eventi e la volontà di costruire la base di un processo di riqualificazione a lungo termine. La struttura del progetto prevede trenta moduli funzionali alle principali esigenze per la fruizione dello spazio pubblico. Attraverso il movimento ed il gioco, l’intento è stato quello di innescare nuove interazioni tra gli abitanti e i luoghi della loro quotidianità. La strategia applicata, infatti, assume come fautori dei luoghi urbani gli stessi abitanti e attraverso essi ricerca una maggiore aderenza alle reali necessità. Primo tassello di un processo step by step, la flessibilità dell’intervento prevede un progressivo adattamento secondo scenari urbani possibili. Il progetto analizza e ripensa quindi i luoghi della città come insiemi aperti dove lo spazio urbano è il risultato di un meta-progetto comune. Purtroppo in fase esecutiva è stata negata, per questioni di sicurezza, la possibilità di dotare i moduli di ruote. Nonostante questa limitazione i feedback degli utenti sono stati possibili grazie a dei questionari presenti in loco. La scelta dei materiali ed il loro reperimento si inserisce all’interno di un modello di economia sostenibile definito circolare tramite il quale, una volta utilizzati, questi vengono reinseriti all’interno del loro processo produttivo.
Un muro recinto percorso avvolge i volumi essenziali dell’atelier disegnando spazi vuoti… spazi per l’arte. L’idea di Atelier alla base del progetto è che abbia le potenzialità per evolversi gradualmente nel tempo in un organismo più complesso, un polo delle arti contemporanee che possa ospitare mostre e performance, in stretto rapporto con il territorio e le sue specificità, con una grande attenzione alle accademie d’arte e in stretto contatto con i laboratori artigianali presenti nel luogo. Dalla corte centrale si svolge la rampa che, con la sua leggera pendenza, a spirale, dinamizza e mette in relazione tutti gli spazi esterni, penetra il corpo principale, lambisce le ampie terrazze e ridiscende infine nel cuore della collina per diventare un percorso ipogeo a supporto dello spazio di futura espansione previsto interamente scavato nel profilo della collina. La superficie del muro-percorso è realizzata con un impasto di terre e pozzolana steso su un sottofondo di giunchi intrecciati e parzialmente bruciati. Il muro ha il colore della terra, una pelle viva, mai uguale nel tempo, che seguirà il lento degrado del giunco, supporto ideale per la vegetazione che man mano lo sostituirà. Il progetto per sua vocazione pone grande attenzione ai materiali ed all’utilizzo di criteri di sostenibilità, in particolare è stato previsto l’utilizzo del legno per le strutture e una parte dei rivestimenti esterni. Pietra, fibre naturali, calce e argilla per gli altri rivestimenti esterni.
L’attuale fase di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Firenze si inserisce in una lunga scia di interventi che nel corso degli ultimi quattro secoli hanno interessato l’omonimo complesso. L’intervento si è sviluppato lungo due direttrici principali: l’inserimento di funzioni contemporanee con i necessari adeguamenti da una parte, e il mantenimento dell’integrità storica della struttura dall’altra. Il progetto ha lavorato per l’armonizzazione dell’insieme, studiando e analizzando, negli spazi esistenti al piano terra e al piano primo, le varie possibilità che rispondessero alle esigenze richieste dalle varie attività da insediare, unitamente alle indicazioni fornite dal maestro Franco Zeffirelli, senza però sminuire la natura di manufatto storico, architettonico e monumentale del complesso, raro esempio di architettura barocca a Firenze. Lo scopo è di suddividere gli spazi mantenendo una separazione netta tra le varie destinazioni, tutte comunque sempre in simbiosi tra loro attraverso la fluidità dei percorsi. Un recupero, con la creazione di un nuovo contenitore culturale dell’opera del maestro Franco Zeffirelli, grazie al riuso del complesso di San Firenze in risposta alle nuove funzioni, nel pieno rispetto e tutela di un edificio storico monumentale che potrà finalmente riaprire le sue porte alla città, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori occasionali, in stretto legame e simbiosi con il circostante patrimonio storico del tessuto urbano di Firenze.
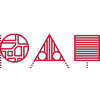
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix