

L’attuale fase di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Firenze si inserisce in una lunga scia di interventi che nel corso degli ultimi quattro secoli hanno interessato l’omonimo complesso. L’intervento si è sviluppato lungo due direttrici principali: l’inserimento di funzioni contemporanee con i necessari adeguamenti da una parte, e il mantenimento dell’integrità storica della struttura dall’altra. Il progetto ha lavorato per l’armonizzazione dell’insieme, studiando e analizzando, negli spazi esistenti al piano terra e al piano primo, le varie possibilità che rispondessero alle esigenze richieste dalle varie attività da insediare, unitamente alle indicazioni fornite dal maestro Franco Zeffirelli, senza però sminuire la natura di manufatto storico, architettonico e monumentale del complesso, raro esempio di architettura barocca a Firenze. Lo scopo è di suddividere gli spazi mantenendo una separazione netta tra le varie destinazioni, tutte comunque sempre in simbiosi tra loro attraverso la fluidità dei percorsi. Un recupero, con la creazione di un nuovo contenitore culturale dell’opera del maestro Franco Zeffirelli, grazie al riuso del complesso di San Firenze in risposta alle nuove funzioni, nel pieno rispetto e tutela di un edificio storico monumentale che potrà finalmente riaprire le sue porte alla città, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori occasionali, in stretto legame e simbiosi con il circostante patrimonio storico del tessuto urbano di Firenze.
Edificio pontremolese del XVIII secolo, Palazzo Damiani è parte privato –ancora in stato di abbandono– e parte comunale, affidato a ERP spa per la realizzazione di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica. Molto articolato, con tre corti, due scaloni monumentali, vani per depositi di merci, spazi commerciali, piano nobile e numerosissimi ambienti residenziali, affianca al restauro calibrato e rispettoso, con opere di consolidamento eseguite con materiali ad alta tecnologia ma di bassissimo impatto o realizzate con tecniche tradizionali per esaltare la materia antica, un progetto che ha arricchito lo spazio di nuovi modi d’uso per imprimere all’edificio la vitalità necessaria a superare il tema scontato di luogo di accoglienza ma anche isolamento per famiglie disagiate: le superfici “sprecate”, diventano ambienti comuni e condivisi ai vari piani, le corti coperte a vetri, luoghi di vita quotidiana, gli ambienti per i magazzini, centro per il coworking e il vano adiacente l’androne di ingresso verso il quartiere di San Giacomo si trasforma in galleria pubblica che caratterizza e apre il palazzo alla città insieme all’area di sosta, allo spazio verde con parco giochi e rampa di accesso inclusiva, al rinnovato rapporto con la zona extra moenia della stazione, di recente recuperata con ampio parcheggio scambiatore. L’intervento di ERP spa innesca e favorisce la rinascita dell’edificio storico integrando antiche funzioni e nuovi valori, urbani, architettonici e sociali.
L’intervento si è rilevato per condizioni e per scelta, composito, in quanto ha adottato e combinato tra loro più registri di mera conservazione, di risarcimento, di aggiunta, di manutenzione. Il progetto ha ricercato un’assonanza temperata tra le parti attraverso l’utilizzo di materiali affini e compatibili, proponendo un risultato che ha voluto essere sobrio ma ha rifiutato di essere neutrale ha cercato cioè di riconnettere le parti preesistenti alle nuove integrazioni senza rimarcare la discontinuità ma senza nemmeno mascherarla, affidandosi sopratutto al differenziale dovuto all’assenza di degrado e patinatura dei nuovi materiali rispetto agli antichi e a contatti nitidi che rispettano le tracce antiche senza però ostentarle in modo “scientifico“. La scelta è stata quella di condurre un intervento per così dire prudente, discreto in un certo qual modo timido da risultare quasi “trasparente” che ha permesso di conservare e rispettare i caratteri delle superficie preesistenti. L’intervento sulle strutture è stato anch’esso sviluppato in modo da minimizzare l’impatto e non alterare il meccanismo statico preesistente, dove ciò non è stato possibile si è reso reversibile al fine di poterlo rimuovere nel caso di mutate necessità o di avanzamento tecnologico: non sostituzione dell’organismo statico con uno diverso, ma restituzione alle strutture preesistenti dei loro compiti e delle loro caratteristiche con l’eventuale aiuto, dove si è reso necessario, di strutture integrative.
L’intervento qui presentato rientra nel più generale progetto di manutenzione e riammodernamento del complesso della Cantina della Società Cooperativa di Pitigliano, attivo già a partire dagli anni Cinquanta, finanziato con fondi della Regione Toscana e della cantina stessa. Si tratta qui del nuovo punto vendita e degustazione non solo del vino ma anche dell’olio e dei prodotti locali. Viene completamente ristrutturata la parte terminale del capannone in cemento armato prefabbricato con funzioni di deposito direttamente prospiciente all’entrata del complesso. Il fronte e la testata del capannone sono stati completamente ripensati attraverso la realizzazione di una nuova pensilina inclinata con struttura in acciaio zincato e rivestimento in lastre di corten asolate direttamente appesa alle travi esistenti in cemento armato prefabbricato, e creando un nuovo spazio adibito a punto vendita e separato dal magazzino per mezzo di pareti realizzate con pannelli sandwich coibentati con una facciata, quella verso il punto vendita, rivestita in lamiera di corten. Tutta la nuova pensilina ed un nuovo volume sporgente dal corpo di fabbrica sempre rivestito in lastre di corten con il logo della cantina ritagliato al laser, sono retroilluminati in modo da creare un effetto particolare durante le ore notturne. Il punto vendita è chiuso verso l’esterno da una grande vetrata anch’essa con profili di corten che permette di percepire in modo immediato e diretto i prodotti in vendita all’interno.
Nel bel mezzo di un oliveto, ci troviamo ad operare su di un abuso edilizio. Nata come una baracca di legno, divenne in un momento non ben precisato una casetta di mattoni forati. Nel passaggio di proprietà il suo destino sarebbe stata la demolizione, ma perché mai dover produrre quintali di macerie quando si può tentare un riuso? Come esser certi che anche la platea fondativa in cemento armato sarebbe stata effettivamente eliminata? Abbiamo condotto una trattativa con l’ufficio tecnico comunale per fare in modo che il cliente non perdesse il bene acquisito e che il paesaggio potesse redimersi dall’abuso. Si è deciso che la preesistenza potesse essere ammantata di una veste lignea, camaleontica per rapporto alla tonalità della terra, dei tronchi nodosi degli ulivi e dei cipressi circostanti. L’intero perimetro murario della casetta, copertura compresa, è stato rivestito da balle di paglia raccolte nei campi circostanti. A chiusura dell’involucro edilizio sono state avvitate sui telai d’abete delle assi da ponte usate e passate a fiamma per aumentarne la resistenza nel tempo, facendo così rivivere un’antica tecnica contadina sprofondata nell’oblio. Se gli esterni restituiscono le scure tonalità dei tronchi e della terra, l’interno è un abbagliante scrigno dorato al quale si demanda in qualche modo il ricordo dell’occultato involucro di paglia. Gli intonaci di calce sono ricavati da argille scavate nei campi circostanti e applicate con grande sapienza artigianale.
L’intervento di recupero interessa porzione di un più vasto fabbricato abitativo realizzato nei primi anni Sessanta del secolo scorso. Il fabbricato era stato edificato con tecnologie tradizionali in uso nel momento ossia muratura portante di mattoni, solai in latero-cemento, copertura a falde inclinate in travetti prefabbricati e manto in tegole di laterizio. L’abitazione è definita da due piani fuori terra con zona giorno al piano inferiore e zona notte a quello superiore. Il tutto ruota intorno allo spostamento della scala di accesso al piano primo da uno specifico vano attestante l’esterno alla zona dell’ingresso e prevede anche la traslazione delle pareti attestanti direttamente sul nuovo disimpegno–vano scala. Ciò ha richiesto un significativo intervento di ridefinizione degli elementi strutturali del manufatto con la messa in opera di longarine metalliche sia nella ricucitura della primitiva trama portante sia per la nuova scala. Pochi e chiari elementi, una scala ed una articolata struttura metallica che si inseriscono nel primitivo manufatto con la forza derivante dal loro essere “ferro” imponendosi per la contemporaneità del linguaggio e la delicatezza del tratto ed una parete colorata di rosso che fa da contrappunto ad un pavimento in pietra levigata al piano terra ed in legno al primo, concorrono a trasformare un comune e tipologicamente datato “terratetto” in una abitazione aperta in linea con i modi del vivere contemporaneo.
Il progetto di recupero e riuso del Palazzo Pretorio di Pontedera, PALP, nasce dalla volontà di rilanciare un importante edificio del centro storico offrendo una risposta all’abbandono, attraverso una proposta di rifunzionalizzazione dell’edificio che andasse a creare uno spazio urbano strategico di incontro e scambio per la città. Partendo dalla lettura della sua storia di stratificazioni nei vari periodi architettonici l’intervento di recupero a fini culturali, istituzionali e ricreativi è risultato fin dall’inizio estremamente complesso. Il progetto in linea con quanto richiesto dal bando, ha previsto al piano terra nella parte del loggiato chiuso da vetrate, un ristorante una zona caffetteria e area living. Sulle pareti del loggiato sono state conservate le targhe commemorative presenti e per annullare il classico effetto bar è stato progettato un giardino verticale con sedici essenze selezionate da botanici che caratterizza l’ambiente creando uno sfondo scenografico. Il piano primo, che si sviluppa su due livelli, ospita il nuovo spazio espositivo. Grazie alla disposizione sequenziale degli ambienti con piccole demolizioni ed accorgimenti è stato possibile realizzare uno spazio museale di dieci sale e la sala accoglienza/biglietteria e servizi vari per una superficie di circa 700 mq.
Nella cantina di una villa sulle colline di Firenze, a Pian dei Giullari, si è tentato di risolvere un problema attraverso un esperimento abitativo: convertire l’ambiente composto da un’unica stanza in un appartamento, non cadendo nell’errore di separare gli ambienti nettamente con pareti vere e proprie togliendo aria, luce, spazio e rimpicciolendo la percezione visiva della dimensione totale del volume; né tanto meno in quello di lasciare un ambiente unico indiviso e invivibile composto da zone con funzioni diverse separate solo idealmente da linee immaginarie (loft). Il principale talento di un architetto è quello di risolvere, con un unico gesto, il maggior numero di problemi progettuali. La soluzione, ovvero il gesto, che si adotta può essere formale o tecnica, ma l’importante è che risponda sempre al tentativo di una sintesi architettonica: “faire d’une pierre deux coups” o “to kill two birds with one stone”. In questo caso il gesto e il progetto coincidono. La soluzione è un cubo che divide e determina gli spazi. Non si deve però pensare al cubo come ad un’opera d’arte: “l’architettura non è un’arte, poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte” (A. Loos). Il cubo è in definitiva un mezzo, formale e tecnico allo stesso tempo, per arrivare allo scopo di convertire una cantina di una antica villa fiorentina in un appartamento in cui gli ambienti siano piacevoli e indipendenti tra loro; che poi era la sfida progettuale proposta dal committente.
La casa è stata costruita in una radura tra ulivi, lecci e pini marittimi a metà collina tra la piana di Lucca e l’altopiano delle Pizzorne. Alla costruzione esistente sono stati aggiunti due ampliamenti, uno sulla testata nord-ovest, l’altro, parzialmente interrato, verso nord-est. La parte esistente è intonacata e tinteggiata a calce, quella nuova in pietra di Guamo (Verrucano dei Monti Pisani). Il fronte sud dell’ampliamento è un infilata di pilastri massicci a doppia altezza e i serramenti sono arretrati per ripararsi meglio dal sole e dall’acqua. Il volume dell’entrata della casa è l’unione tra il vecchio e il nuovo: a sud l’esistente mentre a nord una galleria si allunga per spingere il nuovo volume a trovare lo spazio libero e la vista verso valle e Lucca. L’infilata dei nuovi volumi inclinandosi verso nord-est facilitano l’apertura della corte verso il verde della radura. Le due facciate dell’entrata sono due portali uguali in pietra di Santafiora sabbiata, una è il fondale di un cortile stretto e lungo ed è l’entrata principale della casa, l’altra del cortile aperto verso il verde. I serramenti e le persiane sono in legno verniciato. I cortili e i marciapiedi sono in Santafiora sabbiata. Una scala è in ferro, l’altra è in ferro e legno wengé. Le tinteggiature interne sono chiare. La struttura del nuovo edificio è un telaio in c.a. con appoggiati il tetto a capriate e il solaio in travi e travicelli in legno di castagno. I nuovi edifici sono in classe energetica A3.
Inserita tra le Giornate FAI 2018, la torre è posta sulle cime del monte omonimo, Montalceto. Costruita nel 1463 dal senese Matteo di Pinoccio, possiede una forma quadrangolare con accentuato basamento a scarpa; prima del restauro la torre si presentava completamente aperta, con i tre solai e parte del coronamento crollati. Il restauro, condotto con la soprintendenza di Siena, ha portato al fedele recupero delle caratteristiche originarie, fino al riutilizzo dei conci in pietra reperiti sul posto.
La villa oggetto d’intervento è ubicata sulle colline di Firenze. Il progetto si basa sull’idea che un’architettura storica può e deve rispondere alle esigenze abitative contemporanee in fatto di funzionalità, comfort e tecnologia grazie a interventi condotti nel rispetto della struttura originale e con criteri che nulla concedano al “gusto” e alla “moda” del momento. I vincoli di tutela dei beni culturali possono essere affrontati come ulteriori elementi di sfida, per soddisfare le nuove richieste della committenza. L’intervento nasce dall’esigenza, di accorpare le unità immobiliari, realizzate nel tempo, ricomponendo l’originario organismo unifamiliare, secondo scelte progettuali frutto di ricerche storico-documentali. L’edificio ha subito nel corso del tempo modifiche che hanno alterato irreversibilmente gli interni, a differenza degli esterni che non sono sostanzialmente mutati. Il lavoro architettonico si è tradotto nella completa reinterpretazione funzionale degli interni e nel restauro degli esterni. La muratura esterna in Pietraforte, è stata recuperata con un restauro puntuale e il rifacimento delle parti mancanti.Gli interni sono stati progettati nel rispetto dell’impianto originale. La funzionalità e il comfort, seppur in spazi rigidi, sono stati raggiunti con la progettazione di tutti gli arredi e con l’adozione di un sistema integrato di gestione degli impianti, realizzato rispettando le caratteristiche dell’immobile e limitando le tracce invasive nelle murature.
Posta in un parco di 3.500 mq sulla collina di Marignolle a Firenze la villa di 200 mq venne costruita nei primi anni ’70 del secolo scorso ed è rimasta sostanzialmente immutata fino alla attuale ristrutturazione che ha interessato, oltre agli interni, anche il disegno dei prospetti e delle aree che circondano l’edificio dove è stata inserita una nuova piscina “a sfioro” di 28 mq che si affaccia verso la valle sottostante. Dalla zona giorno due grandi vetrate si aprono sull’ampio deck in legno che separa l’edificio dalla piscina e che circonda completamente la villa. L’intervento ha migliorato sensibilmente la prestazione energetica dell’edificio che è oggi completamente protetto da un “cappotto” termico esternamente rivestito con lastre di travertino. Lo skyline dell’edificio –circondato da cipressi, ulivi e pini marittimi– è stato completamente modificato dall’inserimento di nuovi ampi aggetti della copertura che proteggono i percorsi esterni in legno di larice.
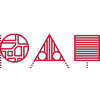
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix