

La nuova sede di Find Facility Net è il risultato di un intervento di ristrutturazione che ha cercato di reinterpretare gli spazi interni di un’unità immobiliare ad uso ufficio, posta al piano primo di un fabbricato situato nel centro storico di Pontedera. Il progetto si è posto l’obiettivo di rimuovere l’impostazione classica di ufficio caratterizzata da spazi chiusi in sé stessi e corridoi bui, per creare un ambiente più dinamico e stimolante per le attività svolte. Attraverso la rimozione di tramezzi si genera un unico spazio aperto, fluido e luminoso, dove volumi di forma organica si inseriscono in corrispondenza dei setti conservati per necessità strutturali, rivestendoli e creando nuove relazioni con lo spazio. Questi volumi diventano il fulcro del progetto anche grazie all’uso del colore che permette di orientare i vari ambienti nello spazio organico. Infine un ruolo fondamentale viene assunto anche dagli arredi, andando a connotare i diversi ambienti secondo colori e matericità diverse. Tutti i diversi ambienti sono in relazione l’uno con l’altro risultando un unico spazio di lavoro condiviso dove le partizioni vetrate favoriscono rapporti di collaborazione continui.
Piazza del Tiratoio. In quella che fu la zona destinata alla lavorazione della lana nell’Oltrarno fiorentino, un nuovo cocktail bar trova collocazione all’interno di un grande spazio voltato a più campate, già rimessaggio per barche. La zona di somministrazione è filtrata da uno spazio di soglia destinato a giardino d’inverno. Il bancone domina lo spazio e gerarchizza le funzioni svelandosi dietro a un infisso vetrato centinato. I servizi igienici e i locali accessori sono dietro a una parete espositiva che fa da sfondo al locale. Terracotta nera, tinteggiature a calce e ottone spazzolato garantiscono un’atmosfera accogliente e delicata che accompagna i clienti nei sapori della miscelazione senza sopraffarli. Credits Cliente: Bi.Bi & co s.r.l Anno: 2021-2022 Luogo: Firenze, Italia Dimensione: 150 mq Team: AFSa (Antonio Acocella, Alessandro Falaschi, Pietro Seghi) Collaboratori: Paolo Buti, Clemente Nativi Imprese: Idealforme 2000, Malte Storiche, ACS automatismi, CM Clima Fornitori: Fameg, Ceramica Cielo, Cotto Manetti, Ciulli, CIAM Fotografia: Fabio Semeraro
Oggetto della presente proposta è la realizzazione di una sala multifunzionale nel Comune di Pisa, quartiere “I Passi”, nell’ambito del progetto “PIU” (PIANI DI INNOVAZIONE URBANA), che ha lo scopo di dotare la comunità di uno spazio che diventi luogo di incontro, di scambio e di arricchimento personale e collettivo. L’edificio ha la funzione principale di auditorium fruibile sia dal quartiere che dall’intera città, ma come già detto, si configura come uno spazio multifunzionale. Nella fase di studio sono stati presi a riferimento gli edifici presenti nel quartiere ed è emerso che la gran parte dei fabbricati esistenti sono di natura residenziale e realizzati con mattoni facciavista, mentre il complesso parrocchiale del quartiere è un edificio dalle forme nette e squadrate in calcestruzzo armato, che quindi si distingue dal resto dell’edificato rendendolo facilmente identificabile. L’area oggetto dell’intervento si colloca a nord di Pisa in un’area a prevalenza residenziale di origine popolare derivante principalmente da una lottizzazione INA Casa degli anni 50 e 60. Nel quartiere sono presenti i principali servizi: la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, la chiesa ed un complesso sportivo. Il volume della sala polivalente è articolato su due piani fuori terra; il piano terra è realizzato su strutture puntiformi, offrendo così un porticato ed una piazza coperta dalla quale si accede al piano primo, dove si è ubicata la sala che ha una disponibilità di 120 posti.
L’area di progetto è posta in una zona semicentrale, in prossimità dell’attuale centro direzionale, in un contesto prettamente residenziale. Il circostante contesto urbano, mostra un edificato di scarso valore paesaggistico oltre che architettonico. Si tratta di edifici multipiano realizzati per lo più negli anni’70, con facciate ad intonaco, cemento armato a vista e finiture di scarso pregio, le cui imponenti volumetrie bloccano le viste dal basso verso le colline o le emergenze più prossime. La mancata riqualificazione degli spazi verdi circostanti e dell’area sportiva, nel corso degli anni ha determinato una condizione di vuoto percettivo. In questo ambito il progetto proposto, che sintetizza la cura formale ed estetica alla sostenibilità ambientale, è in grado di sviluppare soluzioni che coniugano risparmi energetici apprezzabili a linguaggi formali, percettivi-estetici adatti alla riqualificazione di aree di interesse notevole per la città di Scandicci. L’intervento, infatti, propone soluzioni per la definizione di un linguaggio morfologico e formale attraverso elementi capaci di migliorare l’aspetto percettivo dell’intero isolato e di introdurre elementi di eco-sostenibilità in grado di migliorare lo spazio abitato. All’interno di una complessiva pianificazione sostenibile del governo delle città, che contempli in modo coordinato tutti gli aspetti della vita delle comunità, dalla gestione dei rifiuti ai trasporti, la qualità degli edifici gioca un ruolo chiave, sia che
La struttura dell’antica stalla di una casa colonica, sulle colline che guardano il golfo di Talamone, è oggetto dell’intervento di restauro “Podere Civitella” che ruota fin da subito su due cardini: la passione dei clienti per il mondo dell’arte e l’importante carattere storico dell’edificio toscano. Nel rispondere alla necessità di inserire tre camere da letto con rispettivi bagni si è deciso di rispettare l’impianto originale a due navate, dedicandone una alla zona notte ed una a quella giorno. Le morbide curve delle pareti, inserite nella rigida struttura rurale, dapprima definiscono con la loro parte concava gli spazi delle camere per poi ricavare con la controparte convessa i bagni, in un flusso sempre più intimo che porta alle ampie docce circolari. Gli spazi giorno si articolano in tre momenti: la cucina con la sala da pranzo, il grande salotto conviviale e la zona del camino. Questa enfilade, scandita dai preesistenti archi a tutto sesto, permette una comunicazione tra gli spazi della vita quotidiana senza mai sovrapporli. I pezzi iconici di Pistoletto o di Ceroli, con gli altri dipinti e sculture, cercano il dialogo con le tonalità e le finiture scelte. Lo storico pavimento in cotto del soggiorno si reinventa nel mosaico color mattone della zona notte, le travi dipinte interagiscono con i toni verdi dei soffitti delle camere, plasmando l’atmosfera della nuova stalla restaurata: rigorosa nelle sue geometrie esterne ed armoniosa nelle forme e tonalità interne.
Il bastione del Parlascio è stato realizzato a ridosso di una delle porte di accesso alla città, facente parte della cinta muraria del XII secolo, che ha subito numerosi interventi di ampliamento. I primi interventi riguardarono la costruzione di una torre portaia del 1320 e di un’antiporta eretta nel 1324, la costruzione di un fortilizio su progetto del Brunelleschi a partire dal 1435 e la costruzione del bastione di Nanni Ungaro eretto tra il 1542 e il 1544. Il bastione perse la sua funzione difensiva nel corso del XVIII secolo, quando venne utilizzato come deposito per il ghiaccio; successivamente durante l’ultimo conflitto, a seguito di modifiche, la struttura è stata usata come rifugio antiaereo. Dagli anni 60 agli anni 90 del secolo passato la struttura è stata usata come autofficina. Il bastione del Parlascio, che è parte integrante e sostanziale del progetto mura, è situato in prossimità dell’area archeologica delle Terme Romane, sul prolungamento dell’asse pedonale di Borgo Stretto e Borgo Largo, risulta un punto strategico dal punto di vista dell’interesse architettonico e dal punto di vista dell’accessibilità al percorso in quota alle mura urbane, in quanto al suo interno è previsto uno dei punti di salita. Il complesso architettonico con il restauro e recupero garantisce un’accoglienza turistica al suo interno con l’utilizzo degli spazi per informazioni, sosta, mostre; inoltre consentirà il suo attraversamento interno con un percorso pedonale pubblico.
La struttura dell’antica stalla di una casa colonica, sulle colline che guardano il golfo di Talamone, è oggetto dell’intervento di restauro “Podere Civitella” che ruota fin da subito su due cardini: la passione dei clienti per il mondo dell’arte e l’importante carattere storico dell’edificio toscano. Nel rispondere alla necessità di inserire tre camere da letto con rispettivi bagni si è deciso di rispettare l’impianto originale a due navate, dedicandone una alla zona notte ed una a quella giorno. Le morbide curve delle pareti, inserite nella rigida struttura rurale, dapprima definiscono con la loro parte concava gli spazi delle camere per poi ricavare con la controparte convessa i bagni, in un flusso sempre più intimo che porta alle ampie docce circolari. Gli spazi giorno si articolano in tre momenti: la cucina con la sala da pranzo, il grande salotto conviviale e la zona del camino. Questa enfilade, scandita dai preesistenti archi a tutto sesto, permette una comunicazione tra gli spazi della vita quotidiana senza mai sovrapporli. I pezzi iconici di Pistoletto o di Ceroli, con gli altri dipinti e sculture, cercano il dialogo con le tonalità e le finiture scelte. Lo storico pavimento in cotto del soggiorno si reinventa nel mosaico color mattone della zona notte, le travi dipinte interagiscono con i toni verdi dei soffitti delle camere, plasmando l’atmosfera della nuova stalla restaurata: rigorosa nelle sue geometrie esterne ed armoniosa nelle forme e tonalità interne.
Il progetto è frutto della partecipazione ad un concorso, nel quale era posto a base di gara un progetto preliminare, rispetto al quale era richiesto di presentare delle modifiche. Il progetto è risultato vincitore della gara e la soluzione proposta e realizzata ha trovato un grande apprezzamento da parte della committenza. L’edificio del nuovo Ingresso costituisce il primo fondamentale impatto tra Ospedale ed utenza. Nella consapevolezza di quanto questo primo rapporto con la struttura sia fondamentale, il progetto nasce con la precisa volontà di dare una maggiore visibilità e protagonismo al nuovo Ingresso, rispetto a quanto ipotizzato nel progetto posto a base di gara, attraverso una spazialità generosa con un aggetto che ricuce i volumi sottostanti, scherma i prospetti vetrati e offre un luogo accogliente – e non solo di transito – dove poter sostare e socializzare. Gli spazi esterni protetti sono concepiti per creare uno spazio pubblico nel verde e, al tempo stesso, per comunicare una riconoscibile accoglienza che agevoli anche l’orientamento ed il wayfinding, in questo modo la nuova loggia ed il nuovo landscaping offrono protezione e massima accoglienza. La maggior caratterizzazione estetico architettonica del nuovo Ingresso dialoga con la struttura preesistente, ricercando una composizione spaziale e materica rivolta a riqualificare l’intero complesso.
Ubik architecture firma la nuova cantina vinicola “Tenuta il Quinto” sulle colline di Magliano in Toscana, un piccolo paese in provincia di Grosseto. La sua architettura è stata pensata per entrare in mimesi con il paesaggio e lasciarsi scoprire a poco a poco, attraversando la tenuta che la ospita e rifuggendo qualsiasi tentativo di monumentalismo. La cantina è stata posizionata in modo da massimizzarne l’integrazione nel paesaggio, riducendo al contempo gli scavi. Il suo volume si inserisce, infatti, nel reticolo stradale esistente ricongiungendo i vari percorsi posti a livelli diversi, evitando la realizzazione di nuove strade, nella consapevolezza che in ambito paesaggistico tali elementi possono essere più impattanti degli edifici. La nuova architettura della cantina è generata attraverso le linee del paesaggio esistente. Idea che il visitatore legge chiaramente nei nastri metallici che caratterizzano la cantina, i quali cambiano significato nel loro scorrere, trasformandosi da strada a muro, da muro a copertura, fino a fondersi nuovamente nel reticolo viario poderale. Quando si arriva alla tenuta siamo circondati dal verde del paesaggio maremmano e la vista si apre fino al promontorio dell’Argentario. Quella che sembra una collina tra le altre, è l’ingresso della cantina che nasce dal terreno. La sua facciata, realizzata con la pietra proveniente dagli stessi scavi ed elementi di corten si integra con i colori della campagna circostante. Tale scelta progettuale sottolinea la rice
Il progetto prevede la suddivisione di un grande fienile recuperato nei primi anni duemila nel territorio del Chianti Classico in due unità immobiliari, una delle quali ampliata di volume. Quest’ultima, al fine di soddisfare le esigenze di una giovane coppia di professionisti, viene dotata di un nuovo collegamento verticale e riprogettata nei suoi spazi interni e nel nuovo involucro edilizio. Il cotto fatto a mano , il legno di rovere e il travertino di Rapolano caratterizzano gli ambienti caldi e accoglienti degli interni, sempre in diretto contatto visivo con la natura all’esterno della casa. Il rapporto tra interno ed esterno è infatti una costante materica e percettiva del progetto, amplificato dalle grandi superfici vetrate e dalla presenza di abbondante illuminazione naturale. Le superfici esterne dell’ampliamento sono finite con intonaco a cocciopesto in discontinuità con le superfici dell’esistente, per rendere di chiara leggibilità l’addizione volumetrica. Cliente: Privato Anno: 2020 – 2021 Luogo: Sambuca Val di Pesa, Italia Dimensione: 130 mq Team: AFSa (Antonio Acocella, Alessandro Falaschi, Pietro Seghi) Collaboratori: Tecla Nencini Imprese: Hallulli Enver, Trambusti, 2P, Falegnameria Frazzetta Forniture: Cotto Manetti, Arredo di Pietra, Malte Storiche, Illux Fotografia: Fabio Semeraro
Lo scenario paesistico in cui è inserito il borgo di Torri trova la sua unicità nelle relazioni tra gli elementi che lo compongono: il centro storico dialoga con il paesaggio agrario modellato dall’azione antropica nel corso dei secoli. La lettura del territorio è stata quindi fondamentale per un progetto che mirasse a recuperare gli spazi pubblici del borgo, volendo fornire anche una chiave di lettura della memoria storica del tessuto urbanistico. L’intervento si costituisce quindi di un nuovo disegno dei luoghi cardine della socialità di Torri restituito tramite lo studio ed il ricordo della coltura a grano, la più diffusa nel territorio di pertinenza produttiva del borgo: una pavimentazione architettonica con ghiaia a vista, eco dell’antica viabilità in terra battuta, si intreccia a ricorsi in pietra calcarea, riflesso dei solchi tracciati con l’aratro durante la semina. Le necessità tecnologiche del materiale portano quindi all’utilizzo di sottili ricorsi metallici bruniti, pretesa per l’identificazione degli antichi assi viari e del loro tracciato desunto dalle indagini di archivio. Tramite sedute in pietra ed essenze autoctone si costituisce un arredo urbano in grado di restituire gli spazi ove la socialità si condensava in tempi in cui il borgo era ancora centro nevralgico di un tessuto produttivo vocato all’agricoltura: dinamiche sociali, da tempo inaridite nei piccoli centri, che possono rinascere tramite una lettura consapevole del proprio passato.
Lo scenario paesistico in cui è inserito il borgo di Torri trova la sua unicità nelle relazioni tra gli elementi che lo compongono: il centro storico dialoga con il paesaggio agrario modellato dall’azione antropica nel corso dei secoli. La lettura del territorio è stata quindi fondamentale per un progetto che mirasse a recuperare gli spazi pubblici del borgo, volendo fornire anche una chiave di lettura della memoria storica del tessuto urbanistico. L’intervento si costituisce quindi di un nuovo disegno dei luoghi cardine della socialità di Torri restituito tramite lo studio ed il ricordo della coltura a grano, la più diffusa nel territorio di pertinenza produttiva del borgo: una pavimentazione architettonica con ghiaia a vista, eco dell’antica viabilità in terra battuta, si intreccia a ricorsi in pietra calcarea, riflesso dei solchi tracciati con l’aratro durante la semina. Le necessità tecnologiche del materiale portano quindi all’utilizzo di sottili ricorsi metallici bruniti, pretesa per l’identificazione degli antichi assi viari e del loro tracciato desunto dalle indagini di archivio. Tramite sedute in pietra ed essenze autoctone si costituisce un arredo urbano in grado di restituire gli spazi ove la socialità si condensava in tempi in cui il borgo era ancora centro nevralgico di un tessuto produttivo vocato all’agricoltura: dinamiche sociali, da tempo inaridite nei piccoli centri, che possono rinascere tramite una lettura consapevole del proprio passato.
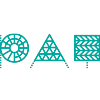
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix