

Il progetto prevede la ristrutturazione di un piccolo edificio in via della Stufa al numero civico 38 di Prato. La casa è singolare, perché singolare è la conformazione legata alla scala di ingresso che “taglia” longitudinalmente tutti i piani e consente la distribuzione e l’accesso alle varie quote. Tutti gli interventi hanno come scopo principale quello di confrontarsi con il tema dell’abitare declinato, in questo caso, nella necessità di rendere gli ambienti accoglienti e capaci di migliorare e facilitare la vita delle persone che li abiteranno senza però comprometterne l’architettura originaria. Lavorare sui prospetti diventa l’occasione per mettere in contatto la sfera privata con quella pubblica. I prospetti esterni infatti comunicano con l’esterno, con la città ma anche con l’interno, con il mondo domestico, casalingo. Il disegno dell’intonaco a sgraffito, che dialoga con quello delle persiane per forma e ritmo, è sempre teso nel far risaltare l’andamento verticale della facciata secondo un ritmo sincopato che mano a mano che sale, si apre sempre di più. Il risultato che si ottiene è quello di un fronte elegante e leggero dove i pochi elementi inseriti sono la conseguenza di una lettura sensibile del contesto, di un’interpretazione critica dell’esistente nella logica di valorizzare e potenziare la qualità architettonica dell’antico tessuto urbano della città.
La realizzazione del nuovo ampliamento è stata pensata per soddisfare quelle che sono le esigenze legate alla progressiva espansione dell’azienda Tricobiotos S.p.A. I nuovi uffici inoltre garantiranno spazi più accoglienti e in grado di restituire, in termini di comfort ambientale, un luogo di lavoro più consono alle necessità operative dell’azienda e a quelle psicofisiche del personale che vi andrà ad operare. Lavorare in un ambiente salubre, migliore, bello, sicuramente favorisce anche la performance produttiva di ogni singolo addetto. Oltre a questo l’obiettivo correlato è dare maggiore prestigio all’immobile esistente e fornire al visitatore (fornitore, cliente o istituzione) la giusta immagine e percezione del valore dei brand rappresentati. La nuova architettura è stata concepita per trasmettere al visitatore un’immagine professionale, elegante e moderna, ma al contempo sobria e priva di sfarzi o esasperazioni architettoniche. Il nuovo edificio individua, attraverso l’utilizzo di materiali diversi, le due funzioni principali: quella produttiva al piano terra e quella amministrativo-tecnica ai piani superiori. Cemento a faccia vista per la prima, lamiera sagomata in alluminio anodizzato per la seconda. L’architettura risponde alle esigenze dell’azienda attraverso un linguaggio semplice e diretto usando pochi materiali, che facilitano anche la manutenzione generale dell’immobile, e forme geometriche non complesse.
“Casa per Tre Dame” è stata progettata per tre donne, una mamma e due figlie, un forte esempio di imprenditoria femminile che dopo anni decide di tornare a vivere sotto un unico tetto, vendendo le singole abitazioni per costruire un nuovo ed unico nucleo edificato. L’obiettivo del progetto era quello di costruire tre unità amalgamate in un unico fabbricato, concepito con una soluzione di continuità tra le varie unità, rispondendo alle singole esigenze delle committenti. La bellezza della costruzione si è concretizzata nella collaborazione tra committenza, progettista ed impresa fin dalle prime fasi: un esempio di questa sinergia è stato il momento del getto della platea, quando le tre proprietarie hanno consegnato ciascuna un oggetto da posare nelle fondazioni in cemento armato, come gesto “augurale e fondativo”. Il progetto si imposta su un margine in pietra che fa da piattaforma tettonica a due volumi compositivi superiori che si dispongono, al di sopra di questo, accoppiati e paralleli, separati da un elemento distributivo centrale. Non avendo “retri”, la costruzione si caratterizza per la cura delle due “navate” intonacate, ricreando una suggestione che richiama un’architettura navale. Il paramento di margine è stato realizzato a sassi di pietra calcarea, “alberese”, per poter riprendere l’immagine dei muri che cingono ancora il tracciato delle vecchie strade della zona e finire di delimitare con la stessa morfologia il “cuore” centrale verde del campo del Salicone.
Il progetto “Camminare a Firenze” si è sviluppato a partire da un lavoro di ricerca finalizzato allo studio e alla definizione di un sistema di wayfinding per la città di Firenze: con l’obiettivo di favorire l’uso pedonale e ciclabile della città, entro una più ampia strategia di riduzione del traffico veicolare e sviluppo di una mobilità sostenibile; di facilitare allo stesso tempo il riconoscimento di luoghi, spazi e loro sequenze, in modo da potersi orientare e scegliere dove andare avendo la possibilità di “misurare” il tempo più che la distanza. Il percorso progettuale è stato caratterizzato dallo studio degli elementi segnaletici, dall’ideazione del sistema di identità visiva e dalla progettazione esecutiva degli stessi; dal coordinamento degli interventi sullo spazio pubblico in fase operativa e dalla redazione di un manuale d’uso per l’amministrazione. Le steli per l’orientamento e i diversi elementi della “famiglia” contengono informazioni semplici ed essenziali (mappe, pittogrammi, indicazioni turistiche e toponomastiche), oltre a cartografie nelle quali lo spazio urbano viene rappresentato identificando “ambiti di prossimità” e punti di riferimento riconoscibili come monumenti, piazze, giardini, servizi e attrezzature di interesse pubblico, che permettono di individuare i luoghi da raggiungere a piedi e il tempo necessario per percorrere quella determinata distanza (indici di percorrenza: 6/12 min. x 500/1000 m.; cartografie elaborate in scala 1:2.500/1:8.000).
Il Teatro della Pergola è una “cattedrale” fatta di legno, teli, corde, stucchi, suoni e voci che si rincorrono attraverso scale e corridoi: un bellissimo labirinto dove convivono linguaggi e materiali diversi, macchine e ingranaggi che permettono di trasformare gli ambienti in qualcos’altro, montando e smontando velocemente strutture che ne modificano la percezione, senza perdere l’identità e la forma. Il progetto di un nuovo sistema espositivo per allestimenti temporanei realizzato per la Sala Oro – una galleria stretta e lunga come una strada, decorata come un salone per le feste – muove da queste osservazioni e si confronta con i vincoli e le caratteristiche del suo spazio. Come spesso accade, è il luogo che suggerisce ipotesi e soluzioni: il progetto sviluppa la suggestione della strada e la trasforma nell’idea di un “percorso abitato” che ne occupa il vuoto con rispetto; un insieme di elementi che assumono via via le sembianze di una quinta, di una colonna, di un portale, montati su un basamento che attraverso una “griglia di fori” li organizza entro un sistema geometrico variamente componibile, in grado di assumere molte e diverse configurazioni. La struttura, molto semplice e a basso costo, è stata pensata e realizzata per essere composta, smontata e stoccata con relativa facilità. Ogni elemento del sistema è un modulo progettato in modo da poter essere utilizzato modificando all’occorrenza posizione, colore e grafica, adattandosi ai diversi contenuti di una mostra.
Civico 22 è un frutto di un intervento integrale di trasformazione e rigenerazione di un edificio degli anni Settanta (ex Enel) in un complesso residenziale. La planimetria a L con il lato corto attestato su Via del Campofiore ha subito indirizzato la progettazione sulla dualità dei fronti, più urbani quelli rivolti su strada, più porosi quelli rivolti sull’interno, che il progetto risolve con un telaio metallico e un sistema di pannelli “brise soleil”. Attuando una sorta di smontaggio e rimontaggio degli elementi tipologici dello stato di fatto, il progetto ha restituito il volume attraverso la giustapposizione di tre elementi chiaramente riconoscibili: il basamento, il corpo principale e l’attico. La lettura stratificata di queste tre parti di programma è stata rafforzata con la scansione di fasce marcapiano in acciaio, annegate sul cappotto perimetrale. Il basamento ospita le attività direzionali e stabilisce relazioni urbane anche grazie alla flessuosità delle pensiline che si protendono verso la strada. Al di sopra si sviluppano il corpo principale con da una gamma cromatica che varia dal grigio cemento al perla, nell’ottica di esaltare le fasce finestrate e i generosi vuoti delle terrazze. Il piano attico rappresenta l’elemento di chiusura dal quale emergono le volumetrie dei duplex, ideati come “ville urbane” con le terrazze rivolte sul Piazzale Michelangelo. Infine, la realizzazione del giardino condominiale, ha consentito di ricucire gli spazi del piano terreno.
La residenza si trova all’interno del tessuto storico fiorentino, vicino alla Porta al Prato, all’ultimo piano di un edificio a schiera e fa parte di una lunga stecca costruita nel 1576 finanziata dall’ordine di Santo Stefano. La richiesta della committenza è quella di rendere l’immobile adatto alle esigenze di una giovane donna ampliando il più possibile la penetrazione della luce rispettando le caratteristiche storiche e tipologiche. Il progetto si è incentrato sull’uso dell’intero volume in cui è stato eliminato il cannicciato e realizzato, con un nuovo solaio in acciaio, un soppalco; quindi, è stata ampliata la finestra del soggiorno in porta finestra con ringhiera che permette una maggiore aerazione e illuminazione di tutta la zona giorno e affaccio sulla corte interna. Per assicurare aerazione ed illuminazione alla camera sono stati eliminati i palchi morti, sostituiti da un passaggio in ferro e vetro con una rete per catamarani nella parte centrale. Questa soluzione amplia la potenzialità d’uso degli ambienti che diventano fluidi e poliedrici. Sono stati inoltre utilizzati intonaci armati con fibra di vetro per consolidare le pareti portanti, le travi della copertura sono state riconsolidate e integrate con materiale già presente in loco, mentre per il pavimento è stato scelto un parquet in rovere leggermente nodato. Il progetto è stato curato dall’architetto Gaetana Maria Naso, la grafica dalla dott.ssa in Architettura Silvia Angius e la fotografia da Patrizia Gervasi.
Il progetto consiste nella realizzazione di due nuovi volumi ‘accorpati’ all’edificio esistente e la realizzazione di un piano interrato che collega e unisce le due porzioni sovrastanti. I due volumi hanno forma simile ma destinazione diversa. Nel primo edificio è inserita la nuova sala ristorante, che si collega con la cucina esistente (e il bar) tramite un piccolo volume trasparente la cui copertura si estende per l’intero tratto di sovrapposizione tra il vecchio e il nuovo edificio. Nel secondo edificio è stata collocata la segreteria, gli uffici e una sala riunione. Questo volume è collegato ‘fisicamente’ con quello esistente con una copertura trasparente. Successivamente è stato realizzato il porticato che amplia la sala ristorante nei mesi estivi. La ricerca del corretto inserimento ambientale insieme alla funzionalità degli spazi e dei percorsi costituiscono gli aspetti principali del progetto: forme semplici e rigorose con ampie porzioni vetrate, per esaltarne l’apertura e il senso di accoglienza verso l’esterno, L’edificio vuole risultare ‘contemporaneo’ e allo stesso tempo intimamente connesso al luogo: è realmente un ampliamento ma, con forza, cerca la sua ‘indipendenza’ per comunicare solidità e continuità nel tempo. Dal punto di vista costruttivo: il piano interrato è stato realizzato con una struttura in calcestruzzo armato e per i volumi ‘fuori terra’ strutture in legno: pareti in Xlam e soffitti a vista. Manto di copertura in rame naturale.
Dai colori, gli odori e i sapori del territorio nascono le linee, le forme e i luoghi. Il percorso del visitatore si snoda all’interno di questa antica residenza fra la storia e la contemporaneità. I materiali, i tessuti, gli oggetti di recupero e l’artigianato identificano gli ambienti privilegiandone l’unicità. Il progetto di interior è incentrato sull’integrazione tra i valori ed i caratteri del contesto storico, artistico, paesaggistico, umano ed il linguaggio architettonico contemporaneo per creare ambienti accoglienti, che avvolgano ed emozionino. L’ospite vive l’esperienza del viaggio nel cuore dell’antico borgo di Montalcino all’interno di uno spazio, raffinato, confortevole, genuino, permeato da tradizione e contemporaneità. La cura e l’attenzione al contesto si concretizza nella scelta dei materiali, dei colori, delle forme. In tutte le stanze sono restaurati i soffitti originali in legno di castagno e mezzane in cotto, le pareti sono trattate con finitura a calce e dove possibile sono state mantenute le originali pareti in pietra. Gli altri materiali sono il travertino toscano, il rovere miele, il ferro. Il vetro, l’acciaio e l’illuminazione led conferiscono un tono contemporaneo e delicato in armonia con la storicità della struttura. Grande importanza è attribuita all’artigianalità, al materico, al “su misura”, alla tradizione, integrando questi temi con gli elementi più interessanti e qualificanti dell’innovazione.
Il progetto, su un area in collina, è stato affrontato considerando il tema dell’inserimento paesaggistico del fabbricato. Il progetto propone un edificio con un solo piano fuori terra, che si sviluppa su un corpo di fabbrica principale, posto lungo l’asse est/ovest, di forma rettangolare e compatta con una copertura a più falde delle quali le principali sono convergenti con impluvio interno. Un lungo parallelepipedo al quale si contrappongono nel lato nord altri due volumi, volendo con questa scelta emulare un processo diacronico di crescita del fabbricato tipico del processo evolutivo dell’edilizia di base nelle nostre terre. Il progetto del fabbricato si è inoltre basato sui principi della progettazione bioclimatica. L’Architettura si muove sempre di più verso la sostenibilità, verso un’integrazione degli edifici nella natura e nella ricerca di materiali che siano il più possibile eco-compatibili. In particolare ciò che renderà l’architettura sostenibile sarà il superamento della radicata tradizione costruttiva per porre, all’inizio del processo, altri elementi e sistemi considerati fino da oggi solo marginalmente: orientamento, soleggiamento, fattori di ventilazione naturale, ombreggiamento, ma anche l’adozione di sistemi di sfruttamento ed utilizzo dell’energia ricavabile da fonti rinnovabili e sistemi domotici di gestione. Per questo motivo è stato realizzato un edificio nZEB, con struttura prefabbricata in legno ad altissima prestazione energetica.
Una microarchitettura in bioedilizia nelle campagne pistoiesi realizzata in ampliamento ad una rimessa agricola esistente. L’edificio prende spunto dall’architettura rurale dei luoghi e si caratterizzata con linee semplici e richiami all’architettura tradizionale, quali il tetto a falde a coppi e tegole e le mandolate in laterizio. La struttura è costituita da pilastri, travi ed arcarecci in legno lamellare ancorati con sistemi a scomparsa e realizzati con viti autopforanti. Per i prospetti laterali del fabbricato in ampliamento è stato concepito un inserto in laterizio, in richiamo alla mandolata toscana, per offrire la giusta privacy e creare un continuum materico e cromatico con la copertura in laterizio. Il prospetto principale, così come l’edificio esistente, viene inciso da una grande vetrata per favorire l’ingresso della luce naturale e la visuale sull’intera vallata.
L’idea: un involucro contemporaneo che potesse contenere oggetti datati. Un gioiello nel centro di Firenze che doveva essere giovane e dinamico, ma allo stesso tempo anche elegante e rispettoso nei confronti del passato. Il contrasto è più importante dell’armonia. Forme, colori e materiali sono in contrasto e mai in conflitto. “Un interno è come un orchestra sinfonica, ogni oggetto ha un ruolo preciso e molto importante, anche il più piccolo, tutto deve essere in prefetto equilibrio.” Il grigio assume il ruolo del bianco, ma più presente e porta una compattezza e un unità nella stanza di cui approfittano tutti i complementi”, mentre i toni intensi e saturati danno agli elementi anche un significato architettonico. I colori giocano un ruolo decisivo in questo progetto, le tende di velluto rosso rendono gli ambienti scenografici, come in un teatro, per dare ai mobili un palcoscenico, mentre le stoffe e i tappeti sono gli elementi che coniughino l’architettura e gli ambienti. La carta da parati e il murale alle pareti hanno una tematica, la foresta, che ha un rapporto diretto con il background del proprietario, gli alberi sono i presupposti di tutta la produzione di cui sono la personificazione. Anche molti elementi d’arredo nell’appartamento sono parte di questo omaggio alle origini del proprietario.
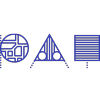
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix