

Ridare vita a una Pieve dell’XI secolo significa conoscerne la storia e le cause del suo abbandono, a volte per interventi storicizzati ma incongrui e nocivi al suo organismo più intimo. Il complesso monumentale è composto da due fabbricati di diverse origini, la chiesa e la canonica, risultato di sovrapposizioni avvenute nel tempo, alcune di valore storico rilevante, altre recenti prive di pregio, nonché da un piccolo cimitero cintato di proprietà comunale. L’intervento è stato preceduto da un’attenta analisi materica e storica a supporto delle scelte progettuali. Poter disporre di un quadro conoscitivo della fabbrica sufficientemente completo, ha consentito di comprendere come, nell’intero arco della sua storia, il cambiamento delle destinazioni d’uso, la modifica dei percorsi di collegamento e delle aperture, l’aggiunta, la rimozione o la sostituzione di intere porzioni dell’edificio è stato senz’altro il mezzo più efficace e utile a garantirne la conservazione. Gli interventi di restauro in progetto si inseriscono con unità teorica e metodologica nel testo storico, con un linguaggio contemporaneo coerente, conforme e consonante con le testimonianze documentali. La storia, unita all’ascolto del monumento e dello stato dei luoghi, è stata in definitiva la traccia principale, il più importante referente progettuale che ha guidato e indirizzato ogni scelta dell’intervento, caratterizzato da una serie di modifiche migliorative nella complessiva conservazione del bene storico.
Nel Museo dell’Opera del Duomo di Pisa la successione delle opere è espressione della devozione e della magnificenza di Pisa a partire dal Dodicesimo Secolo. Nella potente e ricca repubblica marinara si sono incontrate culture artistiche diverse, da quelle d’oltre Alpi a quelle islamiche, e nel sec. XIII, con l’arrivo di Nicola Pisano, inizia una stagione di sperimentazione nell’ambito della scultura che ha in sé tutti i semi che germoglieranno con il Rinascimento. Il nuovo progetto museografico si pone come obbiettivo la realizzazione di un percorso fluido, in cui le opere della grande scultura pisana sono valorizzate dagli allestimenti e nello stesso tempo dialogano con il contesto storico. Le opere sono contestualizzate mediante allestimenti che evocano il luogo, la collocazione e le atmosfere originarie. Si tratta di una operazione complessa, mai imitativa della realtà, ma volta a cogliere l’essenza e i significati reconditi per veicolarli. Le finiture, i colori e i materiali rimandano a quelli storici usati nei monumenti della piazza, reinterpretati in chiave contemporanea. I basamenti e le pedane sono in pietra arenaria lavorata in modo da creare una leggerissima vibrazione della superficie. I fondali delle opere sono realizzati in resina o in encausto, per evocare i colori della piazza o i finti marmi dell’interno duomo. Il percorso espositivo si sviluppa su 3000 mq interni, e su una porzione del porticato esterno. Le 380 opere esposte sono suddivise in 26 sezioni.
Il progetto riguarda un antico casale del 1887, nelle vicinanze del Comune di Lucca ed un più recente annesso rustico destinato a tirasotto, il tutto immerso in un paesaggio collinare ed ambienti boschivi. L’intervento di restauro valorizza gli elementi strutturali tipici dell’architettura locale, l’utilizzo del mattone faccia a vista, della pietra di Matraia e del legno di castagno, rivisitando i materiali in chiave contemporanea. All’interno si è provveduto ad applicare manualmente intonaci a base di calce naturale evidenziando la struttura irregolare delle pareti dovuta dall’utilizzo di materiali come il sasso e la pietra. Il recupero delle travi e delle tavelle tramite sabbiatura è un richiamo alla tradizionale architettura interna toscana attualizzata mediante la sbiancatura dei soffitti. L’esterno dell’immobile è stato conservato inalterato mantenendone la storicità senza intaccarne il fascino optando per degli infissi esterni in acciaio dal profilo contenuto. Nel giardino l’ampia piscina s’inserisce nel paesaggio circostante, dove il disegno delle pavimentazioni rispetta la vegetazione secolare lasciandone inalterata la posizione. Il volume del tirasotto è stato totalmente ristrutturato internamente, optando per materiali e colori contemporanei, dove il pavimento in calcestruzzo ed il blocco nero a sevizi contribuiscono a dare nuova identità.
In stretta sinergia con il Consiglio Amministrativo del Tennis Club di Prato, l’obbiettivo primario del restauro è stato quello di restituire agli ambienti interni dell’antica villa del ‘700, immersa nella natura della collina pratese, l’eleganza e il verve che questo tipo di luoghi hanno a livello internazionale, creando un spazio dove i soci possano ritrovarsi non solo per praticare sport ma per condividere momenti di relax e convivialità, lasciando inalterata l’architettura storica. L’intervento ha riguardato il piano terra della villa e si è articolo in quattro ambienti principali: la sala bar, caratterizzata da grandi archi che mettono in comunicazione gli ambienti esterni con l’interno, l’ampia zona d’ingresso che oltre a collegare i due grandi cortili esterni a destra e sinistra della villa funge da filtro e sala d’attesa, la sala lettura, la sala ristorante divisa in due zone e la saletta conversazione, con un salotto conviviale sovrastato al centro della parete da una grande composizione di racchette appartenute ad alcuni soci storici del club. Il restauro ha riguardato a livello architettonico l’eliminazione di alcune superfetazioni estranea all’edificio storico, il rifacimento degli impianti di climatizzazione, la sostituzione degli infissi con elementi dalle caratteristiche più performanti, lo studio dell’illuminazione ed il rifacimento della pavimentazioni oltre allo studio dettagliato di tutti gli elementi d’arredo realizzati su misura.
Il complesso “La Querce”, originariamente costituito da un casale e due annessi, rispecchia perfettamente per morfologia e forme l’architettura contadina Toscana. L’intervento sull’intero complesso è iniziato con il restauro del Casale, la ristrutturazione edilizia dell’annesso principale e la demolizione dell’annesso secondario. Sull’impronta originale di quest’ultimo è stata realizzata una piscina a sfioro di 5x 13,5 metri. Il Casale di circa 540 mq si distribuisce su due piani. Il piano terra, adibito a zona giorno, è caratterizzato da ampie porte finestre ad arco che si aprono sul paesaggio circostante. Forte è la presenza di una tradizione architettonica. Volte a crociera e a botte originali in cotto, si alternano negli ambienti al piano terra. Una cucina “sartoriale” che racconta uno stile raffinato con materiali pregiati e forme senza tempo. Salendo la scala in pietra si raggiunge il piano primo, in cui sono ben distribuite cinque camere da letto matrimoniali ciascuna con il bagno privato. L’annesso di circa 100 mq è un grande “openspace” destinato a zona hobby. Una particolare importanza è stata conferita al “landscape“. Una progettazione dello spazio esterno mirata al superamento dei differenti livelli di quota appositamente creati per dare ad ogni elemento la singola importanza. Scalette in cotto e percorsi ben delineati collegano i fabbricati alla magnifica piscina che si affaccia sul sottostante campo da golf e al campo di bocce circondato da olivi secolari.
L’intervento in oggetto prevede l’armonizzazione e quindi una sensibile rigenerazione di un complesso edilizio attraverso il recupero del corpo principale, ovvero una “capanna” storica e di un attiguo “corpo secondario” realizzato successivamente e privo di qualità architettonica. Il volume principale, già indicato nelle antiche carte del Catasto Leopoldino, è stato oggetto di un intervento attento, oculato, sensibile, volto a mantenere inalterata la lettura architettonica e razionale dello stesso nonostante la suo nuova destinazione abitativa. All’interno, le opere strutturali in carpenteria metallica con funzione di sostegno del nuovo tetto ventilato e del parziale solaio di mezzeria, sono state pensate e realizzate per essere ben visibili e quindi senza nascondere o alterare la natura strutturale principale del volume storico composto da una muratura perimetrale portante. Il corpo secondario, alla luce dell’assenza di elementi architettonici da tutelare, è stato oggetto di una totale rigenerazione anche attraverso la realizzazione di una pelle esterna in legno larice non trattato e quindi pronta a mutare nel tempo raggiungendo dolcemente dei cromatismi in perfetta simbiosi con l’adiacente massa muraria. L’immagine finale si compone quindi di un architettura lineare, il corpo secondario avrà il compito di relazionarsi con la forza espressiva della capanna in pietra, contribuendo a dare impeto e valore ad un insieme compositivo basato su un equilibrio cromatico e strutturale
Il complesso monumentale dei Bottini dell’Olio–Luogo Pio, realizzato all’inizio del XVIII secolo, costituisce un intero isolato urbano nel cuore dello storico quartiere della Venezia Nuova. L’intervento di restauro degli edifici esistenti ha compreso anche il completamento delle parti distrutte dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale realizzando, purtroppo ancora non in maniera completa, nuovi volumi sul sedime di quelli storici tesi a ricucire il tessuto urbano sfrangiato dalle bombe. In essi mediante l’utilizzo di materiali quali il vetro, il metallo ed il laterizio scialbato a vista, si sono introdotti linguaggi architettonici distinguibili ma che trovano riferimenti nel contesto del quartiere. L’intervento ha realizzato anche nuovi collegamenti funzionali interni, scale, ascensori, rampe e passaggi coperti, che hanno reso il complesso funzionale al nuovo ruolo e completamente accessibile. Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, utilizzando l’acqua del vicino canale, realizzano un alto risparmio energetico, le reti distributive sono celate ed integrate negli elementi architettonici e negli allestimenti. Negli spazi così restaurati e ricostruiti, si sono ricavati nuovi locali espositivi e nuove dotazioni di servizi per l’esistente Biblioteca Labronica. All’interno dei Bottini dell’Olio, negli ampi saloni voltati, è stato allestito il nuovo Museo della Città, mentre gli ambienti e la Chiesa del Luogo Pio ospitano la collezione comunale di arte contemporanea.
L’edificio, che risale alla prima metà del Novecento, ospitava una distilleria e poi un’officina meccanica. La posizione su un importante asse di comunicazione ha suggerito un’ipotesi di recupero dell’immobile per destinarlo a spazio espositivo per le arti visive. All’esterno, un grande portale in ferro grezzo segnala, sulla piccola corte privata, l’ingresso allo spazio espositivo. Lo spessore di pochi centimetri dell’infisso esistente è sostituito da uno di quasi due metri. Il portale raccorda i due spazi, assumendo il ruolo di tramite fisico tra interno ed esterno, dilatando la soglia. L’ampia copertura a volta e il pavimento, seppure molto usurato, sono stati conservati in una filosofia progettuale che intende riflettere sul possibile rapporto tra preesistente e nuovo. Il nuovo si sovrappone al preesistente seguendo il principio della stratificazione: sulle pareti perimetrali si appoggia un rivestimento leggero, ad altezza variabile. Sull’asse longitudinale dell’aula, una sequenza di cinque celle cubiche di lato tre metri, aperte su un lato e prive di copertura. Vuoti che riempiono il vuoto. Un basamento della stessa dimensione in pianta, ma alto solo un terzo del lato di base, apre la sequenza. I volumi sono staccati tra loro: pause che consentono di traguardare, lasciando scoprire l’effettiva larghezza della sala. Un percorso anulare consente l’accesso alle stanze espositive, che si lasciano scoprire nell’alternanza di pieni e vuoti che caratterizza la composizione.
Dall’unione di due unità è stato ricavato un unico spazio abitativo su tre piani, adatto a soddisfare le esigenze di una famiglia. I lavori sono stati orientati a valorizzare i tratti più caratteristici dell’esistente, come la scala originale dei primi del novecento che unisce i tre livelli, recuperata e reinventata. Un elemento del passato che rivive nella nuova abitazione. La scala, in resina di colore grigio, è invece il segno della nuova distribuzione dello spazio. Il progetto interviene con un’idea volumetrica a doppio volume solo nella zona del soggiorno, da cui parte il collegamento fra il piano primo e secondo: la scala esistente, le linee minimalistiche con la resina a pavimento, il colore bianco delle pareti e la luce che arriva dalla copertura creano un aspetto semplice e raffinato ma insolito per la tipologia di casa. Che interessi una o più stanze della casa, le pareti, gli arredi o il pavimento, il bianco è il colore che meglio sa far splendere gli interni riflettendo la luce proveniente dall’esterno. Sicura nella sua eleganza monocromatica è questo loft nei dintorni di Firenze, progettato da Alessandro Bruni a reinterpretare la perfezione e l’armonia dello spazio domestico contemporaneo. All’interno domina il senso di leggerezza, reso interessante dalla modernità dell’openspace. Per la sua capacità di dilatare lo spazio, il bianco è stato scelto come colore guida, declinato in più sfumature, che vanno dalle pareti a ogni singolo arredo.
Il nuovo lucernario dell’ex “Cinema Moderno” è forse la metafora più esaustiva di una più complessa ristrutturazione dell’intero immobile. Il particolarissimo edificio a punta, un “Flatiron Building” di origine medievale nel cuore di Siena, di fronte allo storico Palazzo Tolomei, irrompe nella piazza omonima creando una “Y”, simbolo della storica suddivisione in terzi di città. Diventa così l’impronta su cui insiste la nuova lanterna sul tetto, landmark urbano, virus contemporaneo generatore della nuova struttura interna che si innesta come nuovo ordine compositivo e distributivo. I muri esterni, interamente in mattoni faccia vista e pietra nel basamento del piano terra, hanno fatto da scenario alla spettacolare asportazione di tutte le superfetazioni, fino al completo svuotamento dell’intero volume. Oggi, dopo un dettagliato rilievo laser scan e un accurato restauro, continuano a fare da cortina alla nuova struttura metallica. L’attuale destinazione dell’edificio è mista. Il residenziale è caratterizzato da un numero limitato di appartamenti per privilegiarne la qualità, mentre la parte commerciale, trova la sua entrata in corrispondenza della prua dell’edificio, al piano terra, attraverso lo spazio compreso tra le prime due arcate, lasciate aperte per la fruizione pubblica. Un dono alla città che riporta alla memoria l’antica στοά, luogo per l’incontro, lo scambio e la crescita culturale.
La Sortita del Baluardo San Paolino è uno dei luoghi più interessanti degli spazi interni delle Mura urbane di Lucca. La riapertura al passaggio pubblico è un’importante operazione di valorizzazione che permette la connessione diretta della città al parcheggio di viale Carducci. La richiesta della committenza era di restituire la sortita alla fruizione pubblica in sicurezza permettendone una corretta percezione. È stato studiato così un nuovo sistema illuminotecnico che elimina i precedenti apparecchi a parete. Gli apparecchi a incasso a pavimento sono inseriti in fasce o corone di acciaio corten che staccandosi dalle pareti con una fascia di granulato di marmo bianco di Carrara, costituiscono una protezione all’impianto e una guida visiva del percorso. Il corten rende chiaramente individuabile l’intervento contemporaneo nel contesto dello spazio storico. I totem contengono il sistema di emergenza, le prese elettriche e le linee dati per gli allestimenti temporanei. Una contro parete di acciaio corten con foratura a laser che riproduce il disegno del paramento a broccato del baldacchino del Duomo di Lucca, consente di schermare il consolidamento murario pre-esistente della parete. Il sistema di raccolta acque piovane di percolamento dalle murature è realizzato da canalette lineari con griglie in ghisa sferoidale collocate sulle soglie di passaggio tra i vari ambienti e lungo il perimetro continuo della sala centrale, l’acqua di raccolta è convogliata nel pozzo esistente.
Il bando di gara del Comune di Livorno del 2013 prevedeva il restauro e l’ampliamento di uno piccolo chalet in stile neoclassico dei primi del Novecento e la riqualificazione del Parco della Rotonda di Ardenza, tappa finale dell’ottocentesca passeggiata a mare della città di Livorno, tra le prime realizzate in Italia. Contrariamente a quanto permesso dal bando si è scelto di limitare l’edificato all’area retrostante allo chalet originario, lasciare libera l’area centrale di intersezione dei viali, mantenendo la totale permeabilità visiva sugli assi principali e generando uno spazio urbano che potesse assumere la funzione di “piazza”, luogo pubblico e polifunzionale per eccellenza. Lo chalet storico, completamente restaurato, è diventato così il fulcro dell’intervento progettuale. Il nuovo ampliamento, invece, è stato studiato per integrarsi nel contesto naturale esistente ed allo stesso tempo dialogare con all’edificio storico. Caratterizzato da una grande permeabilità visiva, è stato impostato rivisitando in chiave contemporanea i fili architettonici, le simmetrie e le proporzioni dell’edificio originario diventandone, allo stesso tempo, cornice e sfondo capaci di tutelarlo e valorizzarlo. All’interno di un organismo edilizio con elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, trovano spazio ambienti eterogenei e polifunzionali in cui si svolge attività di ristorazione con possibilità di ospitare eventi culturali.
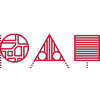
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix