

Il progetto, situato in una delle zone più felici per la produzione del vino in Italia, Bolgheri, mira alla costruzione di una nuova cantina e la riqualificazione di un capannone esistente per farne il nuovo centro aziendale per la Tenuta di Guado al Tasso di proprietà della famiglia Antinori. Il sito, a solo un chilometro dal mare, ha un orografia pianeggiante e il progetto, viste le grandi dimensioni e l’esigenza di costruire fuori terra, si è dovuto da subito confrontare con il paesaggio e l’integrazione con esso. La progettazione di dune ricche di vegetazione mediterranea, elemento tipico del territorio, mitigano l’impatto visivo dell’intervento. Il volume della cantina, riprendendo le tematiche industriali di serialità, è pensato come un oggetto modulare a shed lungo l’asse longitudinale con un passo di 5 m a campata che trova in facciata una forte articolazione attraverso un rivestimento sfaccettato, una “corazza” in lamiera forata, che funge da filtro termico e d’illuminazione. Questa pelle, realizzata in zinco al titanio di colore scuro, cerca un dialogo continuo con il paesaggio.
Il progetto di Nio mira a favorire la permeabilità fra il centro e il suo territorio. L’edificio esistente viene integralmente conservato e lasciato intatto in tutti i suoi aspetti. A esso si accosta, in forma di anello, un nuovo volume che, riprendendo il disegno dell’originario parco circostante, si orienta verso la dimensione pubblica. Grazie alla nuova entrata, al bookshop e al ristorante situati all’interno di un corpo trasparente al piano terra, il Centro si rivolge all’esterno, sollecita curiosità, invita all’interazione, si apre alla città, mediato da un giardino sperimentale e da una ampia piazza. Il punto più alto del complesso espositivo è raggiunto da un elemento simile a un’antenna capace, da un lato, di rappresentare la volontà di captare le nuove forme di creatività vive nel territorio, dall’altro di denunciare la presenza importante di un luogo deputato alla loro promozione, di immediata visibilità sia per chi proviene dall’autostrada sia per chi arriva a piedi dalla città. Fin dalla prima formulazione del progetto, Maurice Nio ha scelto per il nuovo edificio un titolo dal forte sapore evocativo: Sensing the Waves, suggerendo la sua funzione di recettore (e magari anche di trasmettitore) capace di captare e divulgare le vibrazioni del tempo presente.
Il progetto consiste in una casa semi-indipendente a basso consumo, collocata in un terreno in pendenza triangolare di dimensioni molto ridotte. Il lotto si trova in una zona collinare di valore paesaggistico, dall’urbanizzazione rada, situata a Le Sieci vicino a Firenze. L’area era costituita da una parte edificabile, libera dalla vegetazione, e da una parte con una foresta di conifere e latifoglie. Il programma funzionale prevedeva due appartamenti indipendenti, ciascuno dotato di un ingresso individuale, una vista panoramica sulla valle a nord-ovest, un ingresso carrabile da valle al garage interrato, un accesso al giardino a sud, dove il lotto si allarga verso la proprietà forestale. I forti vincoli del sito e le richieste della committenza hanno determinato l’organizzazione volumetrica e funzionale, definita da parallelepipedi impilati e sfalsati, che paiono sospesi su una cortina vetrata. La disposizione interna e le aperture sono state influenzate dalle prestazioni ambientali con un maggiore impatto sul benessere psicologico; la protezione solare estiva ha richiesto uno studio speciale al fine di ridurre al minimo la necessità di schermi mobili: le schermature permanenti (aggetti e pensiline) permettono il passaggio della radiazione invernale per il guadagno solare passivo e contemporaneamente forniscono una protezione efficace dal sole estivo senza impedire la vista del paesaggio. L’edificio raggiunge la classe energetica A con un consumo di circa 30 kWh/mq anno.
Posta in un parco di 3.500 mq sulla collina di Marignolle a Firenze la villa di 200 mq venne costruita nei primi anni ’70 del secolo scorso ed è rimasta sostanzialmente immutata fino alla attuale ristrutturazione che ha interessato, oltre agli interni, anche il disegno dei prospetti e delle aree che circondano l’edificio dove è stata inserita una nuova piscina “a sfioro” di 28 mq che si affaccia verso la valle sottostante. Dalla zona giorno due grandi vetrate si aprono sull’ampio deck in legno che separa l’edificio dalla piscina e che circonda completamente la villa. L’intervento ha migliorato sensibilmente la prestazione energetica dell’edificio che è oggi completamente protetto da un “cappotto” termico esternamente rivestito con lastre di travertino. Lo skyline dell’edificio –circondato da cipressi, ulivi e pini marittimi– è stato completamente modificato dall’inserimento di nuovi ampi aggetti della copertura che proteggono i percorsi esterni in legno di larice.
In principio c’è il disegno. L’intuizione si consolida attraverso i veloci tracciati sovrapposti ai rigorosi segni del rilievo architettonico. I solchi incerti dell’idea si sommano ai lacerti di un passato recente, ultima stratificazione insignificante se confrontata all’anima dell’edificio. L’appartamento, posto al secondo piano di un impianto medievale nel quartiere di San Martino a Pisa, originariamente si presentava scarsamente funzionale: un corridoio d’ingresso adiacente ad un piccolo disimpegno serviva due bagni ciechi e due camere. L’intervento valorizza le componenti strutturali dell’architettura. L’angusto impianto distributivo viene sostituito da un diverso sistema funzionale di forte caratterizzazione estetica. Questo congegno scatolare fatto di legno e vetro intercetta le strutture degli impalcati con degli schermi trasparenti, rivelandone in tal modo la loro continuità. L’impianto planimetrico che ne risulta ritaglia nuove traiettorie geometriche ottenendo una riorganizzazione spaziale e funzionale. Gli effetti vibranti prodotti dai colori, dalla luminosità dei materiali e dalle molteplici riflessioni delle vetrate conferiscono a questo spazio una particolare suggestione entro cui la contemporaneità si confronta con la storia. Nel soggiorno un armadio attrezzato richiama nelle componenti cromatiche, nella forma e nelle linee geometriche il nuovo sistema distributivo enfatizzando l’organicità dell’intervento.
L’openspace per definizione è un ambiente unico e vasto mentre l’alloggio da rigenerare era un piccolo piano terra nato da aggiunte nel corso del tempo. La richiesta era di ristrutturare l’appartamento ereditato e realizzare nuovi impianti e infissi di migliore prestazione energetica nonché renderlo convertibile in uno spazio-feste. Il primo concept si basava sulla demolizione di due muri portanti e due divisori per creare un spazio centrale regolarizzato da arredi integrati perimetrali. Ma realizzate le demolizioni il cantiere ha mostrato qualità non prevedibili su carta: si sono allora abbandonati i rivestimenti in legno per far leva sull’articolazione del nuovo spazio unico e fluido ma poiché irregolare gerarchizzato in ambienti diversi. Al contrario dell’approccio iniziale il progetto non ha cercato di realizzare un openspace come forzatura di inserire il quadrato nel foro circolare ma ha fatto leva sulle porzioni di foro circolare scoperte. Ambiguità percettiva e diverse possibilità di fruizione come trasposizione spaziale della nozione funzionale di flessibilità. Pur trattandosi di un piccolo interno il progetto si è interrogato sul significato di rigenerazione di una preesistenza: non un’esclusione di fattori per la genesi di un’immagine comunicativa ma un rinnovamento che nasce dall’integrazione critica delle pluralità del contesto. Il prodotto generato trascende mode e valori formalistici per continuare le tracce del passato all’interno della metamorfosi contemporane
L’opera è un edificio in linea, composto da 4 piani fuori terra, piano terreno ad uso direzionale p1/2/3 uso residenziale, 15 unità immobiliari. L’edificio è stato realizzato in sostituzione di un edificio preesistente ad uso commerciale, non più idoneo funzionalmente e strutturalmente al nuovo uso, con lo stesso ingombro planivolumetrico. L’edificio si caratterizza per un volume compatto e massivo ma, allo stesso tempo, dinamico. L’opera è rivestita con un “materiale povero”, il cappotto termico,utilizzato come materiale massivo, in maniera scultorea, creando campiture e volumi compatti. L’edificio è a due facce, progettate in base alla loro collocazione e funzione. Quella lungo la strada è compatta e chiusa, direzionale, per fare cortina con gli edifici adiacenti e come barriera contro i rumori. Il fronte interno è più aperto e articolato,residenziale, vivibile anche all’esterno attraverso grandi logge silenziose. La tecnologia costruttiva è: struttura antisismica travi e pilastri in C.A, tamponamento in Poroton, cappotto termico in polistirene con spessori da 10 a 20 cm e uso di strutture steel frame per le facciate, materiali a secco per i divisori interni e le contropareti in cartongesso a 2 lastre; insieme con l’eliminazione dei ponti termici, infissi in alluminio ad alte prestazioni ed un impianto di climatizzazione centralizzato per ottenere la classe energetica “A”. Finiture:pavimentazione interna in gres nero, esterna in cls a vista e ghiaia.
La Costa dei Barbari per la Versilia è un locale storico che sorse nel porto di Viareggio. Negli anni 70/80 il locale fu trasferito, l’anarchia e la semplicità del primo fabbricato furono abbandonate e fu realizzato un fabbricato di legno con copertura a capanna.Il contrasto con le costruzioni spontanee e illegittime del viale Europa era evidente. Da una parte lamiere, cannicci e tele disegnavano il fronte delle attività del lungo mare, dall’altra la nuova costruzione.La ricostruzione ha comportato una serie di riflessioni.La banalizzazione delle soluzioni adottate hanno portato un impoverimento dei segni del passato per una proposizione di un lessico scontato. Dall’osservazione dei padiglioni realizzati sulla passeggiata a mare e degli stabilimenti marini dell’800 sono emerse una lunga serie di suggestioni spaziali autetiche. Non la riproposizione di un’abaco di elementi tipologici codificati quali finestre ad oblò, passamanerie in acciaio inox od ottone, icone abusate per rappresentare costruzioni marine.La terrazza di uno stabilimento balneare di fine ottocento sospesa tra terra e mare è ispiratrice del progetto. La visione dello spazio illimitato,l’aria che penetra tra le strutture e fa muovere le tende che sbattendo trasmettendo una sensazione di quiete, la luce che invade lo spazio. Il cubo sopra le tende è rosso come i fuochi accesi sulla spiaggia intorno ai quali ci si raduna e ancora ogni altra cosa che la fantasia e l’ispirazione dell’osservatore può suggerire
La scuola per l’infanzia “La Balena”, a Sinalunga, deve il suo nome ad uno scheletro fossile di un cetaceo di oltre otto metri, risalente al Pliocene, emerso durante gli scavi di sbancamento. Una sorpresa nel paesaggio toscano. Così Marco Mulazzani definisce la scuola nel numero 861 di “Casabella”. Dopo aver vinto la gara di aggiudicazione, la progettazione ha perseguito le richieste del programma funzionale, inserendo sei sezioni (circa centocinquanta bambini) con relativi servizi, mensa e cortile protetto per le attività all’aperto, disposte su un unico livello. Tutte le aule si affacciano sul cortile con un albero caducifoglie che scandisce le stagioni durante l’anno. La scuola si inserisce tra due strade con un edificio parzialmente incastrato nel terreno con un importante dislivello. Le quote si fermano al livello della strada superiore così da non intralciare lo sguardo verso la Val di Chiana e una piazza, sopra i locali mensa, ricuce il tessuto urbano preesistente con una nuova connessione. Tutto l’edificio è in cemento a vista con superfici vetrate continue per i prospetti sul cortile e quelli a sud-est e a sud-ovest. Un’eccezione è la sala polifunzionale a sbalzo sopra la scuola che ha una struttura in metallo ed è tamponata con un rivestimento in profilati U–Glass. Nell’uso pubblico serale si trasforma in una lanterna. Nel 2014 Cino Zucchi inserisce “La Balena” nel Padiglione Italia per rappresentare il paesaggio contemporaneo italiano alla 14° Biennale di Architettura a Venezia.
Villa VP è una residenza privata immersa nella campagna a solo 6 km da Siena. A parte la Villa principale, gli altri fabbricati erano ad uso agricolo, disposti attorno ad un’area pavimentata e realizzati da materiali molto diversi tra loro. L’uso del grigliato a salto di gatto era particolarmente diffuso per garantire ventilazione naturale ed ombreggiamento all’interno. Il progetto, grazie ad una committenza illuminata, ha introdotto un VIRUS Contemporaneo all’interno della casa. Un vero e proprio Serpente di corten e vetro che entra ed esce dai volumi, generando nuove connessioni spaziali orizzontali e verticali, attraversa la libreria e scende fino alla sala da pranzo. Questo elemento ha permesso di liberare il corpo principale da precedenti e obsolete superfetazioni e caratterizza l’intervento con un linguaggio poetico e contemporaneo che si mescola con i colori del luogo ormai consolidati. Con particolare cura sono stati scelti le cromie degli intonaci, del cotto, del legno usati per il recupero dell’intero complesso. Fondamentale è stato l’impiego di una ditta locale che potesse trasmettere la propria conoscenza di manifattura artigianale nell’uso dei materiali e nella loro messa in opera. Fortunatamente il recupero non si è limitato alle parti edificate, ma si è esteso anche al parco circostante. Ciò ha permesso il ripristino di specie autoctone e la salvaguardia della vegetazione esistente, con l’integrazione di un orto per una piccola coltivazione ad uso personale.
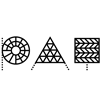
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix