

Come nasce una comunità? Molto ambizioso provare a rispondere brevemente, più probabile riuscire a raccontare come intorno ad un’architettura si sia stretto un insieme di persone, di famiglie, che a poco a poco si sono riconosciute in una identità condivisa. Lentamente ed attraverso un progetto comune, gli architetti e le diverse anime di un cliente multiforme e multiculturale hanno dato vita a ciò che dal principio era un rendering di prova, una maquette, poi fango, battaglie ferro lacrime traguardi poi, in fine, casa. Infatti, se nella maggior parte dei casi, l’asse architetti – general contractor si riassume nella costruzione e vendita delle unità abitative, con gli obiettivi fondamentali della massima qualità e profitto, in questa avventura l’abitante è già lì, pronto a vegliare sulle proprie mura che vengono su giorno dopo giorno. L’idea nasce grazie ad una scheda urbanistica del comune di Firenze che individuava un’area industriale immersa nelle colline della zona sud della città, dove la struttura paesaggistica di alto pregio si salda lentamente al Chianti attraverso l’inseguirsi di colline dolci, punteggiate da nuclei storici ed edifici manifatturieri, in una sfumatura leggera che fonde campagna e città. Una fabbrica dismessa di tessuti di seta veniva destinata a funzioni residenziali, con una parziale demolizione degli edifici esistenti ed il restauro di una parte di alto valore architettonico, oltre che l’utilizzo della superficie demolita per nuova edificazione.
I restauri hanno interessato la Compagnia del SS. Sacramento, risalente al XVIII sec. e la torre campanaria, risalente al XVI sec. che rappresenta il manufatto più antico, tuttora conservato nelle caratteristiche originarie. Il restauro della torre ha visto la preliminare messa in sicurezza del paramento lapideo, con successiva pulitura mediante operazioni graduali di minimo impatto, facilmente controllabili e in grado di garantire il mantenimento delle patine naturali. In fase di rimozione degli intonaci degradati nella cella campanaria è emerso un fatto anomalo, o quantomeno singolare: le 4 catene in ferro erano state “tagliate” negli anni ’60, in occasione della rimozione del castello in legno delle campane (scelta molto opinabile in assenza di idonee opere di ripristino o quantomeno compensative). E’ stato pertanto eseguito un intervento di ripristino, considerando il contributo essenziale che le catene svolgono per la tenuta strutturale. Per il restauro della facciata sud della Compagnia, visti i forti degradi presenti, è stata operata la rimozione completa dell’intonaco ammalorato, previa esecuzione di saggi stratigrafici che hanno permesso di risalire ai cromatismi che si sono succeduti nel tempo. Qui l’intervento ha visto la realizzazione di un intonaco “all’antica” a base di calce idraulica naturale, con il ripristino, in considerazione del valore testimoniale, della decorazione geometrica a riquadri secondo il disegno originale risalente agli anni trenta.
L’Immobile si trova nelle campagne senesi, è un edificio industriale con struttura prefabbricata, realizzato alla fine degli anni 60, in disuso dal febbraio 2020 ovvero da quando la sede di Tenute Piccini Spa (azienda vitivinicola italiana) si è trasferita, per esigenze produttive, nel più funzionale opificio nella zona industriale di Casole d’Elsa. Questo immobile sarà utilizzato nel futuro da Tenute Piccini Spa per valorizzare l’immagine dell’azienda, immerso com’è nei vigneti del Chianti senese che rappresentano anche le proprie origini. L’idea progettuale ha mantenuto inalterata la struttura dell’immobile esistente per arrivare alla realizzazione di un manufatto dall’estetica completamente diversa e rispondente alle nuove esigenze commerciali dell’azienda. Il nuovo manufatto sarà costituito da due volumi, uno pieno e materico ad andamento verticale ed uno vuoto e arioso ad andamento orizzontale. Il primo volume richiama un torrino medievale chiuso, ispirato anche dai diversi esempi di fortificazione circostanti, ha un volume deciso, scandito verticalmente dal nuovo rivestimento metallico in quadrotti di 10×10 cm a tutt’altezza, posti alla distanza di 10 cm della facciata, lasciata peraltro inalterata nella forma originaria, che ha creato un gioco di ombre e luci, pieni e vuoti molto serrati caratterizzanti il progetto. Il secondo volume si appoggia al torrino, è leggero ed aereo, e si contrappone alla matericità del primo grazie alle ampie aperture vetrate sulla facciata
La ristrutturazione di un edificio all’interno del Camping Oasi a Orbetello, adibito a ristorante, bar e market, realizzato negli anni ’70 in struttura prefabbricata in cemento, ha dato l’occasione di una sua rilettura, lasciandosi guidare dalle suggestioni dell’ambiente circostante. L’intervento partendo dalla necessità di un adeguamento igienico-funzionale nella rivisitazione della distribuzione interna, si è proiettato all’esterno nella volontà di interrompere la monotonia dell’originaria costruzione differenziando le varie destinazioni d’uso e caratterizzando in maniera netta la sala ristorante e il bar. Su questi si è operata una forte connotazione volumetrica esasperando i rapporti fra i pieni della muratura e i vuoti delle grandi vetrate, che hanno permesso di creare una continuità fra interno ed esterno. Antistante la sala è stato costruito un pergolato in acciaio tinteggiato, con copertura in rete elettrosaldata dove si intrecciano rampicanti di passiflora, per il pranzo all’aperto. Nella parte relativa ai servizi – market cucina magazzini – si è invece mantenuta la configurazione strutturale originaria inscatolando l’aggetto delle travi di copertura con lamiera grecata e rivestendo in legno al naturale le pareti del fronte, dove due tettoie in acciaio vanno a costituire una sorta di portale d’ingresso alle attività principali.
Era officina: ora è casa. È stato agire su un volume compatto per sottrarre pieno. È stato, anche, costruire lì, ove era rumore di motore, un vuoto vegetalizzato, un ambiente aperto ma dalla spazialità interna, definito com’è da certe travi che sono ancora lassù, frammenti di memoria, tracce della copertura dell’officina che fu. È stato generare percorsi luminosi e avvolgenti attorno al nuovo ventre verde, innestando inedite dinamiche e costruendo spazi dilatati in profondità e altezza. Nel quartiere in odore di mare in Livorno, già l’affaccio sulla pubblica via urlava da subito diversa riconoscibilità. Ora un bianco diaframma anticipa e filtra verso lo spazio privato. Si eleva superando la invariata quota di gronda, aprendosi poi in due nitide e caratterizzanti aperture, cornici di cielo e della loggia cavata in copertura. Gli allineamenti sono calibrati sulle misure dei fabbricati limitrofi. Un accesso arretrato e svettante nel suo fuori scala, introduce alla spazialità interna, immediatamente vertiginosa in altezza e in profondità, aumentata dalle trasparenze nel ventre verde. Dinanzi è lo sbalzo audace di nitidi gradini. La finitura in resina bianca sottolinea la pulizia formale. Sopra, spazi introspettivi si affacciano sul living. Sotto, vetrate e volumi puri. Un leggero differenziarsi cromatico e del trattamento superficiale, muta la percezione visiva e sensoriale. Il tempo pandemico ha indotto ad ambienti dilatati nel verde. Qui, ora, è un abitare informale e felice.
La proposta progettuale per la nuova sala espositiva di TTT individua tre elementi fondanti: la piazza, il portico, il vecchio focolaio. La piazza è definita dalla luce zenitale introdotta attraverso due lucernari a forma di piramidi tronche. I diffusori per l’aerazione e le linee dei proiettori luminosi, sono alloggiati nelle intercapedini tra controsoffitto e pareti, affidando al controsoffitto la funzione di macchina impiantistica. Al centro della sala è posizionato un setto contenitivo ancora in produzione al tempo degli scatti fotografici. Le collezioni, in precedenza appese alle pareti, sono state posizionate dietro una controparete. Qui, tramite tablet, è azionato un rullo meccanizzato che identifica il pezzo richiesto presentandolo in prossimità del varco. Il portico, delimitato da telai pivottanti, presenta proporzioni diverse dalla sala. Nella galleria l’illuminazione è puntuale, diretta ai canovacci incorniciati e posizionati a muro su binario scorrevole in ferro nero calamita. Pareti e arredi sono rivestiti con intonaco di calcecanapa con proprietà termo-isolanti. Il canapulo impastato richiama le trame delle tele impiegate dall’azienda. Pavimenti e pareti del bagno sono rivestiti in ecocemento. L’ambiente del vecchio focolaio nasce dal desiderio della committenza di uno spazio di tipo tradizionale. Fabbricato con morali in castagno piallati a mano e arredo di recupero, le pareti in cartongesso sono trattate con velo rustico di calce e velature dai toni bruniti.
La sfida: trasformare quella che appariva come un’anonima villetta di campagna in un’autentica casa colonica toscana, non già per aggregazione di elementi tradizionali, bensì “per via di levare”. Vengono rimossi: 1_Gli sporti di gronda, facendo risaltare il profilo primario e archetipico della casa. 2_L’intonaco plastico delle murature, permettendo la riemersione del paramento lapideo. 3_I controsoffitti, facendo riapparire le solide travi in tronchi di castagno. Scarnificata la preesistenza, vengono stabilite due diverse modalità di intervento. La prima è mimetica e riguarda principalmente il massetto di copertura del pavimento radiante dove un cocciopesto levigato si fonde con le tonalità sabbiose della pietra arenaria dei muri. In continuità coloristica e materica sono anche i banconi della cucina e del bagno, entrambi caratterizzati da lavabi monolitici. La seconda modalità d’intervento, lavora invece per contrasto attraverso l’uso dell’acciaio grezzo. Un materiale che marca la nuova fase costruttiva, lasciando gli innesti ben leggibili rispetto agli elementi originari. Gli infissi tecnici in alluminio antracite lavorano pure per contrasto, tradendo un’anima tecnologica che è stata parte rilevante della ristrutturazione. Oltre a notevoli rinforzi strutturali antisismici, la casa colonica è infatti dotata di un sofisticato impianto termico che ibrida un termocamino con due pompe di calore alimentate dal campo fotovoltaico installato in copertura.
Ciò che è stato realizzato a Petriolo, e che oggi è visibile, tangibile per tutti i suoi visitatori , è una grande armonia tra storia e natura, in un difficile ma ben riuscito equilibrio. Questa armonia è stata raggiunta con l’apporto di idee, energie, risorse. Soltanto pochi anni fa l’intero complesso versava in condizioni disastrose. Le parti costruite erano pericolanti, in parte abbandonate, l’attività agricola quasi scomparsa. La sfida, possiamo oggi dire riuscita, è stata quella di aver creduto, già in quel momento, nella bellezza e nell’incanto del luogo, incanto che solo un occhio intelligente e romantico poteva intravedere. Dopodiché, il notevole e delicato restauro dell’intero complesso è stato portato avanti investendo non solo risorse economiche ma anche esperienze, professionalità, capacità, visioni. Tutti, architetti, paesaggisti, ingegneri, storici, sono stati chiamati ad unire le proprie idee e forze per centrare un risultato che sembrava una sfida insormontabile. Oggi, passeggiando tra gli edifici restaurati, perdendosi tra antiche pietre, aie in cotto, suggestivi affreschi, olivi e cipressi che incorniciano i nuovi segni dei vialetti, delle piscine, dei due ristoranti, del centro benessere, traguardando con lo sguardo in lontananza le Alpi Apuane, la torre di San Miniato, la piana verso la costa tirrenica, ci si può veramente sentire in equilibrio e riappropriarsi di una grande pace interiore di fronte a tanta armonia e bellezza.
Un fortino nelle campagne senesi, un’architettura povera ma massiccia nata dalla vita e dalla tradizione contadina, che si presentava come il tipico insieme di elementi tipologici dell’edilizia rurale toscana. L’intervento di riorganizzazione evita ogni tentativo di ricreare il falso: ripulito l’involucro esterno in pietra e mattoni, vengono introdotti con decisione elementi brutalisti in cemento armato a vista, dalle geometrie semplici ma caratterizzanti, corredati da infissi ed elementi funzionali in acciaio corten. L’architettura contemporanea non si nasconde, ma dialoga con i materiali tipici della tradizione toscana: cotto, pietra e legno si alternano al vetro, alle bruniture dei metalli e alle finiture del cemento. La rilettura dei prospetti ha permesso l’aumento dell’interazione interno-esterno, secondo una continua connessione con il paesaggio. In adiacenza alla casa principale, l’ex annesso agricolo viene rivisitato con una struttura in cemento e vetro a creare una piccola piscina coperta, un calidarium, foderato in travertino, che apre lo sguardo sui vigneti circostanti. Un sentiero tra ulivi, piante aromatiche e graminacee, raggiunge l’agriturismo, dove tradizione costruttiva locale, cromie del territorio e paesaggio si fondono attraverso il calore degli intonaci, il riordino delle aperture vetrate dei prospetti e le pensiline in corten e legno che disegnano una geometria di ombre su luoghi di sosta pavimentati in cotto.
Il complesso della Tenuta Casenuove è stato interamente ristrutturato per rispondere alle esigenze di un’azienda vinicola moderna. Il progetto di recupero tipologico e funzionale ha riportato la Tenuta a un elevato livello di funzionalità e ha ridefinito gli spazi esistenti. La Villa ha mantenuto la duplice funzione residenziale e di cantina vinicola. La porzione residenziale è stata trasformata in struttura di accoglienza di alta gamma, mentre la cantina è stata riorganizzata in zone destinate alla promozione e alla vendita del prodotto e all’invecchiamento del vino in tini di rovere. La Colonica, completamente restaurata, ospita oggi l’area produttiva e di stoccaggio – tinaia – e lo spazio per l’invecchiamento in tonneau – barricaia. Nei locali del piano superiore si trovano invece una serie di locali dedicati ai visitatori. La filosofia progettuale che ha guidato il design d’arredo coniuga tradizione e innovazione. Linee geometriche pure e profili essenziali scandiscono gli spazi della Villa e della Cantina, rendendo l’esperienza del visitatore unica in ogni spazio che si attraversa. Ciascuna forma ricalca e imita funzioni e immagini legate al vino. La scelta dei materiali si è fondata sull’esaltazione di elementi che caratterizzano la toscana e le sue risorse: legno di quercia e marmo. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle sistemazioni esterne, con il nuovo giardino all’italiana prospiciente la Colonica ed il completamento della parte a verde della Cappe
Il Cisternone è un’architettura idraulica ottocentesca che collega la cinta degli orti pubblici al centro storico medievale di Seggiano (1000 ab.). Abbandonato da molto tempo, è oggi la nuova porta simbolica al Museo della terra e dell’olivastra diffuso nell’intero centro storico: qui si celebra la parte più nascosta del paesaggio olivicolo: le “radici intelligenti” delle piante; la metafora ispirerà il nome della fondazione comunale creata per promuovere la vita sociale e culturale della comunità. L’edificio restaurato e i nuovi spazi di accesso al piede accolgono la presentazione dell’apparato radicale della più grande pianta al mondo coltivata in aeroponica, beneficiata dallo specchio d’acqua ricavato al fondo dell’ambiente e alimentata dai nutrienti dispensati lungo le pareti. Nella verticalità dello spazio e nella fitta penombra, visitatori e cittadini vivono un incontro multisensoriale con l’intelligenza vegetale, ecologica e resiliente. L’attività elettrica delle radici è monitorata dal Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università di Firenze guidato da Stefano Mancuso; i dati sono interpretati in tempo reale dall’installazione artistica di Gianandrea Gazzola che li traduce in forma di scrittura. La visita termina sulla piazzetta all’estradosso del volume idraulico dove tronco e chioma della pianta si integrano visivamente con gli uliveti circostanti. Il progetto del museo diffuso è stato esposto alla Biennale di Architettura di Venezia del 2018.
La riqualificazione del Centro Civico in via Giorgini rappresenta un’opportunità significativa per la comunità di San Vito, un quartiere della periferia di Lucca caratterizzato da una storia complessa e una vibrante diversità culturale. L’edificio, da tempo abbandonato, è stato trasformato in un moderno centro polifunzionale, rispondendo alle richieste della comunità e ai valori da essa espressi: inclusione sociale, sostenibilità e identità. L’intervento architettonico integra elementi innovativi e tecnologici, come una parete “bioclimatica” costituita da pannelli di alluminio colorati, che si aprono per dosare la luce interna, riflettendo l’impegno per l’efficienza energetica e il comfort interno. I colori dei pannelli, quelli a sud ispirati alla natura e quelli ad ovest rappresentativi della diversità culturale del quartiere, promuovono un ambiente inclusivo e accogliente. La forma dei pannelli rimanda le coste dei libri della biblioteca ospitata all’interno. Allo stesso tempo, il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi interni per accogliere una varietà di attività, dall’istruzione alla cultura, dalla socializzazione al relax e rendendo l’edificio più accessibile. La torre é il nuovo landmark del quartiere caratterizzato da alti fabbricati residenziali. Il Centro civico rappresenta un modello di rigenerazione urbana e inclusione sociale, offrendo un luogo di incontro e crescita per la cittadinanza e un luogo simbolico per l’identità del quartiere.
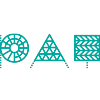
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix