

Il progetto converte Podere Cerreto, all’origine una torretta di avvistamento medievale, in un centro di innovazione e ricerca sull’energia e la sostenibilità, rivelando la memoria e le tracce dei suoi otto secoli di storia, e aggiungendovi un nuovo capitolo legato all’ambiente e al futuro, in intenso dialogo con quelli precedenti. La Via Francigena, che oggi lambisce la proprietà, attraversava originariamente il podere: questo elemento di memoria è stato rivelato tramite un tappeto lineare di pietre di recupero e un taglio sul muro di recinzione (due lame di corten e lastre in travertino) che punta verso il Castello di Monteriggioni e crea un nuovo accesso. Tutte le preesistenze sono state restaurate con il massimo rispetto, lavorando per analogia sull’esterno e per contrasto sugli interni, dove i materiali della tradizione sono valorizzati dalle aggiunte contemporanee. Il vano a tutta altezza attraversato dalla scala semiellittica, metafora dell’energia, fornisce luce dai lucernari verso gli ambienti circostanti, tramite delle perforazioni nelle murature cerchiate in ferro calamina, che si ripetono per tutto l’edificio connettendo gli ambienti di lavoro e riquadrando i paesaggi interni, cosi come le finestre riquadrano quelli esterni. I muri non portanti sono stati sostituiti da pareti in vetro, mentre a pavimento una resina materica colore della foglia dell’olivo attraversa tutti gli spazi, riquadra tappeti in cotto di recupero e crea elementi di arredo.
L’edificio oggetto di intervento, un villino in stile liberty degli anni trenta, presentava un elevato livello di degrado oltre alla presenza di alcune superfetazioni frutto del frazionamento in due distinte unità immobiliari avvenuta negli anni cinquanta. Il progetto propone di ridare dignità all’edificio tramite interventi puntuali di restauro conservativo e la rimozione della scala esterna. Con la realizzazione di una scala interna nella posizione originaria, viene ripristinato l’aspetto storico dell’immobile all’epoca della sua costruzione, mentre all’interno il fabbricato viene svuotato in modo tale da creare un unico open-space tra ingresso, salotto e cucina con il pavimento in resina che risulta inciso da inserti in legno a testimonianza e memoria delle porzioni murarie demolite. La scala, come già detto riportata nella posizione originaria, viene sospesa rispetto al mobile di partenza grazie a tiranti in ferro ancorati al solaio sovrastante, diventando da mobile d’arredo, collegamento funzionale con i piani sovrastanti.
Il Beauty Salon VG Make-Up Artist and Eye Designer nasce nel quartiere Cure di Firenze. Attraverso una corte interna si accede ad un luogo magico che rifacendosi all’identità artistica della committenza formatasi in Accademia e Teatro, si ispira alle scenografie teatrali anni’30 rivisitate con caratteri contemporanei. Questa mixité insieme all’estrema cura dei dettagli ha generato un’atmosfera calda, avvolgente che porta il visitatore in una dimensione esotica, onirica e raffinata, in un viaggio nella bellezza senza tempo. Lo spazio si articola in un ambiente principale dove la parete a specchi amplifica lo sguardo moltiplicando l’effetto avvolgente ed elegante dato da materiali preziosi, finiture in ottone brunito, dettagli oro su nero, colori scuri e caldi, superfici e illuminazione, essenze noce canaletto lucido e opaco, marmo di carrara, laccature e dettagli cannettati, velluto per i drappeggi ed alcuni arredi vintage originali. La copertura originale con capriata e travicelli è stata valorizzata in chiave contemporanea laccandola del colore blu verde delle pareti ed enfatizzandone volumi e ombre con l’illuminazione. L’armonia di forme spazio e materiali, l’eleganza di finiture e colori, l’immagine coordinata dei dettagli stimolano una partecipazione emotiva dello spazio, un’esperienza sensoriale e percettiva unica di bellezza nata dalla cura e dall’amore messo da tutti gli attori che hanno condiviso un approccio tailor made al fare bene insieme, all’eccellenza artigiana.
Il progetto riesuma un vecchio granaio dell’antica Fegghine, costruito con materiali ancestrali provenienti dalle rive dell’Arno e dalle vecchie fornaci. Svariate sono le volte presenti nel susseguirsi di stante, così come le altezze delle pareti che le sorreggono. L’intervento svolge un ruolo determinante nella valorizzazione degli antichi spazi. La nuova pavimentazione non vuole avvicinarsi all’esistente, in segno di rispetto. Tutto è staccato per permettere all’illuminazione di svolgere un ruolo fondamentale nella resa percettiva della storicità materica. Il moderno innesto che insegue la totalità delle stanze non vuole nascondersi, bensì mostrarsi, attraverso la sua lucentezza. La prima stanza è il risultato di un susseguirsi di necessità funzionali che hanno portato ad una totale asimmetria, delle superfici, delle pareti, dei soffitti, persino dell’accesso. In questo contatto ottico tra nuovo e antico, erompono quattro pietre porta botti, riesumate dagli stessi pavimenti preservati, dimostrazione delle innumerevoli funzioni succedute. Con la stessa delicatezza con la quale viene trattata la superficie muraria dell’intero spazio, l’espositore avvicina alle pareti illuminate le 964 bottiglie di vino, che seguono con una forma sinuosa e regolare gli archi creati dalla copertura. Centinaia di specchi riflettono la bellezza del pavimento originario, vagheggiando l’antico pozzo presente nella stanza adiacente. La bellezza è ciò che ha a che fare con la forma.
Massima estensione di superficie a parcheggio, massima superficie a magazzino, massima altezza. Il progetto del magazzino per autoricambi viene sviluppato, da una parte partendo da queste richieste programmatiche e dall’altra relazionandosi con un tessuto edilizio di anonimo e discontinuo. Viene elaborata un architettura semplice costituita da un volume di tre piani fuori terra e un ampio parcheggio interrato. La sagoma del fabbricato viene collocata al centro del lotto in modo da liberare gran parte della superficie esterna. Il disegno planimetrico segue quindi uno sviluppo per spazi concentrici costituiti da una successione di fasce funzionali: La prima fascia si sviluppa tutto intorno all’edificio ed è interamente dedicata a circolazione e parcheggio mentre la seconda, piantumata a verde, si estende fino al perimetro della parcella e costituisce un filtro naturale verso il contesto circostante. L’ edificio si mostra essenziale, articolato in due semplici volumi sovrapposti. In basso un basamento in continuità cromatica con il piazzale di asfalto e, su questo podio scuro e opaco, un volume di due livelli, alleggerito da un rivestimento in lamiera di acciaio microforata che riflette le tonalità dell’ambiente. I due “ordini” architettonici rappresentano le relative funzioni interne. Al piano terra spazio di accoglienza e uffici, ai piani superiori spazi destinati a magazzino. Completano il disegno delle facciate la scala e le bucature richieste dalle misure antincendio.
La casa di Sansepolcro è stata ideata come uno scrigno lapideo inciso e segnato dai serramenti in legno che si configurano come stratificazioni materiche. La scelta dei materiali è finalizzata ad accentuare un rapporto dialettico con il contesto ma senza rinunciare ad operazioni progettuali nette e radicali sulla volumetria. I serramenti in legno sono l’occasione per innestare nel volume dinamici e preziosi inserti materici, che producono vibrazioni e giochi di luce sempre differenti. L’interno risulta segnato dalla presenza forte della scala che si riverbera anche sul volume in pietra e disimpegna tutti gli ambienti, mentre la progettazione dell’arredo su misura definisce soluzioni integrate a forte carica plastica.
Un piccolo anonimo annesso rurale appoggiato sull’orlo di una paradisiaca terrazza naturale posizionata in faccia al migliore skyline di Volterra e dominante sulla val di Cecina. L’intenzione progettuale è stata quella di mettere in scena un vero e proprio manifesto programmatico con l’intento di poter affidare all’architettura autenticamente contemporanea e convintamente anti vernacolare, la mediazione tra contesto rurale e valore paesaggistico. Per fare ciò ci siamo dovuti concentrare sul rapporto tra forma e funzione facendo emergere le molte contraddizioni che una selvaggia agrituristizzazione della Toscana ha posto negli ultimi decenni, malintesi di carattere etico, culturale e tecnico. Perché continuare ad usare una forma insediativa pensata per lo più per assecondare i metodi del lavoro mezzadrile oggi scomparsi da decenni? Altro punto centrale del progetto il tentativo di superare il pretestuoso antagonismo tra bellezza e verità cercando di limitare i formalismi, affidandosi alla spigolosa tridimensionalità della geometria classica la più adatta alla luce del Tirreno che qui arriva a folate di scirocco. A scontrarsi con le linee tese e silenziose dei volumi, la pietra, pervasiva di ogni dimensione del progetto ed allestita con tecniche, pezzatura e significati diversi. La pietra con cui tutto si è compiuto in questo territorio, e che l’arato ha fatto emergere dalla terra come archeologia e che noi abbiamo lasciato nel giardino come monumento all’agricoltura che fu.
I lavori di restauro conservativo hanno interessato la facciata sul Corso e la copertura dell’aula retrostante. Per la facciata si trattava di intervenire sull’avanzato degrado del paramento murario, in buona parte a vista (pietra e laterizio) e con ricorsi orizzontali ad intonaco, da tempo soggetto a fenomeni di disgregazione e progressivo distacco di frammenti. Sono state utilizzate malte di calce naturale per la stilatura dei giunti che avessero le stesse caratteristiche materiche e cromatiche delle preesistenti, con inerti di granulometria adeguata, attraverso l’esecuzione di apposite campionature. Gli interventi sulla facciata sono stati completati con un restauro del portale che potremmo definire morfologico. Questo, nella fase di ricostruzione post-bellica, era rimasto incompleto, con l’intento successivo di ricollocare l’apparato decorativo lapideo, danneggiato dagli eventi bellici. Tale lettura ha portato ad una soluzione che da una lato accrescesse il decoro complessivo della facciata, banalizzato dall’utilizzo di materiali di scarsa qualità e da tessiture murarie scadenti e dall’altra permettesse di ridare leggibilità alla stessa morfologia del portale, rispettando il manufatto originale. L’intervento si è pertanto limitato ad un ripristino dell’intonaco sulle lesene che delimitano il portale, consentendo di migliorare la leggibilità, ridefinendo sul piano materico l’originale stacco fra il portale stesso e la superficie muraria a vista della facciata.
Realizzazione di piscina a servizio di agriturismo. La piscina è a servizio esclusivo degli ospiti dell’agriturismo, ed è stata collocata in uno spiazzo naturale presente lungo il pendio collinare, che si apre alla vista verso il mare sul golfo di Talamone. Sfruttando la presenza degli elementi arbustivi ed arborei e scegliendo materiali propri dell’ambito, quali muro con pietra facciavista sul lato a monte della piscina, pavimentazione impermeabile e antisdrucciolevole effetto pietra, e il bordo a sfioro su tre lati, è stato raggiunto l’intento di ottenere un’ottima armonizzazione nell’ambito paesaggistico, creando la sensazione di una finestra affacciata sul mare. L’area intorno alla piscina è stata “recintata” con un gioco di siepi arbustive alternate da recinzione alla maremmana per creare la necessaria barriera di protezione richiesta dalle normative di settore, ed arricchire la sensazione di essere immersi nella natura. La colorazione interna della vasca è stata scelta in tonalità neutra, in effetto pietra, per richiamare la naturalità degli esterni. Il vano tecnico ha trovato alloggiamento in un vano interrato posto a monte, con accesso da botola. L’accesso all’area piscina avviene da una serie di percorsi ricavati nel pendio modellando lo stesso con gradini naturali in terra e pietra e con rampa in mattonellata adatta anche ai disabili.
Il Piano Nobile di Palazzo Capponi alle Rovinate ospita la sede della Stanford University da circa dieci anni. Il progetto di ampliamento, concepito durante il primo lockdown, recepisce il tema della flessibilità richiesto inizialmente dalla Committenza allargandolo al tema delle distanze fisiche necessarie per garantire il corretto svolgimento in sede della didattica. Ecco quindi che gli ambienti, caratterizzati da altezze importanti e soffitti affrescati, diventano il contenitore da rispettare e in cui inserire arredi e dotazioni impiantistiche necessarie. Gli arredi sono concepiti come moduli da assemblare e collocare a seconda delle esigenze didattiche, con la massima flessibilità. Arredi leggeri che richiamano il tema dei banchi di scuola e le cui forme spezzate ne evidenziano la modularità e le varie configurazioni. A partire dagli affreschi presenti, restaurati nell’ambito dell’intervento, sono stati individuati i temi cromatici che hanno dettato la scelta progettuale. La teoria dei 3 colori ha permesso di condurre la continuità tra i vari ambienti, garantita anche dalla presenza di un tappeto continuo in appoggio sagomato sul perimetro, funzionale alla preservazione dei pavimenti storici decorati presenti nel Palazzo. Il “fil rouge” formale è dato dal tema ricorrente della linea spezzata che consente di leggere con facilità gli arredi come elementi da accoppiare e posizionare in funzione delle esigenze didattiche.
Il progetto è nato per rispondere alla richiesta di un centro di riabilitazione per l’handicap fisico e mentale, per l’autismo e per un supporto fisioterapico aperto alla città. Nuovi corpi di fabbrica, articolati e divisi per funzioni diverse, sono collegati al vecchio edificio, ampliato e ristrutturato, da un percorso coperto che si apre su un parco a verde attrezzato: “metronomo” che scandisce il tempo della permanenza. Il nuovo edificio, a pianta ellittica, con il corpo in mattoni ed un percorso a due livelli coperto da una struttura in metallo e vetro, ricorda il gesto del seminatore quando il braccio allarga il movimento e spande il seme per raccontare al mondo il frutto che nascerà; ed anche nel suo ingresso a forma tronco-conica, i simboli si susseguono e i materiali si sommano per raccontare, senza nasconderli, coloro che vivono dentro e devono sentirsi proiettati in quel mondo che spesso viene loro negato. All’interno, aule/laboratorio per lo sviluppo di capacità operativo-sensoriali, un auditorium, una nuova aula liturgica per rispondere anche alle esigenze del quartiere e della città. Nuovo e antico convivono, anche nel vecchio edificio ristrutturato, memoria e permanenza della storia, che, con la sua quinta in mattoni (materiale unificante di tutto l’intervento), curvata e possente, offre con i suoi vuoti, da dentro e da fuori, scorci, quadri e nuove prospettive. Un’avventura non facile, vissuta con il mio collega e collaboratore arch. Riccardo Lombardi.
Un appartamento degli anni ’50, luminoso e con spazi generosi la cui organizzazione non rispecchiava le esigenze dei nuovi inquilini. I clienti esigevano un intervento radicale ed il cambio di funzione di praticamente tutti gli ambienti; il programma, preciso e complesso (cucina aperta su zona giorno separabile all’occorrenza, grande zona giorno, camera degli ospiti, un bagno in più, ingresso luminoso e spazio per organizzare) necessitava un completo ripensamento degli spazi. Le caratteristiche costruttive permettevano un certo grado di libertà nella riconfigurazione dello spazio senza compromettere la struttura. Il progetto si basa su due elementi: La realizzazione di una zona giorno unica su cui affaccia la cucina e la riconfigurazione della zona notte. Per fare questo, abbiamo deciso di realizzare un unico grande intervento unitario, un elemento funzionale e distributivo allo stesso tempo. Le partizioni del corridoio della zona notte sono state sostituite da profondi armadi; porte e ante, senza soluzione di continuità, definiscono un ambiente distributivo e funzionale allo stesso tempo. La transizione tra zona giorno e zona notte è determinata, oltre che da una porta scorrevole, da un cambio materico: le ante in doghe di legno naturale invece che porte laccate. La cucina, nella prima parte della zona notte, è divisa dal corridoio solo da un armadio e dalla zona giorno da tre grandi pannelli scorrevoli che danno continuità materica al corridoio.
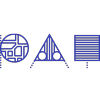
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix