

Un fortino nelle campagne senesi, un’architettura povera ma massiccia nata dalla vita e dalla tradizione contadina, che si presentava come il tipico insieme di elementi tipologici dell’edilizia rurale toscana. L’intervento di riorganizzazione evita ogni tentativo di ricreare il falso: ripulito l’involucro esterno in pietra e mattoni, vengono introdotti con decisione elementi brutalisti in cemento armato a vista, dalle geometrie semplici ma caratterizzanti, corredati da infissi ed elementi funzionali in acciaio corten. L’architettura contemporanea non si nasconde, ma dialoga con i materiali tipici della tradizione toscana: cotto, pietra e legno si alternano al vetro, alle bruniture dei metalli e alle finiture del cemento. La rilettura dei prospetti ha permesso l’aumento dell’interazione interno-esterno, secondo una continua connessione con il paesaggio. In adiacenza alla casa principale, l’ex annesso agricolo viene rivisitato con una struttura in cemento e vetro a creare una piccola piscina coperta, un calidarium, foderato in travertino, che apre lo sguardo sui vigneti circostanti. Un sentiero tra ulivi, piante aromatiche e graminacee, raggiunge l’agriturismo, dove tradizione costruttiva locale, cromie del territorio e paesaggio si fondono attraverso il calore degli intonaci, il riordino delle aperture vetrate dei prospetti e le pensiline in corten e legno che disegnano una geometria di ombre su luoghi di sosta pavimentati in cotto.
La nuova sede della Farmacia Martini a San Romano, Pisa, trova spazio negli ambienti di una vecchia scuderia annessa ad una villa signorile, poi officina di autoriparazioni, alle porte del centro abitato. Si sviluppa su due livelli per circa 280mq al piano terra e 100mq al piano primo. Con il progetto di allestimento abbiamo voluto rovesciare le abitudini consolidate che vedono gli ambienti delle farmacie spesso allestiti in modo molto “asettico”, “ospedaliero”, frutto di progettazioni spesso delegate ad allestitori che forniscono arredi preconfezionati per tali funzioni. Abbiamo pensato un ambiente che fosse al tempo stesso contenitore di medicinali, con una gestione del magazzino ipertecnologica e un luogo accogliente, esso stesso cura per lo spirito. Questo pensiero si traduce in spazi dove la luce entra generosa nell’ambiente principale di doppia altezza, allestito con colori chiari attraverso l’uso del cemento a vista e del legno di rovere naturale. All’interno risulta protagonista la vista, filtrata da una vetrata, di un olivo secolare, posizionato al livello superiore in una piccola corte ottenuta attraverso una apertura nella copertura. Oltre a spazi dedicati alla vendita di medicinali, nella farmacia trovano collocazione un laboratorio galenico ed ambienti per consulenze, visite e trattamenti.
Quest’opera tenta di restituire decoro e significato a architetture indispensabili al nostro vivere. L’idea progettuale nasce dalle emergenze paesaggistiche proprie dell’area, lungo la Via Fossa Ducaria, dominata dalla vicinanza dell’argine del Fiume Arno. Conformazione del terreno, vegetazione ed elemento acqua sono protagonisti di un’esperienza progettuale tesa alla ricerca di valore estetico e qualitativo e di integrazione ambientale. Gradevolezza e sobrietà sono alla base della definizione di spazi, linee, forme e colori. Ci si muove perseguendo il minor impatto paesaggistico: visibilità e percezione sono mitigate dal parziale effetto schermante e dalla generale ricucitura tra l’uso agricolo, i soprassuoli arborei, la vegetazione ripariale ed il margine stradale. Dell’elemento Verde si enfatizza la tridimensionalità. Un movimento tellurico profondo anima il terreno; le piantumazioni, tipiche della golena, definiscono le scarpate; il prato si solleva come in equilibrio con il leggero declivio, fino a raccordarsi nuovamente con la strada vicina. In questa reinterpretazione e riprogettazione del Verde si inserisce il costruito: l’area di servizio (pavimentazione in asfalto ecologico colorato e cemento) l’edificio di servizio al gestore e alle utenze i manufatti per la distribuzione di carburante il “recinto-canneto” della cabina del gas metano le pensiline disegnate a suggerire scheletri di alberature Tutti questi “oggetti” sono voluti in acciaio verniciato
L’idea del progetto nasce da una riflessione sui modi di studiare e di fare ricerca in un momento storico in cui le tecnologie di trasmissione ed edizione digitale invitano ad una reinterpretazione degli spazi tradizionali dedicati alle biblioteche. L’intervento si sviluppa su tutti e sei i piani dell’edificio, per una superficie totale di circa 2000 m2. Scopo primario del progetto è proporre un insieme di soluzioni d’arredo reiterabili nelle varie stanze del palazzo in modo da creare una continuità linguistica riconoscibile dagli utenti della scuola. Il progetto cerca di ‘pulire’ le stanze, sature di ostacoli fisici e visuali che impediscono la godibilità funzionale e inibiscono la fruizione distributiva dello spazio. L’esigenza principale è di ricondurre in una trama di pochi segni e di spazi, facilmente identificabili, gli ambiti bibliotecari interessati dal progetto, favorendone la cucitura e l’integrazione con l’articolato impianto planimetrico dell’edificio storico. L’architettura degli interni viene concepita come organica alla forma dell’edificio, in modo da evitare al visitatore la sensazione di trovarsi di fronte ad un intervento di semplice collocazione degli arredi. L’idea principale quindi si muove attorno all’esigenza di creare l’identità della nuova biblioteca attraverso i due elementi principali dell’arredo: le scaffalature librarie, pensate come fondali alle pareti, e gli arredi, pensati come delle isole, elementi riconoscibili ed ordinatori dello spazio.
Il complesso della Tenuta Casenuove è stato interamente ristrutturato per rispondere alle esigenze di un’azienda vinicola moderna. Il progetto di recupero tipologico e funzionale ha riportato la Tenuta a un elevato livello di funzionalità e ha ridefinito gli spazi esistenti. La Villa ha mantenuto la duplice funzione residenziale e di cantina vinicola. La porzione residenziale è stata trasformata in struttura di accoglienza di alta gamma, mentre la cantina è stata riorganizzata in zone destinate alla promozione e alla vendita del prodotto e all’invecchiamento del vino in tini di rovere. La Colonica, completamente restaurata, ospita oggi l’area produttiva e di stoccaggio – tinaia – e lo spazio per l’invecchiamento in tonneau – barricaia. Nei locali del piano superiore si trovano invece una serie di locali dedicati ai visitatori. La filosofia progettuale che ha guidato il design d’arredo coniuga tradizione e innovazione. Linee geometriche pure e profili essenziali scandiscono gli spazi della Villa e della Cantina, rendendo l’esperienza del visitatore unica in ogni spazio che si attraversa. Ciascuna forma ricalca e imita funzioni e immagini legate al vino. La scelta dei materiali si è fondata sull’esaltazione di elementi che caratterizzano la toscana e le sue risorse: legno di quercia e marmo. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle sistemazioni esterne, con il nuovo giardino all’italiana prospiciente la Colonica ed il completamento della parte a verde della Cappe
L’intervento prevede la realizzazione di due fabbricati, ispirati dal complesso residenziale Heuberg di Vienna (Adolf Loos), sfalsati tra di loro sia trasversalmente che in altezza, configurati come due masse monolitiche scolpite secondo una serie di facce e piani inclinati e adagiati sull’orografia dell’area per ottenere una Siedlungen moderna. Ogni fabbricato è composto da un piano seminterrato adibito a parcheggi, cantine e locali tecnici condominiali e due piani fuori terra destinati a residenziale. Una scala interna collega direttamente la quota dei parcheggi con le residenze soprastanti. Agli appartamenti si accede dai percorsi pedonali alternati a giardini privati a monte dei fabbricati, per poi trovare il vano scala in corrispondenza dello scarto della facciata. Al fine di assecondare l’andamento naturale del terreno, ogni stecca scarta di circa 70 cm verso il basso in corrispondenza del vano scala, ne deriva che in facciata la scansione delle aperture varia in altezza assecondando la quota di imposta. La stessa lavorazione dell’intradosso tende a conferire quella sensazione di massa scolpita che volevamo ottenere. L’elemento che rompe l’apparente rigidità dei volumi è il sistema delle aperture in facciata, ora elementi lavorati per estrusione, ora per sottrazione, non sono altro che la cornice di quadri naturali già esistenti. Il tetto è risolto con un sistema di falde, di colmi e di linee di gronda variabili tali da conferire alla copertura un carattere scultoreo.
Il progetto de i Vivai al Parugiano si ispira alla storia del nucleo edilizio e al suo rapporto col territorio. Nel tempo l’aggregato rurale ha svolto anche funzione di produzione di piante per la vicina villa Pazzi. La sistemazione degli spazi esterni salvaguarda gli elementi relitti della matrice agraria armonizzandoli con tale peculiarità per connotare il complesso e inserirlo nel paesaggio. Se il progetto architettonico, elaborato dallo studio b-arch, reinterpreta l’agglomerato rurale, il progetto di paesaggio fa sì che gli spazi aperti si relazionino a edifici e contesto in modo da garantire permeabilità visiva e continuità ecologica. Lungo il perimetro un fronte vegetale permeabile consente il dialogo con i vicini campi e le colline ad eccezione del lato sud dove un lembo di bosco planiziale funge da barriera verso la viabilità. La trama principale dei percorsi rispetta la tessitura agraria; la vegetazione arborea è costituita da alberi tipici del contesto paesaggistico; le bordure di perenni e graminacee attorno agli edifici, composte con ritmo e serialità nella parte interna, ai margini acquistano informalità e naturalità per dialogare con prati e coltivazioni di grano. Varie le soluzioni progettuali mirate alla sostenibilità: percorsi pedonali e carrabili quasi totalmente drenanti, impianto d’illuminazione essenziale e anti-inquinamento luminoso, tappeto erboso e specie vegetali a ridotto fabbisogno idrico, aree di compensazione idraulica che ospitano prati fioriti
Il Cisternone è un’architettura idraulica ottocentesca che collega la cinta degli orti pubblici al centro storico medievale di Seggiano (1000 ab.). Abbandonato da molto tempo, è oggi la nuova porta simbolica al Museo della terra e dell’olivastra diffuso nell’intero centro storico: qui si celebra la parte più nascosta del paesaggio olivicolo: le “radici intelligenti” delle piante; la metafora ispirerà il nome della fondazione comunale creata per promuovere la vita sociale e culturale della comunità. L’edificio restaurato e i nuovi spazi di accesso al piede accolgono la presentazione dell’apparato radicale della più grande pianta al mondo coltivata in aeroponica, beneficiata dallo specchio d’acqua ricavato al fondo dell’ambiente e alimentata dai nutrienti dispensati lungo le pareti. Nella verticalità dello spazio e nella fitta penombra, visitatori e cittadini vivono un incontro multisensoriale con l’intelligenza vegetale, ecologica e resiliente. L’attività elettrica delle radici è monitorata dal Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università di Firenze guidato da Stefano Mancuso; i dati sono interpretati in tempo reale dall’installazione artistica di Gianandrea Gazzola che li traduce in forma di scrittura. La visita termina sulla piazzetta all’estradosso del volume idraulico dove tronco e chioma della pianta si integrano visivamente con gli uliveti circostanti. Il progetto del museo diffuso è stato esposto alla Biennale di Architettura di Venezia del 2018.
La nuova copertura per l’area del mercato di Piazza delle Cure (che rientra nell’intervento più generale di riqualificazione della Piazza a cura del Comune di Firenze) ha il duplice obiettivo di ospitare il mercato ortofrutticolo e di creare un luogo iconico per l’aggregazione dei cittadini. L’Ex-Acquedotto è stato demolito ricostruendone la facciata fino al marcapiano, mantenendo così i confini della Piazza e offrendo un solido sostegno strutturale alla copertura. Nell’intento di unire sia un linguaggio architettonico contemporaneo che una progettazione contestualizzata, abbiamo osservato che questa piazza si trova fra il centro di Firenze e le colline di Fiesole, che ispirarono a Gabriele D’Annunzio i versi de “La sera fiesolana”: “… e ti dirò per qual segreto / le colline sui limpidi orizzonti / s’incurvino come labbra che un divieto / chiuda, e perché la volontà di dire / le faccia belle / oltre ogni uman disire…”. Da questa ispirazione nasce il nostro concept di progetto: un rettangolo con il perimetro orizzontale, suddiviso in dieci fasce, otto delle quali si incurvano, citando lo skyline fiesolano. Le intercapedini formate dalle geometrie variabili consentono una illuminazione naturale. Nel perimetro (40 x 24.72), nei prospetti formati alle estremità dalle coppie di travi e nel ritmo fra pieno e vuoto dai travetti del soffitto è stata applicata (in linea di continuità con vari edifici fiorentini del tardo Medioevo e del Rinascimento) la Proporzione Aurea.
La proposta progettuale per la nuova sala espositiva di TTT individua tre elementi fondanti: la piazza, il portico, il vecchio focolaio. La piazza è definita dalla luce zenitale introdotta attraverso due lucernari a forma di piramidi tronche. I diffusori per l’aerazione e le linee dei proiettori luminosi, sono alloggiati nelle intercapedini tra controsoffitto e pareti, affidando al controsoffitto la funzione di macchina impiantistica. Al centro della sala è posizionato un setto contenitivo ancora in produzione al tempo degli scatti fotografici. Le collezioni, in precedenza appese alle pareti, sono state posizionate dietro una controparete. Qui, tramite tablet, è azionato un rullo meccanizzato che identifica il pezzo richiesto presentandolo in prossimità del varco. Il portico, delimitato da telai pivottanti, presenta proporzioni diverse dalla sala. Nella galleria l’illuminazione è puntuale, diretta ai canovacci incorniciati e posizionati a muro su binario scorrevole in ferro nero calamita. Pareti e arredi sono rivestiti con intonaco di calcecanapa con proprietà termo-isolanti. Il canapulo impastato richiama le trame delle tele impiegate dall’azienda. Pavimenti e pareti del bagno sono rivestiti in ecocemento. L’ambiente del vecchio focolaio nasce dal desiderio della committenza di uno spazio di tipo tradizionale. Fabbricato con morali in castagno piallati a mano e arredo di recupero, le pareti in cartongesso sono trattate con velo rustico di calce e velature dai toni bruniti.
La riqualificazione del Centro Civico in via Giorgini rappresenta un’opportunità significativa per la comunità di San Vito, un quartiere della periferia di Lucca caratterizzato da una storia complessa e una vibrante diversità culturale. L’edificio, da tempo abbandonato, è stato trasformato in un moderno centro polifunzionale, rispondendo alle richieste della comunità e ai valori da essa espressi: inclusione sociale, sostenibilità e identità. L’intervento architettonico integra elementi innovativi e tecnologici, come una parete “bioclimatica” costituita da pannelli di alluminio colorati, che si aprono per dosare la luce interna, riflettendo l’impegno per l’efficienza energetica e il comfort interno. I colori dei pannelli, quelli a sud ispirati alla natura e quelli ad ovest rappresentativi della diversità culturale del quartiere, promuovono un ambiente inclusivo e accogliente. La forma dei pannelli rimanda le coste dei libri della biblioteca ospitata all’interno. Allo stesso tempo, il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi interni per accogliere una varietà di attività, dall’istruzione alla cultura, dalla socializzazione al relax e rendendo l’edificio più accessibile. La torre é il nuovo landmark del quartiere caratterizzato da alti fabbricati residenziali. Il Centro civico rappresenta un modello di rigenerazione urbana e inclusione sociale, offrendo un luogo di incontro e crescita per la cittadinanza e un luogo simbolico per l’identità del quartiere.
I VIVAI AL PARUGIANO è un complesso di edifici che include un hotel, un ristorante, una piscina ed una piccola spa. Un progetto che unisce due grandi temi: realizzazione di una nuova architettura e recupero e restauro di una colonica rurale ottocentesca. La sfida risiedeva proprio nel combinare armoniosamente architettura contemporanea e tradizionale. Per affrontare questa sfida abbiamo scelto di adottare materiali e tecnologie rurali, quali la pietra, il mattone, il ferro, e di declinarli in un linguaggio e in un design contemporaneo e minimale. Il fil-rouge che unisce tutto il complesso è il “mandolato”, tecnica costruttiva storicamente molto diffusa in quest’area nella costruzione dei fienili, adattata ed applicata a tutte le superfici vetrate, finestre e recinzioni. Questa nuova ed antica membrana vibrante, fatta di mattoni artigianali assemblati a mano, filtra la luce, conferisce qualità climatiche ed emotive agli spazi interni ed offre un’inedita percezione del paesaggio, mentre contribuisce a definire l’identità visiva dell’architettura e dei volumi, nuovi ed antichi. Situati in una zona rurale nel comune di Montemurlo, I Vivai al Parugiano sono il risultato di un percorso progettuale che parte dall’architettura e si completa nel design degli interni, degli arredi, dei sistemi di illuminazione e dei complementi. Questo progetto incarna appieno l’identità dello studio b-arch, che integra progettazione architettonica ed interior-design in modo completo e profondo.
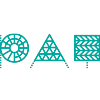
2018 - 2022 © Tutti i diritti riservati. Fondazione Architetti Firenze, Via Valfonda 1/a, 50123 Firenze
Cod.Fisc./P Iva 06309990486 | Privacy Policy | Cookie Policy
Design by D'Apostrophe | Developed by Shambix